- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
La musica è uno degli elementi fondamentali dei film firmati dal grande regista Stanley Kubrick. Strumento centrale, che accompagna il racconta e sottolinea i momenti ‘sacri’ del film. Tutti ricorderanno il “Ludovico Van” di Alex che celebra la sua ultraviolenza in Arancia Meccanica, o lo swing dolce che sancisce la chiusura de Il dottor Stranamore.
Immagine e suono danno vita a un connubio unico nei film di Kubrick, raccontano a loro volta sentimenti e danno vita a situazioni, stravolgendo tutto ciò che è convenzionale. La musica è utilizzata come qualcosa che taglia in due i personaggi e svela quello che c’è dietro. E la musica è l’elemento ispiratore di Ears Wide Shut, idea nata un paio di anni fa tra quattro amici cinefili e cultori di Stanley Kubrick: Stefano Senni, Mauro Campobasso, Mauro Manzoni, Pino Bruni.
Tra chiacchiere a ruota libera, discussioni appassionate e giochi dell’immaginazione maturò l’idea di realizzare un montaggio di sequenze dai film di Kubrick per musicarlo con una nuova colonna sonora: il tutto in un concerto multimediale. Il progetto è stato prodotto dalla “Società del teatro e della musica Luigi Barbara” di Pescara, nell’ambito della stagione 2008-2009. Un’idea nata anche sulla scia di una mostra su Kubrick curata a Pescara da Pino Bruni, che aveva fatto incontrare i musicisti con la moglie del registra, Christiane Kubrick e il cognato Jan Harlan. “D’altra parte - dice Stefano Senni - questa prossimità al mondo kubrickiano, la vivevamo già grazie a Emilio d’Alessandro, uno degli storici collaboratori del regista, cui da qualche tempo ci legava e ancora ci lega una profonda e affettuosa amicizia.
Il jazz che accompagna i film (ovviamente muti) è diventato una sorta di sottogenere fortunato. Ma con Kubrick è un’altra storia. Anzitutto si tratta di cinema sonoro: il montaggio, forzatamente senza audio per consentire l’esecuzione della nuova musica, va a eliminare un elemento essenziale dell’opera, che può uscirne snaturata e impoverita”.
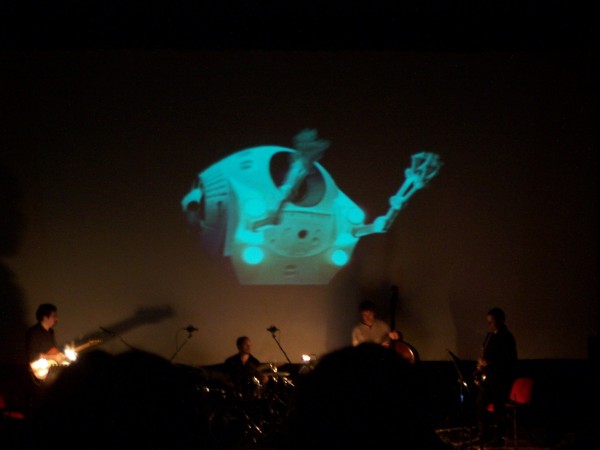 Il concerto, penultimo evento della rassegna di Visioni in Musica, utilizza quindi due linguaggi: quello della musica e quello delle immagini che, mute, scorrono sullo schermo. Si guarda e si ascolta, dunque, e lo si fa immergendosi totalmente in un montaggio sapiente che riesce bene a rappresentare tutti i momenti fondamentali del percorso autoriale di Kubrick e in una musica che sa innovare pezzi conosciuti, dando qualcosa in più.
Il concerto, penultimo evento della rassegna di Visioni in Musica, utilizza quindi due linguaggi: quello della musica e quello delle immagini che, mute, scorrono sullo schermo. Si guarda e si ascolta, dunque, e lo si fa immergendosi totalmente in un montaggio sapiente che riesce bene a rappresentare tutti i momenti fondamentali del percorso autoriale di Kubrick e in una musica che sa innovare pezzi conosciuti, dando qualcosa in più.
Dai celebri brani classici come il Rossini di “Arancia meccanica” o lo Schubert di “Barry Lyndon”, alle canzoncine stile “I Want to marry a lighthouse keeper” che esce da una radiolina accesa nella casa dei genitori di Alex in Arancia Meccanica, Kubrick inventa un nuovo modo di mettere insieme cinema e musica. Non solo accompagnamento puro e semplice, ma parte integrante e fondamentale della narrazione.
Le danze irlandesi di Barry Lyndon, i pezzi ballabili anni Sessanta in Lolita, il romantico tema d’amore Spartacus e standard come Blame it on my Youth in Eyes Wide Shut sono tutti elementi ispiratori per il quartetto. “Il repertorio kubrickiano preso nel suo insieme può offrirsi quale punto di partenza per nuove musiche - raccolto, smontato, rielaborato - senza che questo stravolga l’originale rapporto con i film. È con questo spirito che è stato creato “Ears Wide Shut”, sviluppato musicalmente sulla traccia visiva montata per associazioni iconografiche e tematiche da Pino Bruni”, aggiunge Senni.
L’esperimento probabilmente sarebbe piaciuto al grande regista americano, che amava la sperimentazione e per secondo cui “Ci sono certe aree del pensiero e della realtà - o dell'irrealtà e dei desideri - che sono chiaramente inaccessibili alle parole. La musica può accedere a queste aree”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Luca Mazzucato
di Luca Mazzucato
NEW YORK. Lo scorrere frenetico delle nostre vite 2.0 raramente ci lascia spazio per apprezzare i dettagli. Tra una ricerca su Google e un update del profilo su Facebook, lanciare un twit con il menù del nostro brunch è spossante. In un certo senso, l'epidemia del Ventunesimo secolo si chiama ADHD, deficit di attenzione e iperattività. Siamo passati dall'era della information technology alla TMI, o come direbbero gli Americani - Too Much Information!
D'altra parte ci sono alcune discipline per cui la cura dei dettagli, persino i più minuscoli, è essenziale. Per esempio la creazione artistica. Ma non ne abbiamo proprio il tempo, dobbiamo controllare le nostre email! In realtà l'arte si presta, come tutte le attività umane, ad un apprezzamento superficiale dalla parte del fruitore... ma può l'artista permettersi di essere approssimativo?
“L'ossessione per i dettagli è nient'altro che Manierismo”, dice Taliesin, pseudonimo curioso per il portavoce dell'Immediatismo. Si tratta di un nuovo movimento artistico il cui motto “L'Italia è morta? Viva l'Italia!” fa la sua prima comparsa all'ArtExpo 2012, in esibizione al Molo 92 a Manhattan. Le opere in mostra, a quanto pare, possono vantare l'apprezzamento del pubblico: Taliesin ha venduto vari quadri già nei primi due giorni della mostra; un risultato non comune, specialmente in questi tempi di crisi nera per il mercato dell'arte.
Un'ottima strategia promozionale è stata senz'altro la scelta di tenere il listino a un livello abbordabile, in confronto ai prezzi esorbitanti della maggior parte degli altri artisti, per quanto emergenti, che spesso raggiungevano le decine di migliaia di dollari. Con il record esorbitante di quattrocentomila dollari per una strutture metalliche sferiche di uno scultore italiano.
Fondatore e artista del movimento dell'Immediatismo, Taliesin è il tipico artista in grado di restare a galla nel tempestoso mercato del lavoro: architetto, scultore, pittore, graphic designer - di tutto un po'. Per arrivare alla quarta settimana bisogna proprio sapersi arrangiare. Taliesin ha portato con sé oltreoceano i suoi attrezzi di artista e fa mostra dello strumento che ha costruito per gocciolare il colore sulle tele. Una via di mezzo tra un catetere e una siringa da pasticciere.
 Artisticamente parlando, in cosa consiste questa nuova corrente? Potete trovare sul sito immediatismo.it le immagini dei dipinti in mostra all'ArtExpo. Potremmo definirla hipster art: così laconica da sembrare ironica. Uno strano incrocio tra una versione embrionale del Futurismo e l'ovvia ispirazione del gocciolamento sulla tela alla Pollock, scremato di ogni dettaglio barocco.
Artisticamente parlando, in cosa consiste questa nuova corrente? Potete trovare sul sito immediatismo.it le immagini dei dipinti in mostra all'ArtExpo. Potremmo definirla hipster art: così laconica da sembrare ironica. Uno strano incrocio tra una versione embrionale del Futurismo e l'ovvia ispirazione del gocciolamento sulla tela alla Pollock, scremato di ogni dettaglio barocco.
Ma il tratto distintivo è nella realizzazione, nel metodo: è arte istantanea. Una creazione al primo colpo, che in un battere di ciglia ci trasmette il messaggio nudo e crudo, senza fronzoli né dettagli. Vi fate un'idea dell'opera con una breve occhiata, per poi tornare a spedire sms ai vostri amici sulla mostra che state visitando.
In un certo senso, l'Immediatismo è l'incarnazione artistica di un curioso effetto noto agli psicologi sotto il nome di peak shift. Quando pensiamo con l'occhio della mente ad una forma complicata, come per esempio ad un volto, in realtà ci basta richiamare alla memoria soltanto i suoi tratti più salienti: occhi, bocca. Se poi veniamo messi di fronte ad uno smiley, quelle faccette rotonde gialle e nere, capiamo istantaneamente che si tratta di una faccia, anche se la somiglianza pixel per pixel tra uno smiley e un volto vero non potrebbe essere più distante.
Ai nostri occhi, il messaggio contenuto nello smiley e persino più pregnante di una fotografia del viso di qualcuno. Se non altro, gli Immediatisti hanno un pregio immediato: bastano pochi secondi per apprezzare la loro opera. Invece di fissare per ore una tela alla ricerca del dettaglio cruciale. Come direbbe Andrea Pazienza, il segno si decifra, l'apparenza non si decifra. E siccome siamo tutti molto impegnati di questi tempi, é una novità che certamente riscuoterà consensi...
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
BERLINO. Una “prima volta” di grande successo per i Subsonica a Berlino, approdati il 19 marzo allo storico club S036 di Kreuzberg nell’ambito di un tour europeo che li porterà poi a Londra, Barcellona e Parigi. Nati a Torino nel 1996, i Subsonica sono forse il gruppo più rappresentativo dell’alternative rock italiano: in 15 anni di storia e 6 album prodotti hanno sempre saputo mantenere il proprio stile senza rinunciare a una decisa evoluzione musicale, e senza mai deludere i propri fan. L’ultimo album, Eden (2011), li ha portati a condire basi di rock melodico con elementi dub, drum’n bass, industrial e reggae, per un mix musicale che ha riscosso grande popolarità anche fuori dal Belpaese.
La band ama presentarsi come cresciuta “sull’onda dell'elettronica, dei raduni semiclandestini organizzati nelle fabbriche dismesse e delle notti affollate ad alto volume lungo il fiume sotto piazza Vittorio”, a Torino. A questa descrizione possiamo solo aggiungere che il progetto Subsonica ha unito gli esponenti più validi della scena musicale alternativa torinese degli anni ‘90, un particolare che spesso viene omesso dalla band, forse per modestia. A Berlino abbiamo incontrato Boosta, il tastierista dei Subsonica, che accompagna il gruppo fin dagli esordi.
Altrenotizie: Eden (2011), il vostro ultimo album, ha preso forse una direzione più elettronica rispetto agli altri, avete provato a fare un esperimento oppure avete semplicemente seguito un’emozione?
Boosta: Eden è semplicemente quello che è venuto fuori. Arriviamo da Eclissi (2007), un disco molto “di flusso” e poco “di canzoni”: direi che forse è stato quello il progetto più elettronico. Con Eden è stata semplicemente la voglia di ricominciare insieme con un disco “di canzoni” che si differenziasse da quello precedente, c’è stata anche una virata nei confronti del tema, che si è infatti discostato dall’ultimo. Eclissi è un disco assolutamente più cupo, un po’ premonitore di quello che sarebbe poi avvenuto in questi anni appena trascorsi, e cioè una specie di rinascita per noi: e per rinascita intendo il modo di guadagnarci una sorta di paradiso personale in cui ognuno possa cominciare a costruire un benessere che parta dalle persone che ha a fianco. E in particolare sto parlando del gruppo, quindi questo nostro stare di nuovo insieme dopo 4 anni: ricominciare a lavorare insieme e ricreare i rapporti per me è stata una bella soddisfazione. Musicalmente siamo un gruppo di 5 persone che fanno la loro esperienza e si ritrovano insieme a scrivere musica.
Altrenotizie: Sanremo, festival della canzone italiana. Voi avete scelto di partecipare nel 2000 con una bella canzone, giovane, forse un po’ fuori dalle righe rispetto allo stile dell’evento stesso, perché vi siete lanciati in questa “sfida”?
Boosta: Perché è stato l’unico modo per andarci, non abbiamo scelto di proporre una canzone fuori dalle righe, ma abbiamo scelto di portare una canzone che rappresentasse i Subsonica, quindi se, come è successo, l’organizzazione Sanremo ha voluto il nostro gruppo, si suppone ci abbia voluto perché facessimo la nostra musica.
 Altrenotizie: Come l’hanno recepita secondo te i fan?
Altrenotizie: Come l’hanno recepita secondo te i fan?
Boosta: Guardando 12 anni dopo direi piuttosto bene, visto che siamo a Berlino per il nostro secondo tour europeo, non è andata sicuramente male.
Altrenotizie: Infatti ora suonate a Berlino, in Germania. In Italia siete conosciuti, sono 15 anni che calcate le scene; che rapporto avete con l’Europa e soprattutto che aspettative avete dall’Europa?
Boosta: Decisamente un buon rapporto, questo è il nostro secondo tour europeo e abbiamo vendite con numeri in crescita. Potrei dire che nell’arco di 3 anni da quello precedente stiamo raccogliendo i frutti, non so se del lavoro più virale della rete che diffonde la nostra musica, o del nome che si divulga, fatto sta che i sold-out ci sono. Certo le dimensioni non sono quelle dell’Italia, ma è anche vero che partire dalla dimensione del club, come stasera, è davvero bello; sono tutti posti che in Europa hanno segnato la storia della musica delle rispettive nazioni e noi siamo solo felici di poter mettere i piedi su questi palchi, e di metterli consapevoli di avere un pubblico sotto che ci guarda.
Altrenotizie: Una curiosità: la scaletta delle canzoni che presentate in una città europea è la stessa che presentate anche in Italia?
Boosta: No, tendenzialmente usiamo scalette che definiamo “ci piace vincere facile”, partiamo al massimo dall’inizio fino alla fine e poi vediamo che succede.
Altrenotizie: Incantevole, da Terrestre (2005): forse uno dei vostri successi più conosciuti e più diffusi. L’avete girato a Praga, c’è qualche motivo particolare che vi lega a questa città?
Boosta: In realtà è una questione di logistica, perché la storia fa riferimento a un posto romantico, e quindi è stato necessario rappresentarla in una città per gli innamorati. Direi che in Europa Praga è stata una delle prime scelte.
Altrenotizie: Sono 15 anni che i Subsonica compongono dischi e fanno concerti, un bel po’ di tempo, qual è la tua visione del panorama attuale della musica Italiana?
Boosta: La musica sta bene, grazie a Dio, è una forma d’arte che difficilmente può morire: è più facile che muoia l’industria musicale, come è successo negli ultimi 10 anni, ma è improbabile che muoia la musica stessa. Noto una ripresa sia di concerti dal vivo, sia di persone che scelgono di fare musica, o meglio, che scelgono di tornare a farla con gli strumenti. Per certi versi, forse, è finita l’infatuazione massiccia da elettronica, quello stile che si è avuto con l’avvento dei computer, delle registrazioni a basso costoso. O forse, quell’infatuazione si è semplicemente evoluta. Ai giorni nostri per registrare musica basta che qualcuno abbia un computer: probabilmente gli anni a cavallo del 2000 sono quelli che hanno visto le sale più vuote, perché con l’arrivo della tecnologia molti ragazzi hanno smesso di suonare per stare insieme, invece adesso sostanzialmente vediamo che c’è una bella ripresa.
Altrenotizie: Siete di Torino, non può mancare una domanda sul movimento NO-TAV, ancora in questi giorni si è manifestato. Da una parte il Governo che ha paura di rimanere fuori dall’Europa senza Alta Velocità, dall’altra i cittadini, che pensano alle proprie condizioni di vita, in una terra cui sono legati dalla quotidianità. Cosa ne pensi?
Boosta: Io penso che, per sentirci una nazione europea, dovremmo finire prima le infrastrutture che ci mancano, tra cui ad esempio l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, prima di pensare a quei pochi chilometri di alta velocità che vanno a occupare solamente su una dorsale e non sull’altra. La TAV non è assolutamente fondamentale per lo sviluppo italiano. È vero che porterebbe posti di lavoro in più, però non possiamo dimenticare che la maggior parte degli esperti dicono che poteva essere un progetto interessante 20 anni fa, e se dopo 20 anni ne parli ancora e non cominci a farlo vuol dire che sei già fuori tempo massimo.
Altrenotizie: Progetti futuri?
Boosta: Il progetto futuro è terminare questo tour europeo e poi buttarsi in un nuovo tour per festeggiare i nostri 15 anni di attività, spegnere le candeline, e poi alla fine di quest’anno che sarà dedicato ai live, cominciare a scrivere un disco nuovo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
MOSCA. Boris Leonidovic Pasternak se ne stava accanto alla finestra e vedeva le ragazze con gli abiti chiusi fino alle caviglie che passeggiavano su e giù tenendosi per mano, facendo scorrere il tempo sotto gli archi di pietra lungo i muri delle case dalle facciate austere. Era la via Mjasnitskaya nella Mosca più antica, oggi disseminata di gallerie d’arte.
Al numero ventuno c'era la celebre "Scuola di pittura, scultura e architettura", dove suo padre, Leonid Osipovich di cui quest’anno si celebrano i 150 anni della nascita (Odessa, 4 April 1862), famoso pittore e ritrattista, insegnava. Un giorno del 1911 capitò che vi si iscrivesse un giovane dall'aspetto malinconico arrivato dalla Georgia: era Vladimir Majakovskij. A maggio, dalle crepe del selciato veniva fuori un primo odore tiepido. D'inverno, la strada era tormentata da un vento gelido.
Dalla primavera all'autunno c'era quel continuo brusio che filtrava tra i vetri e accompagnava le musiche di Ciajkovskij che la madre di Boris, Roza Kaufmann, suonava al pianoforte. In ogni stagione la casa si riempiva di artisti come Makovski e Surikov, Repin e Miasoedov, di poeti come Rilke e Verhaeren, di storici come Kljucevskij e Zelinskij, di personaggi come Aleksandr Scrjabin che con Sergej Rachmaninov era il più straordinario innovatore della musica russa.
Pasternak lo ricorda nel poema L'anno 1905: «Un giorno/che il baccano dietro il muro/è incessante come la risacca/ed il gorgo delle stanze immoto/e la strada avvivata dal gas,/squilla il campanello,/voci si avvicinano:/Scrjabin./Oh, dove fuggire/dinanzi ai passi del mio idolo/». Era nei momenti degli incontri che suo padre lavorava con più frenesia. Seduto in un angolo, mentre la moglie suonava al pianoforte, Leonid Osipovich Pasternak, l'album sulle ginocchia, tracciava i profili dei suoi ospiti osservandone i movimenti, cogliendone i gesti, i sorrisi, i tratti poiché, come diceva: «Bisogna saper disegnare rapidamente perché i personaggi non devono accorgersene: non mi piace che si mettano in posa».
Era un pittore affermato da quando s'era legato da grande amicizia a Lev Nikolaevic Tolstoj per il quale aveva disegnato le illustrazioni del romanzo “Resurrezione”. In seguito gli fu riconosciuto il merito di aver "fotografato" con le sue opere il confine tra due epoche, un periodo tra i più ricchi di fermenti della cultura russa. Aveva fissato sulla carta quel percorso di sentimenti e di ambientazioni che sarebbero poi stati sconvolti dalla rivoluzione bolscevica. Per questo motivo Leonid Osipovich è collocato tra i grandi della pittura russa.
 Ma i suoi quadri non furono esposti nei musei sovietici. Molti furono distrutti, altri confinati nei magazzini. Il suo nome, quando uscì il romanzo “Il dottor Zivago” e cominciò la persecuzione di Boris Pasternak, fu persino cancellato sull'Enciclopedia sovietica, come se non fosse mai esistito. È per questo che adesso la gente fa sempre la coda ogni qual volta si organizza una mostra con i suoi quadri. La gente vuoIe vedere quegli ambienti dove Boris Pasternak aveva consumato la sua giovinezza, maturato la sua poesia, pensato al suo famoso romanzo che gli valse il Nobel.
Ma i suoi quadri non furono esposti nei musei sovietici. Molti furono distrutti, altri confinati nei magazzini. Il suo nome, quando uscì il romanzo “Il dottor Zivago” e cominciò la persecuzione di Boris Pasternak, fu persino cancellato sull'Enciclopedia sovietica, come se non fosse mai esistito. È per questo che adesso la gente fa sempre la coda ogni qual volta si organizza una mostra con i suoi quadri. La gente vuoIe vedere quegli ambienti dove Boris Pasternak aveva consumato la sua giovinezza, maturato la sua poesia, pensato al suo famoso romanzo che gli valse il Nobel.
Poiché, come scrisse Kornelij Zelinskij, la sua ispirazione «sorse in un punto dei piccoli appartamenti professorali della Mosca prerivoluzionaria, tra il pianoforte, dove ancora giacevano i manoscritti di Scrjabin, e lo scrittoio dello studio con le poltrone di pelle, dove alle pareti erano appesi i quadri e sotto la lampada si sfogliavano Kant, Cohen, Nartop, mentre oltre la finestra una cultura di molti secoli, molte lingue frusciava col silenzio delle meditazioni. Là forse si sentivano i contrafforti della vita: ormai alle spalle c'era una rivoluzione». La gente vuoIe "leggere" e “rileggere” questa storia dei Pasternak, che non era mai apparsa prima. Se n'era incuriosita fin da quando sulle pagine di Novi Mir era cominciata - trent'anni dopo che il libro era uscito in tutto il mondo - la pubblicazione a puntate del Dottor Zivago.
Ma questo popolo dalla pazienza infinita dovrà attendere un anno ancora per sapere altri particolari della vicenda. A fornirli fu la Literaturnaja Gazeta, il settimanale degli scrittori, il quale promuovendo la prima esposizione ufficiale (agosto 1989) delle opere di Leonid Osipovich ne aveva ripercorso la storia, ricordando che molti dei lavori erano raccolti nella dacia di Peredelkino e che molti erano stati distrutti durante la guerra,quando vi alloggiavano i soldati i quali usavano la carta coi disegni per fabbricarsi i samokrutki, cioè le sigarette.
Evgheny Pasternak, il figlio dello scrittore - una vita dedicata alla memoria del padre - mi raccontava con una profonda amarezza che, «Alcune delle opere del nonno decoravano la stanza dove mio padre scriveva, incontrava gli amici, passava gran parte della sua giornata. Sapevo quanto ci teneva a quelle tele, a quegli schizzi, e non si pacificava per quelli che erano andati perduti. Purtroppo nel l’Ottantaquattro nella casa di Peredelkino sono piombati i rappresentanti dell'Unione degli scrittori dell'Urss, i miliziani e i giudici, e in meno di dodici ore ci hanno sfrattato, hanno sfasciato quel che restava delle memorie nostre più care, hanno seminato il prato coi disegni strappati di mio nonno. La casa intanto è rimasta vuota e non si capisce che cosa abbiano deciso di farne». Era appunto nell’agosto del 1989 che incontrai Evgheny Pasternak che aveva da poco compiuto i sessantaquattro anni.
 Oggi ci si arriva comodamente in treno alla dacia trasformata in casa-museo di Boris Pasternak che si trova al numero 3 di via Pavlenko. E' aperta dalle 10 alle 16, dal martedì alla domenica e l'ingresso costa 100 rubli (poco meno di 3 euro). La dacia dove nacque Zivago è lontana dalla stazione ferroviaria, sepolta nel bosco di Peredelkino, da sempre il "villaggio degli scrittori". È come una nave che galleggia su un fiume di verde. Nella stanza da letto spoglia e nello studio sono rimasti i suoi stivali, il cappotto e il cappello così come lui li lasciò. Sulla luminosa veranda, il tavolo è apparecchiato con le tazze e il samovar.
Oggi ci si arriva comodamente in treno alla dacia trasformata in casa-museo di Boris Pasternak che si trova al numero 3 di via Pavlenko. E' aperta dalle 10 alle 16, dal martedì alla domenica e l'ingresso costa 100 rubli (poco meno di 3 euro). La dacia dove nacque Zivago è lontana dalla stazione ferroviaria, sepolta nel bosco di Peredelkino, da sempre il "villaggio degli scrittori". È come una nave che galleggia su un fiume di verde. Nella stanza da letto spoglia e nello studio sono rimasti i suoi stivali, il cappotto e il cappello così come lui li lasciò. Sulla luminosa veranda, il tavolo è apparecchiato con le tazze e il samovar.
E’ sulla veranda, nelle giornate d'estate, protetto dal sole e dagli acquazzoni che Boris Pasternak appuntava su dei sottili quaderni i ricordi e la sua quotidiana esperienza: «Mi aggrappai a quel lavoro e cominciai a lavorare con passione raddoppiata. Ma proprio quella passione avrebbe rivelato all'osservatore esperto che non sarei mai divenuto uno scienziato. lo vivevo lo studio della scienza con più intensità di quanto richiedesse la materia. Una specie di pensiero vegetativo operava in me. La sua particolarità era nel fatto che ogni concetto secondario, spiegandosi illimitatamente nella mia interpretazione, cominciava a prendere cibo e ogni sorta di cure e quando io sotto la sua pressione mi rivolgevo ai libri, non ero mosso dall'interesse spassionato per il sapere, ma dalle citazioni letterarie che lo suffragavano».
In queste parole è racchiuso il segreto della poesia di Pasternak, la sua passione per l'oggetto, per il particolare,per i significati della vita e della morte. E un'estate, siamo nel 1913, a ventitré anni «si mise a scrivere versi non per eccezione, ma di seguito, con costanza, allo stesso modo con cui si dipingono i quadri o si compone musica». Certo, la poesia la rincorreva da tempo, soprattutto da quando aveva scoperto Rainer Maria von Rilke su una copia di Mir zu Feifer, che il poeta austriaco aveva regalato al padre, Leonid, quando era stato in visita a Jasnaja Poljana da Tolstoj. La scoperta di Rilke risale al 1907. Nell'autunno del 1913, a Mosca, Pasternak incontrò Verhaeren, che stava ottenendo un gran successo in Russia: Brjusov l'aveva tradotto, BeIyj lo definì un «Dante dell'età contemporanea». Leonid Osipovich gli stava facendo un ritratto, e Boris lo intratteneva durante le pose: gli chiese se conoscesse Rilke, e Verhaeren gli rispose che era il miglior poeta d'Europa.
Di tutte le letture giovanili, si può dire che solo Rilke abbia avuto un'influenza diretta sui suoi versi: molti anni più tardi, nel 1926, inviandogli un suo volume di rime, Pasternak deve averglielo scritto, se Rilke rispondeva così: «Come posso ringraziarvi d'avermi permesso di vedere e di sentire quello che avete moltiplicato dentro di voi così miracolosamente! Il fatto che abbiate potuto attribuirmi una messe così ricca nella vostra sensibilità dice le lodi del vostro cuore generoso».
Ho riferito questi episodi della sua biografia per meglio far capire quant'erano stretti i rapporti tra padre e figlio, che non s'interruppero nemmeno quando nel 1921 Leonid Osipovich si trasferì a Berlino per far curare la moglie ammalata, che morì diciotto anni dopo. E proseguirono quando il pittore raggiunse la figlia in Inghilterra, a Oxford, dove soggiornò fino alla morte, il 31 maggio del 1945. Evgheny Pastenak mi raccontava come suo padre fosse «ammaliato dalla grande capacità di mio nonno di concentrarsi sul lavoro. Nelle lettere ne sottolineava la maestria rara di saper cogliere al volo gli oggetti, le persone in movimento, le scene della vita quotidiana, poiché era accaduto in un'epoca in cui l'artista d'abitudine se ne stava rinchiuso nell'atelier. Figurarsi l'amarezza di mio padre quando seppe, negli Anni Trenta, che molte opere, si trattava soprattutto dei ritratti dei personaggi più noti della rivoluzione, erano state distrutte o esiliate nei musei periferici di Vologda e di Celiabinsk, in Siberia».
 Boris Pasternak riprese a scrivere “Zivago” un anno dopo la morte del padre, nel 1946. L'aveva già interrotto due volte: nel 1918 e nel 1936, perché non aveva abbastanza denaro. Lo scrisse assicurandosi da vivere con le traduzioni. Un lavoro sfibrante: traduceva in russo una tragedia di Shakespeare in due mesi e poi tornava a scrivere. L'epilogo è noto: Zivago divenne causa di un terribile scandalo politico.
Boris Pasternak riprese a scrivere “Zivago” un anno dopo la morte del padre, nel 1946. L'aveva già interrotto due volte: nel 1918 e nel 1936, perché non aveva abbastanza denaro. Lo scrisse assicurandosi da vivere con le traduzioni. Un lavoro sfibrante: traduceva in russo una tragedia di Shakespeare in due mesi e poi tornava a scrivere. L'epilogo è noto: Zivago divenne causa di un terribile scandalo politico.
Non lo vollero pubblicare in Urss e fu pubblicato in Italia. Poi a Pasternak arrivò il Nobel, che gli fu dato per tutta la sua opera, e quando Krusciov lo seppe da una notizia proveniente dagli Stati Uniti, scoppiò un putiferio enorme e lo scrittore fu costretto a mandare un telegramma con il quale rinunciava volontariamente al premio.
Evgheny mi ricordava che pur in quel travaglio il padre continuava a lavorare ogni giorno, continuava a scrivere poesie, e non partecipava alle riunioni che si facevano su di lui e sul caso letterario che aveva provocato. Dalla sua dacia di Peredelkino, tra i ritratti muti dei personaggi dipinti da suo padre, e quei paesaggi che gli avevano ispirato la storia di Lara, mandava messaggi al mondo raccomandandosi che la sua opera non fosse strumentalizzata ai fini politici.
«No, non mi fece mai segreto dei suoi scritti», raccontava Evgheny. «Leggevo i capitoli del libro, ne parlavamo: era parte della nostra esistenza. Alle mie esitazioni mio padre rispondeva citandomi la regola di vita più amata da Tolstoj: "Fai quel che tu devi, sia quel che sia". Poi il discorso ogni volta scivolava inevitabilmente ai periodi vissuti a Jasnaja PoIjana, nella casa del grande patriarca, con il nonno che dipingeva le scene di Resurrezione, e i lunghi conversari che vi si svolgevano. Soltanto questi ricordi riuscivano a rasserenarlo».
 La tomba di Pasternak è sotto una quercia nel piccolo cimitero contadino dagli steccati di legno turchese, accanto alla chiesetta bianca e luminosa che risale ai tempi di Ivan il Terribile. Ci sono sempre i sentierini delicati che separano ogni tanto un recinto dall'altro per consentire il passaggio dei parenti che vanno a deporre fiori e cibo sulle tombe dei loro morti.
La tomba di Pasternak è sotto una quercia nel piccolo cimitero contadino dagli steccati di legno turchese, accanto alla chiesetta bianca e luminosa che risale ai tempi di Ivan il Terribile. Ci sono sempre i sentierini delicati che separano ogni tanto un recinto dall'altro per consentire il passaggio dei parenti che vanno a deporre fiori e cibo sulle tombe dei loro morti.
Cancelletti minuscoli permettono di infilarvi il braccio in modo che le offerte raggiungano il centro del tumulo. Soltanto la tomba di Boris Pasternak è più estesa delle altre, con quella lastra di marmo molto bianco sulla quale si distingue, in bassorilievo, la figura dello scrittore, che consente di riconoscerla da lontano.
Mi dicono che in passato poca gente andasse a Peredelkino sulla tomba di Pasternak. Ma non dev'essere del tutto vero, poiché oggi si dice pure che le sue esequie, nel Sessanta, furono la prima manifestazione di dissenso alla quale parteciparono diecimila persone. E poi in tutti questi anni puntualmente, affettuosamente, per chissà quali strade, si è fatto in modo di circondare lo scrittore, morto nell'indifferenza ufficiale, di quel rispetto che in vita gli venne a lungo negato.
Quasi a testimoniare che il Paese, nonostante tutto, è sempre riuscito ad individuare qual è il suo posto vero nella storia. Sebbene sia da sempre afflitto da prove terribili non ancora del tutto superate, zeppe di incongruenze e crudeltà, che si riassumono in questa scartocciata bottiglia di plastica nella quale hanno infilato tre garofani, ed è davanti alla lapide posta là a ricordare che Boris Pasternak è esistito.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Occhiali scuri, capelli lunghi, pantaloni di pelle aderentissimi e anfibi. Sotto i piedi la terra, rossa e bruciata, e intorno le tenebre della foresta. I Masnadieri di Gabriele Lavia urlano, sparano e si muovono in maniera nervosa sulla scena, seguendo la musica alta e travolgente. Sono anime nere, inquiete, un po’ Guerrieri della Notte e un po’ briganti di vecchia data. Lavia rivisita in teatro, e lo fa con grande maestria, il dramma in cinque atti di Friedrich Schiller, che esordisce sulle scene proprio con questo testo.
Rappresentato nel 1782 a Mannheim, fu un successo clamoroso e sembra che durante la rappresentazione alcune signore siano svenute dall’emozione e che gli spettatori si siano abbracciati in un turbine di emozioni. Die Räuber, i briganti, i ribelli, narra la storia di due fratelli, il malvagio e sformato Franz (che ama senza essere corrisposto né dal padre né da Amalia) e il valoroso e bello Karl.
Franz rivela subito le sue mire malefiche e l’intenzione di mettere le mani sulla contea di Morr, tentando di far morire di crepacuore il vecchio padre. Scrive, infatti, delle finte lettere, facendo credere che Karl abbia disonorato il nome di famiglia, macchiandosi delle più becere azioni.
Il vecchio Moor si lascia convincere che sia meglio non perdonare subito Karl, ma lasciare che sia lui a tornare a casa. Franz scrive invece al fratello che il perdono non potrà mai averlo.
Da qui si apre la tragedia, Karl prende la lettera del padre come un rifiuto totale nei suoi confronti e invece di continuare il suo processo di redenzione, tornando a casa, si unisce a una banda di rivoluzionari che poi diventeranno masnadieri.
Al castello proseguono i piani di Franz che non riesce a sedurre Amalia, scivolando sempre più nell’inferno della sua solitudine e abominazione. “Con questa tragedia Schiller entra violentemente nella storia della letteratura tedesca come poeta della ribellione e come suddito ribelle, retore della libertà politico-scoiale e nella kantiana libertà etica”, afferma Lavia.
Un’opera rivoluzionaria che ha tratti molto moderni nella riproposizione di Lavia e che mette in luce la necessità della rivolta quando le condizioni storiche lo richiedono, nonostante questo possa costare molto. “I Masnadieri - continua Lavia - s’inseriscono idealmente nello Strum und Drang e in quella luce di furore visionario l’opera attacca le istituzioni politiche e sociali e i pregiudizi morali nel proposito di impiegare il palcoscenico come ‘Istituto morale’”.
La gioventù e l’energia nello scardinare il vecchio sono la forza motrice di questo spettacolo e proprio per questo Lavia sceglie attori giovani, dando vita a uno spettacolo altamente coinvolgente e appassionato, dove la protesta si innalza con le voci e le azioni nervose e violente degli attori che corrono, saltano e cantano la loro disperazioni. Giovani che assomigliano molto a quelli che si vedono nelle manifestazioni in piazza, che lottano per un lavoro o per i loro diritti.
Il parallelismo viene facile, anche se poi i Masnadieri cederanno completamente al delitto, alla brutalità delle armi da fuoco e alla cancellazione di ideali alti. Lavia mise in scena i Masnadieri già nel 1982, scegliendo Monica Guerritore e Umberto Orsini tra gli interpreti. Ma oggi il regista sceglie una messa in scena completamente diversa, carica di elettricità e furente, dove la fisicità è violenta e coinvolgente allo stesso modo dell’emotività scaturita dai dialoghi. La scelta dell’eccesso è azzeccata e rende l’idea di una chiara inversione di tendenza anche nel teatro d’autore.



