- Dettagli
- Scritto da Administrator
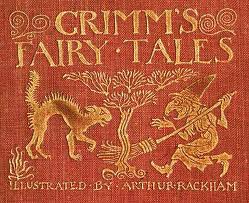 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Checché ne dicano i neuropsichiatri infantili, le fiabe sono ancora oggi uno degli strumenti di trasmissione valoriale più forti che esistano per l'infanzia. Non del tutto soppiantata da social network e consolle, la fiaba è un genere narrativo fantastico popolato di giganti, fate, gnomi e streghe maligne che differisce dalla favola - i cui protagonisti sono solitamente animali antropomorfi - e ha il preciso intento di offrire una morale alla sua conclusione.
L'intento della fiaba vuole infatti essere quello di aiutare il bambino a comprendere quali siano le azioni positive e quali quelle negative, ad essere generosi con i deboli, a rispettare la famiglia, ad avere il coraggio di affrontare il cattivo di turno per cambiare il proprio destino o semplicemente il corso dei fatti. Ma è davvero sempre stato così?
La scorsa settimana è uscito nelle librerie del Regno Unito Fairy Tales from the Brothers Grimm: A New English Version l'ultimo saggio di Philip Pullman - l'oxfordiano già autore della trilogia best seller Queste oscure materie - che ripercorre le origini e le trasformazioni delle celeberrime fiabe dei fratelli Grimm. Leggendolo si rimane impressionati da quanto le storie siano mutate nel corso del tempo. I riferimenti sessuali e gli episodi più macabri sono stati perlopiù rimossi e nessuna delle storie più orrorifiche ce l'ha fatta a entrare nel circuito mainstream e a raggiungere i nostri giorni.
Partiamo con la Bella Addormentata. In una delle primissime versioni di questo classico, pubblicata nel 1634 da Gianbattista Basile sotto il titolo di “Il sole, la luna e Talia”, la principessa non si punge il dito con la punta di un fuso ma invece si pianta una scheggia sotto l'unghia. Cade apparentemente morta e suo padre, incapace di accettare la perdita, decide di custodire il suo corpo ponendolo su un letto in uno dei suoi palazzi. Qualche tempo dopo un re a caccia nei boschi riesce a trovarla ma, non riuscendola a svegliare, la stupra, consapevole che la sua incoscienza non lo avrebbe tradito.
Dallo stupro nascono però due gemelli, che la bella dà alla luce nonostante il coma, uno dei quali accidentalmente succhia la scheggia fuori dal dito, riuscendo finalmente a svegliarla dal pesantissimo sonno cui il sortilegio l'aveva condannata. Vista la prole, un matrimonio riparatore è d'obbligo ma il re che aveva stuprato la bella Talia risulta già sposato e per accogliere la nuova sposa decide di bruciare viva quella vecchia. Ma non temete, prima di tutto questo la regina prova a uccidere e mangiare i due gemelli, quindi, moralmente parlando, torna tutto.
 Passiamo ora alla celeberrima fiaba di Cappuccetto Rosso e del lupo cattivo. Quando la misero per iscritto, i fratelli Grimm addolcirono molto questa storia rispetto a com'era quando se la ritrovarono tra le mani.
Passiamo ora alla celeberrima fiaba di Cappuccetto Rosso e del lupo cattivo. Quando la misero per iscritto, i fratelli Grimm addolcirono molto questa storia rispetto a com'era quando se la ritrovarono tra le mani.
Nella versione di Charles Perrault, inclusa nella sua raccolta “Storie e favole del tempi antichi: i racconti di Mamma Oca” del 1697 non c'è nessun intrepido cacciatore. Cappuccetto rosso semplicemente si spoglia, va a letto e viene divorata dal grosso lupo cattivo. Nessun intervento miracoloso, nessun lieto fine.
Eppure Perrault ci lascia un piccolo verso in rima in cui afferma che non tutti i lupi sono bestie feroci: alcuni seducono con la gentilezza e si intrufolano nel nostro letto per farci del male. I riferimenti sessuali non si sono persi comunque, e sono arrivati fino ai nostri giorni: a tutt'oggi, l'espressione francese per definire una ragazza che ha perso la verginità è elle avoit vû le loup, “lei ha visto il lupo”.
Per quanto riguarda la storia di Cenerentola, Perrault è molto più gentile dei Grimm. Nella sua versione le due crudeli sorellastre vanno in sposa a due membri della corte regale subito dopo il matrimonio tra Cenerentola e il principe. Nella favola dei fratelli Grimm non solo le due sorellastre si amputano letteralmente parte dei piedi per riuscire a farli calzare nella scarpetta di cristallo ma alla fine vengono pure condannate a farsi cavare gli occhi dalle beccate di una colomba. Così, giusto per bilanciare.
Arriviamo ora alla fiaba per antonomasia: Biancaneve e i sette nani. Prima di tutto, nella versione dei fratelli Grimm del 1812, la regina cattiva è la vera madre di Biancaneve e non la sua matrigna. La stessa versione Disney omette di dire che oltre al cuore di Biancaneve la regina chiede al cacciatore di portarle anche il fegato e i polmoni della principessa in quanto intende mangiarli.
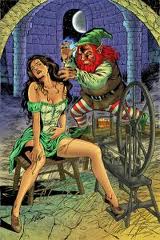 In più Biancaneve non è addormentata quando il principe finalmente la riesce a trovare: è bella che morta e lui sta provando a porta via di forza il suo corpo morto, quando il suo servo inciampa e cade rovinosamente sulla bara liberando la gola di Biancaneve dalla mela avvelenata.
In più Biancaneve non è addormentata quando il principe finalmente la riesce a trovare: è bella che morta e lui sta provando a porta via di forza il suo corpo morto, quando il suo servo inciampa e cade rovinosamente sulla bara liberando la gola di Biancaneve dalla mela avvelenata.
Interessante poi la punizione che i Grimm escogitano per la regina cattiva: nel momento in cui si presenta al matrimonio tra Biancaneve e il principe Azzurro, viene subito obbligata a indossare scarpe di ferro bollente e con queste a danzare letteralmente fino alla morte. Alla faccia del contrappasso.
Conosciamo poi tutti la storia della sirenetta che vende la sua voce per un paio di gambe, se ne va in giro per il reame e finalmente vince il cuore del valoroso principe. Bene, dimenticatela. Nella versione originale di Hans Christian Andersen la bella sirenetta baratta sì la sua lingua per un paio di gambe ma l'accordo con la strega del mare prevede anche che ogni passo della sirenetta sulla terra risulti per lei praticamente insostenibile, come camminare su rocce taglienti.
In più nella versione non edulcorata dalla Disney, il principe sposa un'altra donna e la sirenetta, fallito l'obiettivo di far ricambiare il suo amore, muore trasformandosi in schiuma dell'oceano.
Prima di questo tragico epilogo, però, le sorelle della sirenetta vendono i loro capelli in cambio di un pugnale in grado di spezzare il patto stretto con la strega del mare: con quello la sirenetta avrebbe dovuto uccidere il principe, lasciando che il suo sangue scorresse sui piedi di lei in modo da ritrasformarli in pinne. Coma accennato poc'anzi, il finale tragico non lascia certo spazio ai buoni sentimenti.
Dimenticate quindi le trasposizioni animate della Disney e magari pensateci due volte prima di leggere uno di questi classici ai vostri bambini per la buonanotte. Potrebbero non essere propriamente di sogni d'oro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Maternità, questione femminile, guerra e democrazia. Le Arie che Lella Costa porta in teatro (prima al Carcano di Milano, poi al Secci di Terni) portano con loro una serie di tematiche e questioni di grande rilievo, che l’attrice affronta in maniera ironica, alludendo alla musica e al non prendersi troppo sul serio. Ma allo stesso tempo, mettendo l’accento su alcune questioni che attraversano la vita di tutti.
È ancora quello femminile il sesso debole? Quando è ora che una madre lasci andare i propri figli alla scoperta del mondo? Quando finirà il dramma della guerra?
Tre sedie, luci soffuse e la musica che, insieme alle parole dell’attrice, fanno di questo spettacolo un divertente modo di guardare alla vita.
I copioni degli spettacoli, la Costa li definisce più degli spartiti ed è da qui che nasce un sodalizio con la musica che la porterà nel marzo del 2010 a ottenere da gli Amici del Conservatorio di Milano il premio Una vita per la musica. Così l’attrice ha deciso di riprendere tra le mani i copioni dei suoi vecchi spettacoli, da Ragazze a Adlib, ma anche Stanca di guerra, scoprendo che c’era al loro interno la costante presenza della musica, non solo come semplice colonna sonora, ma come voce altra. E da qui la volontà di riproporre queste romanze recitate, per rimettere vicini momenti che sembrano in apparenza lontani. A tutto questo materiale scritto, si somma il lavoro con musicisti come Paolo Fresu, Stefano Bollani, Rita Marcotulli, Furio Li Castri, e via dicendo. I suoi sono monologhi che sapientemente riescono a alternare ironia e serietà, comicità e drammaticità, per affrontare quelle che sono le dinamiche che muovono la società e il rapporto tra gli individui.
A tutto questo materiale scritto, si somma il lavoro con musicisti come Paolo Fresu, Stefano Bollani, Rita Marcotulli, Furio Li Castri, e via dicendo. I suoi sono monologhi che sapientemente riescono a alternare ironia e serietà, comicità e drammaticità, per affrontare quelle che sono le dinamiche che muovono la società e il rapporto tra gli individui.
Un po’ Alice nel Paese delle Meraviglie e un po’ Traviata, Lella Costa si destreggia magistralmente tra le parole e le musiche che l’accompagnano, rivolgendosi sovente direttamente al pubblico per renderlo partecipe, instaurando quasi una sorta di dialogo.
Ma lo spettacolo non parla mai direttamente di attualità, ma pesca più nella tradizione e nei miti passati. Non sarà un caso, allora, che la conclusione venga affidata allo splendido testo di Pericle, Il Discorso agli Ateniesi, del 461 a.C., dedicata in questa sua trasposizione contemporanea a un’Italia impaurita e preda degli eventi, ma che può risollevarsi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Sara Michelucci
di Sara Michelucci
Tiranni e cittadini, anzi sudditi. È su questo rapporto che Ascanio Celestini basa il suo nuovo spettacolo, Discorsi alla Nazione - Studio per spettacolo presidenziale, che ha presentato al Teatro Secci di Terni e che porterà in altri teatri italiani. Aspiranti tiranni si alternano, così, sul palcoscenico, mettendo in luce tutte le atrocità che una forma di potere di questo tipo porta con sé. Le parole di Celestini tuonano su un palcoscenico scarno, senza scenografia se non una sedia messa a lato, e colpiscono dritte lo spettatore.
“Cittadini! Lasciate che vi chiami cittadini anche se tutti sappiamo che siete sudditi, ma io vi chiamerò cittadini per risparmiarvi un’inutile umiliazione”, tuona l’attore. Il tiranno è chiuso nel palazzo. Non ha nessun bisogno di parlare alla massa. I suoi affari sono lontani dai sudditi, la sua vita è un’altra e non ha quasi nulla in comune con il popolo che si accontenta di vedere la sua faccia stampata sulle monete.
Eppure il tiranno si deve mostrare ogni tanto. Deve farsi acclamare soprattutto nei momenti di crisi quando rischia di essere spodestato. Così si affaccia, si sporge dal balcone del palazzo e rischia di diventare un bersaglio. “Ho immaginato - afferma Celestini - alcuni aspiranti tiranni che provano ad affascinare il popolo per strappargli il consenso e la legittimazione. Appaiono al balcone e parlano senza nascondere nulla. Parlano come parlerebbero i nostri tiranni democratici se non avessero bisogno di nascondere il dispotismo sotto il costume di scena dello stato democratico”. Celestini ritorna ad affrontare il potere, attraverso il suo teatro che ha la funzione di far riflettere, di aprire gli occhi su quello che la società contemporanea e la politica che ci governa sono o possono diventare. Il suo è uno sguardo lucido, schietto, che non risparmia niente e nessuno. Destra e sinistra fanno parte di uno stesso percorso, che si differenzia per alcuni punti, ma che non si discosta poi molto da una linea votata al potere e alla supremazia sui cittadini.
Celestini ritorna ad affrontare il potere, attraverso il suo teatro che ha la funzione di far riflettere, di aprire gli occhi su quello che la società contemporanea e la politica che ci governa sono o possono diventare. Il suo è uno sguardo lucido, schietto, che non risparmia niente e nessuno. Destra e sinistra fanno parte di uno stesso percorso, che si differenzia per alcuni punti, ma che non si discosta poi molto da una linea votata al potere e alla supremazia sui cittadini.
E così anche il considerarsi “di sinistra” può nascondere tutta una serie di luoghi comuni e pregiudizi, che smascherano la vera natura di alcuni politici. La guerra, il razzismo, la logica di un potere becero che non risparmia nessuno, se non chi decide di aprire gli occhi su quello che ci viene proposto e cercare un punto di vista altro, sono i temi fondamentali.
Celestini propone proprio questo attraverso il suo teatro che fa sorridere, ma al tempo stesso stimola le coscienze. Se con La pecora nera, Celestini si mette dietro la macchina da presa per raccontare le vite di coloro che hanno conosciuto l’esperienza nel manicomio, denunciando un determinato sistema sanitario e in Pro Patria è una prigione il luogo dell’azione, in Discorsi alla nazione prende di petto il potere e lo sviscera fino a mostrarne il lato più oscuro. Quel ‘cuore di tenebra’ di conradiana memoria che attraversa sottile le membra della società.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
Che i generali del Pentagono abbiano una crisi di nervi quando gli si chiede se Israele li informa sui suoi piani d’attacco terrestri pochi lo sapevano, prima che lo rivelasse Mark Perry in un’inchiesta (Come l'esercito americano pensa che Israele potrebbe colpire l'Iran) pubblicata sulla rivista Foreign Policy. Un articolo dagli effetti deflagranti, considerato che è un momento nel quale più acceso è il dibattito sia negli Stati Uniti come in Israele sull’opportunità di un attacco armato contro l'Iran.
Perché la testimonianza raccolta da Mark Perry è quella di un generale a cinque stelle, il quale ha dichiarato senza mezzi termini che al Pentagono sono costretti a “volare alla cieca” perché Israele «non ci dice quello che pensa di fare e come intende attuarlo, come se fosse un grande segreto da non condividere nemmeno con noi». Infatti, pare che pure il segretario alla Difesa Leon Panetta abbia dovuto desistere dall’impresa per - come usa dire - non perdere la faccia.
Tutto questo è successo dopo che Benjamin Netanyahu, il primo ministro di Israele, aveva tenuto il famoso discorso della “linea rossa” alla 67esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, più o meno un mese fa. In quella occasione, il premier israeliano aveva denunciato le minacce che incombono sul suo Paese soffermandosi su quella nucleare dell’Iran. Per rendere chiara la posizione di Israele sulla questione, Netanyahu aveva mostrato all’aula un cartello su cui era disegnata una bomba, divisa schematicamente in alcuni stadi. Con un pennarello rosso, egli aveva segnato una linea nell’area dello stadio finale di progettazione della bomba, spiegando che Israele non consentirà all’Iran di andare oltre un certo punto nello sviluppo dei suoi armamenti atomici.
Non so dove Benjamin Netanyahu fondi tanta certezza. L’Iran non è l’Egitto sgangherato della guerra dello Yom Kippur (24 ottobre 1973). Sicché, quando il presidente iraniano Amadinejad avverte che un qualsiasi attacco all’Iran sarebbe da considerarsi un attacco “a tutto l’Islam”, la sua minaccia non va affatto sottovalutata. Poiché determinante è il ruolo dell’Iran e soprattutto dell’Islam persiano nella civiltà musulmana.
Unico vero rivale dell'arabo, il persiano e la sua «accademia» sono stati per secoli gli strumenti di un modo diverso di pensare l'Islam, non necessariamente opposto ma il più delle volte complementare a quello più ufficiale dell'arabismo. I tentativi di inquadrare l'eresia musulmana in termini di sciismo contro sunnismo, religiosità popolare contro religione espressione del potere, sopravvivenze mitologiche contro storicizzazione libresca, Islam di second'ordine contro vero Islam, sono tutti immancabilmente fuorvianti, come la Storia degli ultimi lustri sta dimostrando. Anzi, oggi viene il sospetto che gli studiosi occidentali seminando per oltre un secolo queste idee, abbiano fornito l'ossatura ideologica a certi rigorismi dell'Islam contemporaneo, che molte fazioni hanno fatto propri per meglio diffondere la propria visione religiosa povera e iconoclasta.
 Dopotutto il fattore che determina l’importanza dell’Iran nel panorama politico mondiale non é soltanto la sua posizione geografica e le risorse energetiche di cui dispone, ma è sopra ogni cosa la sua estensione culturale, nel senso più letterale del termine. Infatti, l’Iran è al centro di quell’area dell’Asia sud-occidentale che è in contatto diretto con l’Eurasia, la Cina, l’India, il Caucaso, la Russia, il Medio Oriente, la penisola arabica.
Dopotutto il fattore che determina l’importanza dell’Iran nel panorama politico mondiale non é soltanto la sua posizione geografica e le risorse energetiche di cui dispone, ma è sopra ogni cosa la sua estensione culturale, nel senso più letterale del termine. Infatti, l’Iran è al centro di quell’area dell’Asia sud-occidentale che è in contatto diretto con l’Eurasia, la Cina, l’India, il Caucaso, la Russia, il Medio Oriente, la penisola arabica.
Oggi, come nel passato, l’Iran è il punto d’incontro tra le grandi civiltà: la civiltà indiana, la civiltà islamica e la civiltà europea. L’Iran, insomma, è soprattutto la culla millenaria della civiltà indo-iranica, dove la civiltà iranico-islamica (a partire del VII secolo) e la civiltà iranico-europea (a partire del XVII secolo) si incontrano. Stando così le cose, essere presenti sul territorio iraniano significa avere la possibilità operativa di controllare e dominare uno scacchiere che va dal Pacifico al Mediterraneo, comprese le aree limitrofe.
Infatti in tutte queste aree, l’Iran storicamente ha una presenza e un’influenza culturale radicata. Oggi più di ieri, questa presenza è legata alla natura dell’attuale potere in Iran, poiché esso è gestito dagli ayatollah, che rappresentano le varie anime del clero sciita. In Pakistan, un quarto della popolazione è di fede sciita, così come sono sciite le minoranze consistenti dei musulmani nel resto del subcontinente indiano. Nell’Asia centrale - Uzbekistan e Tagikistan - forte è la componente islamica, ma lo è anche quella iranica. Nel Caucaso meridionale, la maggioranza della popolazione è di fede sciita in Azerbaijan, per esempio.
In Iraq (la culla storica dello sciismo, con i seminari di Najaf e Kerbala, dove risiede la leadership religiosa) gli sciiti, in sintonia con quelli dell’Iran e dell’area siro-libanese, sono la maggioranza della popolazione e risiedono nelle zone petrolifere del Sud del Paese. Pure negli sceiccati petroliferi del Golfo Persico sono forti e attive le comunità sciite. Nel Bahrein esse rappresentano l’80 per cento della popolazione e anche il petrolio saudita viene estratto in buona parte dalle regioni orientali dove è numerosa la presenza sciita. E così pure in Siria, nello Yemen e nel Kashmir, e fino al Mediterraneo, dove gli sciiti del sud del Libano hanno stretti legami ideologici e familiari con la Repubblica islamica di Teheran. Naturalmente, anche l’Islam combattente s’ispira alle varie anime che formano il potere degli ayatollah (Jihad islamica, Hezbollah nel Libano, sciiti iracheni, sauditi e yemeniti del Bahrein).
Zbigniew Brzezinski, (ex consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense durante l’amministrazione democratica Carter), pensava all’area petrolifera del Medio Oriente che gravita materialmente, storicamente e culturalmente intorno all’Iran quando spiegò, sulle pagine di The National Interest, che «il controllo del Medio Oriente da parte degli Stati Uniti conferisce loro un potere indiretto, ma politicamente decisivo, sulle economie europee e asiatiche, che dipendono anch’esse dalle esportazioni energetiche provenienti dalla regione».
Pertanto avere l’Iran come alleato o sotto il proprio controllo, significa poter gestire le risorse energetiche racchiuse tra il Golfo Persico e il Mar Caspio; il che vuol dire governare l’intera economia mondiale, poiché Europa, Giappone, Cina e India, tutti dipendono da quest’area geografica. Così meglio si capisce perché gli Stati Uniti avrebbero accettato per la prima volta la proposta iraniana di negoziati diretti sul controverso programma nucleare di Teheran. Lo ha riferito qualche giorno fa il New York Times citando fonti dell'amministrazione Obama, e aggiungendo che gli iraniani hanno posto come condizione di attendere le elezioni del 6 novembre negli Usa per sapere se dovranno trattare con Barack Obama o con Mitt Romney.
 Una settimana prima - quale straordinaria coincidenza - era stato l’ex segretario di Stato americano e premio Nobel per la Pace Henry Kissinger ad affrontare la questione in una intervista al Washington Post. Secondo l’ex segretario dovrebbero essere soltanto dagli Stati Uniti a gestire la crisi con l’Iran poiché se non lo fanno, “darebbero a Israele una delega con la quale si sentirebbe autorizzato ad attaccare”. E dunque, «gli Stati Uniti non possono subappaltare una decisione così importante a Israele», aveva ripetuto come un mantra l’ex segretario di Stato americano. L’America insomma ci riprova.
Una settimana prima - quale straordinaria coincidenza - era stato l’ex segretario di Stato americano e premio Nobel per la Pace Henry Kissinger ad affrontare la questione in una intervista al Washington Post. Secondo l’ex segretario dovrebbero essere soltanto dagli Stati Uniti a gestire la crisi con l’Iran poiché se non lo fanno, “darebbero a Israele una delega con la quale si sentirebbe autorizzato ad attaccare”. E dunque, «gli Stati Uniti non possono subappaltare una decisione così importante a Israele», aveva ripetuto come un mantra l’ex segretario di Stato americano. L’America insomma ci riprova.
Malgrado il sottofondo di smentite da entrambe le parti, secondo il New York Times il desiderio di negoziare è condiviso. Negli Stati Uniti molto vi ha influito l’impantanarsi della macchina bellica statunitense, poiché i forti legami degli ayatollah di Teheran con gli ayatollah di Najaf e con gli sciiti dell’Iraq (cioè con il 65 per cento della popolazione irachena) insieme ai tradizionali rapporti etnico-culturali tra i curdi iracheni e le popolazioni dell’Iran, lo stallo in Siria e, infine, la déblâche in Afghanistan hanno attenuato gli ardori imperiali degli Usa basati sulla forza.
Tuttavia non li hanno spenti anche perché per i potentati economici, la riconquista dell’Iran significherebbe prima di ogni altra cosa: controllare quasi completamente tutte le aree circostanti e, come abbiamo già detto, le risorse energetiche racchiuse tra il Golfo Persico e il Mar Caspio; mettere l’Europa e il Giappone, la Cina e l’India - gli attuali e futuri maggiori importatori e consumatori di idrocarburi - in una condizione di dipendenza dal nuovo assetto impostato da Washington.
Poi gli consentirebbe di tenere sempre sotto osservazione Russia, Cina, India e di esercitare un’influenza diretta sull’Asia centrale ex sovietica, sul mondo arabo e sul subcontinente indiano. Infine, l’Amministrazione a qualsiasi colore appartenga, potrebbe imporre con il supporto della potente comunità iraniana d’America la reintroduzione del modello monarchico e divulgare l’American lifestyle in un Paese che, per la sua millenaria peculiarità culturale, ha attratto popoli e civiltà in uno spazio che va dal Kashmir (la famiglia di Khomeni era originaria di quelle terre) al Mediterraneo (in particolare il Libano).
Se questo è nell’immaginario americano - l’ultimo confronto televisivo tra Obama e Rommey lo conferma - meglio si capisce la benevola rassicurante tolleranza del Pentagono nei confronti di Israele: «Diamo uno sguardo ai loro [israeliani] mezzi e alle loro capacità di fuoco, ci mettiamo nei loro panni e ci chiediamo come ci comporteremmo se avessimo quello che loro hanno. Così, mentre stiamo fantasticando ci facciamo un’idea di quello che possono e non possono fare», confidava il generale a cinque stelle al redattore del Foreign Policy.
 Beninteso non sono queste chiacchiere da salotto. E’ da un anno e più che il Centcom, il quale sovrintende le attività militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha il compito di studiare il possibile attacco israeliano all’Iran. I suoi funzionari si sono incontrati più volte nella sede Centcom di Tampa, in Florida, con gli ufficiali della Quinta Flotta della Marina a Doha, in Qatar, per confrontarsi sulle rispettive conclusioni.
Beninteso non sono queste chiacchiere da salotto. E’ da un anno e più che il Centcom, il quale sovrintende le attività militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha il compito di studiare il possibile attacco israeliano all’Iran. I suoi funzionari si sono incontrati più volte nella sede Centcom di Tampa, in Florida, con gli ufficiali della Quinta Flotta della Marina a Doha, in Qatar, per confrontarsi sulle rispettive conclusioni.
Quel che si è riusciti a sapere è che la “linea rossa” di Benjamin Netanyahu non li ha turbati più di tanto. Poiché, «questa è una questione politica, non è una questione di guerra. Pertanto non è nella nostra corsia. Stiamo soltanto preparandoci perché un attacco israeliano potrebbe arrivare in qualsiasi momento», ha spiegato l’ammiraglio in pensione Bobby Ray Inman.
Dopo tutto fu sempre Henry Kissinger a ricordare al mondo che «gli Stati Uniti hanno le armi migliori, abbiamo roba che nessun altra nazione ha, e useremo queste armi nel mondo quando sarà il momento giusto». Lo disse nel novembre dell’anno scorso durante un’intervista al giornale satirico inglese The Daily Squib suscitando non pochi clamori in Medio Oriente dopo che essa apparve anche su Al-Ahram il maggior quotidiano egiziano e del mondo arabo. Tant’è che è riemersa - dopo l’ uscita di Netanyahu sulla “linea rossa”- ed è stata stigmatizzata dalla stampa araba come una profetica minaccia. Perché da quelle parti non se l’immaginerebbero mai un Kissinger pervaso di humor, supposto che lo sia veramente.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Sarebbe troppo difficile (se non impossibile) tentare di analizzare le ragioni per cui un video musicale o una canzone pop prodotte in un paese dell'estremo oriente diventino un successo planetario e si diffondano per il mondo con una rapidità simile a quella di un'epidemia (non a caso, a questi prodotti culturali è uso riferirsi con l'aggettivo “virale”).
Qui ci basta rilevare che lo scorso agosto, una pop star sudcoreana di 34 anni, il cui nome d'arte è Psy (un diminutivo di “psicopatico”) ha creato una piccola canzone dance (in coreano) dal ritornello orecchiabile, cui è stato associato un video di fantasmagorica quanto intenzionale volgarità: un fatto la cui rilevanza e “notiziabilità” non sarebbero andate oltre, nella migliore delle ipotesi, il milieu musicale della Corea del Sud.
E invece ad oggi, oltre 400 milioni di persone di tutti gli angoli del mondo hanno visto online questo filmato, mentre testo e video vantano decine di imitazioni e parodie. L’autore di Gangnam Style (questo il nome della traccia), Bahk Jae Wan, è stato invitato a programmi televisivi negli Stati Uniti e vezzeggiato da spocchiose e levigatissime popstar occidentali. Un dato è certo: a giustificare un simile incredibile successo non è la qualità (invero bassina) del prodotto finito, né la prestanza fisica del simpatico performer, che difficilmente può essere definito un Adone.
Probabilmente, a scatenare il successo in patria è stato il tema che Psy ha trattato nel suo singolo: “Gangnam Style” è lo stile di vita degli abitanti di di Gangnam, un distretto caratterizzato dalla ricchezza dei suoi residenti, dove il prezzo delle proprietà immobiliari è il triplo della media nazionale. Il refrain che Psy ripete ossessivamente - ingenerando dipendenza anche nell'ascoltatore più scettico e raffinato - tradotto in italiano suona più o meno così: “è in arrivo il fratellone di Gangnam” (un termine con cui in Corea le donne si rivolgono ad un amico più anziano oppure, appunto, ad un fratello maggiore).
Alla base, come sempre, c'è un tema sessuale, dal momento che Bahk Jae Wan tesse le lodi di una donna che in pubblico sa essere raffinata come una dei quartieri alti, pur essendo capace di sfoderare un temperamento da tigre in contesti più intimi (ahimè, di questo si parla). Tuttavia, come osserva Onsemiro, blogger coreano (ma residente in Minnesota), la canzoncina si presta anche ad una lettura un po’ più elegante: in questo senso, Gangnam Style rappresenterebbe una satira che prende di mira i coreani “normali” che sognano un giorno di potersi permettere una casa ed una vita nel quartiere più “cool” della capitale.
 Lo stesso Psy, in una intervista alla CNN, ha dichiarato: “Chi viene davvero da Gangnam non lo dice mai esplicitamente; sono solo le persone che si atteggiano o i “vorrei-ma-non-posso” ad attribuire a sé stessi uno stile degno di quel distretto. In sostanza, con questa canzone ho voluto prendere in giro tutte le persone che si sforzano in ogni modo di essere ciò che non sono”. Non a caso, l'abbigliamento delirante, e le pose non sempre elegantissime esibite da Psy nella clip (ad un certo punto viene ripreso mentre rappa seduto sulla tazza del gabinetto) a tutto fanno pensare tranne ad una persona raffinata.
Lo stesso Psy, in una intervista alla CNN, ha dichiarato: “Chi viene davvero da Gangnam non lo dice mai esplicitamente; sono solo le persone che si atteggiano o i “vorrei-ma-non-posso” ad attribuire a sé stessi uno stile degno di quel distretto. In sostanza, con questa canzone ho voluto prendere in giro tutte le persone che si sforzano in ogni modo di essere ciò che non sono”. Non a caso, l'abbigliamento delirante, e le pose non sempre elegantissime esibite da Psy nella clip (ad un certo punto viene ripreso mentre rappa seduto sulla tazza del gabinetto) a tutto fanno pensare tranne ad una persona raffinata.
William Pesek, uno dei corrispondenti di Bloomberg dal Giappone, spinge la sua analisi sociale e psicologica ancora oltre. In un suo pezzo del 15 ottobre, spiega come i Coreani siano fieri di essere riusciti a riguadagnare gli standard di vita precedenti al 1997, quando la crisi finanziaria aveva quasi ridotto sul lastrico il paese.
Un obiettivo basato sulla realizzazione ed esportazione di prodotti finiti, che non è stato raggiunto senza rilevanti danni sociali: i lavoratori sudcoreani sono lavorano più di tutti i loro colleghi, mentre perfino i bambini passano più tempo in corsi privati e formazione extrascolastica che al parco giochi. “Sembra, insomma che i Coreani del Sud stiano finalmente comprendendo che l'aumento del prodotto interno lordo non ha necessariamente prodotto una nazione più felice: di cui il messaggio sovversivo di Psy, secondo cui l'appartenenza ad una classe sociale ed il benessere economico sono in fondo falsi dei”. Se una piccola canzone può aiutare, ben venga.
