Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
Il clamore ancora una volta si è scatenato intorno al mondo delle donne e del sesso mercenario. Il piatto succulento del gossip. Il centro benessere di Via Salaria e il lavoro generoso delle massaggiatrici sembrerebbe esser diventato l’argomento di punta delle contestazioni a Guido Bertolaso. Anche qui, come nel caso illustre del premier, del privato e delle abitudini erotiche degli uomini di potere, potrebbe non importare granché a nessuno, se non alle famiglie coinvolte. Quando le donne diventano però moneta corrente, un premio, un favore o una tangente, quando lo scambio sessuale è solo il segno tangibile di una circolazione sommersa di favori e relazioni poco onorevoli, allora esiste un problema che è tutto politico e che chiama in causa il peccato originario della corruzione.
Interessa quindi poco con chi si rilassa Bertolaso: a rendere dovute le sue dimissioni bastano i rapporti amichevole con gli sciacalli. Ma quando il prode Bertolaso dice di essere disposto a dimettersi solo se glielo chiederà il suo capo, esprime tutta la cultura - rilassata? - che ha del servizio pubblico. Roba loro è; se non lo fosse, se fosse al servizio del Paese, avrebbe avuto pochi denari, diverso percorso e diverso esito. La Protezione Civile Italiana, invece, proprio perché roba loro, ha conquistato negli ultimi anni un potere enorme e una straordinaria libertà d’azione. A reti unificate è stata spacciata la presunta neutralità/capacità di Bertolaso, incensato come sacerdote della sicurezza nazionale tanto dal governo come dall’opposizione, come sempre inerte e letargica. Peccato che oltre al tempismo dell’intervento in emergenza, con corredo di appalti fulminanti e costruttori sorridenti - come confermerebbero le intercettazioni sul caso del terremoto dell’Aquila - siano state disattese del tutto le opere di prevenzione. Le frane di Messina, per citarne solo alcune, fino ai recenti episodi dei paesi circostanti, ne sono purtroppo l’ennesima amara conferma.
Il Bertolodo, come già lo chiamano, è la riproduzione caricaturale di una pantomima di governo cui siamo già abituati. Condottieri integerrimi assediati da uomini sbagliati e da giudici faziosi. Brave persone in pasto ai comunisti togati. Gare fantasma necessarie alla conservazione del potere. Potere che deve essere assoluto, al di sopra della legge; intoccabile per essere efficiente ed efficace contro lo Stato lento e ostaggio dei partiti. Questo ha raccontato la propaganda televisiva mentre sui morti caldi qualcuno, così pare, disegnava già la ricostruzione dell’Aquila aumentando gli zeri del proprio conto in banca.
Il business principale é rappresentato dalla trasformazione di ogni intervento pubblico - ricostruzione e grandi eventi - a questione in capo alla Protezione Civile. In nessun'altro Paese del mondo é così, ma nessun'altro Paese ha questo governo. Senza controlli della magistratura contabile, senza i lacci delle gare pubbliche, mascelle allenate all'alta voracità hanno visto il modo per avere "il Paese in mano". Quella degli appalti pubblici e delle grandi opere, insieme alla sanità privata e alle commesse all'estero, é dunque il grande collettore della corruttela pubblica e privata; rappresenta, in tutta evidenza, la relazione tra politica e affari, laddove per politica s'intendono i padrini dell'emergenza e per affari i bilanci dei macabri nottambuli telefonici, i mascalzoni delle fatture immaginate sulla contabilità della disperazione.
Un altro esempio é stata La Maddalena, prima circuita e poi abbandonata dalla banda degli onesti: solo una delle manifestazioni tangibili di come lo scempio sia il core business dei presunti imprenditori. E mentre L’Aquila e la sua provincia ancora aspettano il raggiungimento minimo della percentuale di aiuti promessi, c’è chi si rilassa entrando dalle porte sul retro. Le indagini in corso, che sembrerebbero individuare un intreccio sordido tra il Mangiafuoco degli appalti dei Grandi Eventi della Protezione civile, l’imprenditore Anemone, e i ringraziamenti “megagalattici” organizzati per sdebitarsi con Guido Bertolaso, dovrebbero bastare, per pudore, a sospendere per sempre il decreto del governo sulla trasformazione della Protezione Civile in SpA.
La norma, ha comunicato Fini ieri sera, é stata stralciata. Del resto, persino il gran visir del governo, Letta, aveva suggerito alcune modifiche di sostanza al provvedimento di privatizzazione. Vedremo se verrà ripresentata con un clima più propizio o definitivamente abbandonata, la voracità delle ‘ndrine degli amici spesso supera la decenza. Sarà bene quindi vigilare. Ma l'importante non é solo evitare la trasformazione in S.p.a. della protezione civile: é altrettanto importante che essa sia ricondotta alle funzioni istituzionali cui é predisposta, non permettendo che venga trasformata in una società edilizia per ogni opera, grande o piccola che sia; si deve riconsegnarla alle verifiche ed ai controlli della Corte dei Conti. Le emergenze declinate come eventi diventerebbero altrimenti la tavola imbandita degli appalti e dei profitti e, ogni prevenzione di disastri, un inutile quanto furbo trapasso di denaro pubblico verso agli affari privati. Le risate sadiche nella notte del sisma ci hanno già dato l’idea del gusto che hanno gli affari della morte.
Il decreto che ora é stato stralciato, permetteva non a caso di bloccare ogni azione giudiziaria fino al 31 gennaio 2011, oltre a bloccare tutte quelle pendenti. Vedremo cosa verrà fuori dall'inchiesta della magistratura. vedremo se avranno ancora voglia di ridere sui cadaveri che diventano business. Quello della banda Anemone é un sorriso che viene dall’inferno e vederli marcire in galera sarebbe una paga buona per simili esseri. Quella invece di vigilare affinché l'inchiesta non faccia sconti è un’occasione di lotta che un’opposizione sveglia non dovrebbe perdere: per cantarle chiare non serve Sanremo. Serve invece mobilitare il Parlamento e le piazze per un’emergenza nazionale. La prima senza Bertolaso.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
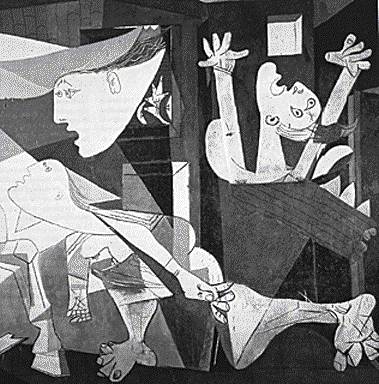 di Giovanni Cecini
di Giovanni Cecini
Disse Emile Zola nel suo J’accuse: «E’ un delitto sfruttare il patriottismo ai fini dell’odio». Ebbene la storia è piena zeppa di uomini, fatti e comportamenti che hanno commesso azioni delittuose in questo senso. La retorica patriottica, nobile quanto genuina in moltissimi casi, diviene un’arma micidiale quando si trasforma in egoista e becero nazionalismo. In tutti i Paesi del mondo esiste questa piaga, anche perché in un contesto sempre più multietnico e globalizzato, quei confini identitari e culturali appaiono più flebili e incerti. I colori nazionali, se mai fossero stati pieni e brillanti, sono ormai sfocati a seguito di migrazioni, conquiste, annessioni e dichiarazioni d’indipendenza.
L’Italia non è indenne da questo fenomeno, se anch’essa dopo secoli di fratture interne e invasioni straniere si è cimentata - una volta unita e indipendente - in una propagandistica azione d'imperialismo sfrenato. A partire dai governi liberali a cavallo tra ‘800 e ‘900, fino alla catastrofe dell’esperienza fascista, Roma si pose come obiettivo quello di realizzare un sogno mitico. Per questo ha iniziato ad assoggettare altri popoli e Nazioni, col tempo anche lontani per storia e cultura a una possibile comunanza di idem sentire italico.
Da queste premesse può partire un discorso pacato e riflessivo sul significato del Giorno del Ricordo, che cade il 10 febbraio, data in cui venne firmato il Trattato di Parigi del 1947, che assegnò a Belgrado i territori occupati durante il conflitto dalle armate di Tito. La ricorrenza venne istituita dallo Stato italiano nel 2004, per offrire rispetto e memoria ai tanti connazionali vittime di violenze nel contesto del confine orientale alla fine della Seconda guerra mondiale.
La geopolitica della regione, che sin dall’esperienza asburgica era stata aggravata dalle innumerevoli differenze etnico-culturali, dimostra come sia molto difficile distinguere le popolazioni più affini a un contesto latino piuttosto che a quello slavo. Sta di fatto che tra il 1919 e il 1947 in tale zona si è andando consumando uno stillicidio di brutalità, dove le cause e gli effetti si confondono a vicenda, non senza strascichi ideologici fino ai nostri giorni.
Per questi motivi, anche a fini politici, la risposta slovena non si è fatta attendere, se nel 2005 Lubiana ha istituito la giornata del 15 settembre come Festa nazionale del ritorno del Litorale alla madrepatria. Le polemiche incrociate non sono mancate e, ancora oggi, un certo attrito permane non tanto tra i due Paesi, quanto tra le due sensibilità interne, che spesso interpretano la logica delle rispettive ricorrenze come un ulteriore strumentalizzazione a quel nazionalismo di cui si è parlato all’inizio.
Una riflessione serena e risolutiva di questi contrasti, che investirebbe in casa nostra tutti i partiti senza distinzione di colore e collocazione, dovrebbe portare alla piena legittimazione del Giorno del Ricordo, al pari della Festa della Liberazione, come un momento di saggia riflessione morale e politica. Consapevoli dello sprezzo aggressivo del fascismo operato nei territori jugoslavi, è giusto, oltre che doveroso, offrire rispetto alle migliaia di cittadini italiani uccisi per le colpe dello Stato dittatoriale di cui facevano parte.
La Prima guerra mondiale e la pace di Parigi nel 1919, pur tra mille contraddizioni, aveva consegnato all’Italia terre e popolazioni affini alla Penisola, che nessun crimine fascista può rendere responsabili, tanto da meritare una condanna a morte così brutale come quella inferta nelle foibe. Parimenti l’invasione e il saccheggio che le Forze armate di Mussolini hanno perpetrato nei Balcani permettono di comprendere, una volta che gli aggressori siano stati scacciati, il diritto degli sloveni e dei croati di un riconoscimento e di un riscatto nazionale anche territoriale.
Le clausole firmate a Parigi del 1947, entrate in vigore appunto il 15 settembre, non vollero essere giuste, se per giustizia intendiamo il riconoscimento oggettivo dei diritti di cittadinanza. Esse vollero essere la risposta e la lezione offerta a un Paese, come l’Italia, che nella sua megalomania non si era accontentato di annettersi degli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e delle isole dalmate, ma pretendeva anche di sopraffare uomini e donne che mai si erano sentiti legati alla Patria di Dante, Raffaello, Mazzini e Garibaldi. In questo senso è inappellabile la decisione che ha portato i dalmati, i giuliani e gli istriani a trovarsi sotto la sovranità della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Ben inteso, altra cosa è invece lo scempio fatto su queste stesse popolazioni, vessate oltre misura perché giudicate diverse o perché pedissequamente definite fasciste in quanto italiane. Ecco perché non deve e non sembra accettabile vedere la Giornata del Ricordo e la Festa del Litorale come alternative, in opposizione e in contrasto tra di loro, tanto da generare a vicenda recriminazioni, ripicche e offese reciproche, generate da enfasi ideologiche.
E’ ovvio che le ragioni di politica diplomatica mal si conciliano con le ragioni del cuore e dei sentimenti, ma è vero pure che a oltre sessanta anni di distanza, a maggior ragione in un contesto di integrazione europea, le decisioni prese nella capitale francese alla fine di un trentennio di odi viscerali furono l’unica risposta dopo una guerra infame e totalizzante. Per tutti questi motivi sarebbe quindi opportuno e legittimo che le città di Gorizia, Trieste, Pula, Rijeka e Postojna (o in qualsiasi altra forma linguistica le si voglia chiamare) fossero accomunate oggi e per l’avvenire da un sentimento comune europeo e non da uno sciovinismo dietrologo pari a quello onomastico sul chiamare Londonderry o semplicemente Derry la città dell’Irlanda del Nord.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Ci è voluto quasi un anno ma, alla fine, inesorabile, la scure di Maria Stella Gelmini si è abbattuta anche sulle scuole superiori. Lo scorso giovedì il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera ai tre decreti che a partire dal prossimo anno scolastico rivoluzioneranno (in peggio) i licei, gli istituti professionali e quelli tecnici. Tutti i tagli agli orari sono stati confermati e anche lo smembramento delle sperimentazioni ha avuto atto: seppure i licei rimarranno sostanzialmente inviolati - fatta eccezione per i nuovi licei delle scienze umane e musicali - sull’altare sacrificale del bilancio sono finiti gli istituti di settore, spolpati degli indirizzi e ridotti ad affidarsi a stage con aziende private.
Non sono quindi valse a nulla le proteste e gli scioperi che durante tutto l’anno scorso hanno infiammato il settore scolastico: secondo la ministra, fresca di nozze, la sua è una “riforma epocale” grazie a cui il nostro disastrato paese potrà avvicinarsi agli standard richiesti dall’Unione Europea.
Peccato che, in realtà, le modifiche predisposte per il nostro ordinamento scolastico, oltre a non tenere in minimo conto le trasformazioni sociali e culturali che interessano questa velocissima generazione di ragazzi, siano ben lontane dalle eccellenze svedesi o tedesche. Il più macroscopico punto debole dell’epocale riforma sta infatti nel drastico taglio agli orari, non solo delle lezioni ma anche di funzionamento dei plessi scolastici. Pare infatti che la ministra, nella sua spasmodica ricerca di perfezione storica, abbia grossolanamente tralasciato l’assunto fondamentale secondo cui l’orario delle lezioni non è lo stesso dell’orario scolastico. Tagliando quest’ultimo si produce l’inevitabile riduzione del tempo in cui gli studenti potranno fruire di strutture didattiche come palestre, biblioteche, teatri e laboratori: secondo il modello europeo questi apparati sono il naturale corollario ad un tempo scolastico che non è, e non deve essere, solo quello dell’apprendimento frontale, tant’è che la maggior parte delle attività didattiche si consuma e si sviluppa proprio in questo segmento.
Se infatti pensiamo che nella stragrande maggioranza dei sistemi educativi comunitari il tempo pieno è una risorsa grazie alla quale poter organizzare e veicolare il tempo libero dei ragazzi, mal si capisce come mai Berlusconi - immancabilmente presente all’illustrazione dei provvedimenti - abbia sottolineato come “l’Italia avrà delle scuole comparate a quelle degli altri Paesi europei e saranno in linea con gli istituti dei paesi più avanzati”. Non importa, infatti, che le attività organizzate nell’orario fuori dalle lezioni siano di stampo culturale, di approfondimento disciplinare o di semplice svago; nei tanto decantati modelli europei la scuola è un’istituzione in grado di trasmettere significati e comportamenti in un ambito protetto e di valorizzare quelle che, mano a mano, emergono come eccellenze o semplici competenze.
Per i ragazzi italiani, chiamati sempre più insistentemente a uniformarsi ai criteri di preparazione d’oltralpe, questa scuola non ha invece praticamente nulla da offrire a meno che essa per prima non venga presentata come un’istituzione credibile, capace di tradurre quelli che sono gli insegnamenti impartiti in comportamenti civici. Che sia forse per ovviare a questa “obsoleta” funzione che dai licei, da sempre fucine della futura classe dirigente, è stato cancellato l’insegnamento di diritto?
In ogni caso, la diminuzione dell’orario scolastico in Italia significherà un sostanziale imbarbarimento delle nuove leve generazionali: costretti ad autorganizzarsi, gli adolescenti nostrani saranno inevitabilmente portati ad assimilare comportamenti non codificati, a riunirsi nei famigerati branchi o, al meglio, a lobotomizzarsi su siti di social networking o di altre amenità, col risultato che gli atteggiamenti prenderanno ad essere sempre più discostati dalla società civile, sopraffatti dall’irragionevolezza di messaggi commerciali (come quelli del marchio Diesel che trionfanti ti impongono un “Be Stupid”) e impoveriti dal linguaggio becero delle tv pomeridiane.
Non stupiamoci allora se i nostri ragazzi sono il fanalino di coda di Eurolandia: le indiscutibili competenze di un avvocatessa che gioca a fare la ministra premaman, non hanno tenuto in debito conto i soggetti ai quali la riforma è rivolta. Soggetti che hanno subito mutazioni repentine sia nell’aspetto che nella sostanza, giovani adolescenti dai comportamenti sempre più adulti e praticamente privi di una qualsiasi mediazione che non sia quella data dall’autoformazione, spesso e volentieri traviante.
Ma i giovani italiani diventano un problema solo quando taglieggiano i compagni, danno fuoco a poveri barboni “per vedere l’effetto che fa”, o vendono il proprio corpo in cambio di ricariche o vestiti firmati. Questa è la politica governativa per la scuola: piangere sul latte versato in settant’anni di fallimenti didattici. Nel frattempo le decine di migliaia di insegnanti condannati dalla riforma a lasciare le loro cattedre, aspettano a braccia conserte di essere cancellati dalla pubblica istruzione come segni di gesso sulla lavagna.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Nicola Lillo
di Nicola Lillo
“L’alternativa per una nuova Italia”. Si è aperto con questo slogan il congresso dell’Italia dei Valori, iniziato il 5 febbraio e terminato ieri con la conferma a presidente del partito di Antonio Di Pietro. Una nuova Italia che, in realtà, sembra conformarsi alla precedente. Vittoria inizialmente scontata per l’ex pm, poi confermata dopo il ritiro dello sfidante Barbato. “Siamo pronti a un altro governo per il Paese. Abbiamo fatto resistenza, resistenza, resistenza che ci voleva a un regime piduista, ma ora siamo alla svolta. Siamo pronti al governo”, ha detto Di Pietro, prendendo la parola dopo la conferma per acclamazione. “La piazza non basta. E' finito il tempo della sterile protesta e comincia quello della grande responsabilità di governo che vogliamo”. Il partito “dovrà ora mettere in campo un'azione politica di contrasto e anche di stimolo al governo”.
Parole che non hanno fatto attendere la risposta polemica di Pier Ferdinando Casini: “L'Italia dei Valori è un macigno su qualsiasi alternativa credibile a Berlusconi. Persino Di Pietro - osserva il leader dell'Udc - si rende conto che la posizione dell'Idv è sterile e non porta da nessuna parte”. Ma oltre ai battibecchi e alle solite “frecciate”, il Congresso ha dato qualche spunto su cui riflettere.
Di Pietro ha ribadito di essere pronto a passare la mano fra qualche anno, ma che in questa fase c'è ancora bisogno della sua leadership: “Sento il dovere di continuare a tenere il timone di questa nave finché non arriva in un porto sicuro. Aiutatemi a portare a questa barca alla riva e, dopo di che, io non vedo l'ora di tornare un po' alla mia masseria”. “Porterò questa nave dell'Italia dei valori - ha aggiunto - insieme ai comandanti delle navi della flotta del centrosinistra al 2013 per riconquistare il governo; dopo, mi chiamate come socio onorario e dovrete fare da soli”.
Quello che ha stupito è stato però il tema regionali. Il leader dell'Italia dei Valori ha ribadito la possibilità di trovare un accordo con Vincenzo De Luca, candidato del Pd alla Regione Campania, a patto che accetti “una serie di paletti”. De Luca, intervenuto al congresso e applauditissimo, afferma: “Non possiamo non combattere insieme questa battaglia”. Il risultato è un ossimoro: l’Italia dei Valori appoggia un candidato due volte rinviato a giudizio per reati gravissimi, cioè concussione, associazione per delinquere, falso e truffa. Sicuramente un errore per Di Pietro, che dopo questa apertura al PD potrebbe perdere un po’ di fiducia da parte dell’elettorato.
E’ frutto di una circostanza che nasce da una situazione di stallo. In Campania, infatti, il Pdl ha avanzato la candidatura di Caldoro, craxiano e non lontano da Cosentino e Cesaro. Il Pd sorregge De Luca, che inizialmente non è appoggiato dall’Idv. Ma, causa fermezza del Partito Democratico nella propria decisione, Di Pietro non ha fatto altro che cadere nel ricatto che gli si poneva dinanzi. O De Luca, o la Campania al Pdl. L’errore dell’opposizione è comunque a monte. I Bassolino, Sandra Mastella e tutti gli scandali sorti negli ultimi anni, non hanno fatto muovere un dito al partito di Bersani. Questo lassismo ha portato alla candidatura di un plurinquisito. Unica voce fuori dal coro dei sì, ululati al congresso, è l'europarlamentare dell'Idv, Luigi De Magistris, secondo il quale “la Campania ha bisogno di altro, non di De Luca”.
Ma l’appuntamento al congresso riserva altri scossoni e, di conseguenza, altre critiche. Gioacchino Genchi, il consulente informatico delle più importanti procure d’Italia (lavorò con Falcone, Borsellino e in ultimo con De Magistris), avrebbe infatti affermato che “nel lancio della statuetta del duomo di Milano a Berlusconi non c'è nulla di vero”. Per poi precisare: “E' evidente che il mio intervento di oggi è stato totalmente frainteso. Le mie parole, infatti, non facevano alcun riferimento alla dinamica dell'attentato e non intendevano affatto metterne in dubbio la veridicità. Mi riferivo, in realtà, a quanto accaduto immediatamente dopo: ovvero, al fatto che la scorta del presidente del Consiglio non abbia provveduto con tempestività e immediatezza ad allontanare il premier da quella situazione di grave pericolo”.
Ma è comunque bufera. Il tema sembra infatti essere un “tabù”, nonostante le voci, i dubbi, i filmati che si sono susseguiti sul web per diversi giorni. Nessuno può parlarne. Ma a rilanciare le sue dichiarazioni è stato, ancora, Luigi De Magistris, per il quale “la magistratura deve fare approfondimenti seri. Come dissi subito - afferma - ci sono aspetti che non mi convincono, ma non credo sia utile aprire una polemica politica. Vero è - aggiunge - che dopo quell'episodio non si è più parlato di vicende di Berlusconi e questa è la cosa grave”.
Risponde pronto il Pdl, con il suo portavoce Daniele Capezzone: “E' inaudito che si sollevino ombre su un attentato che avrebbe potuto uccidere Silvio Berlusconi. Sorge il dubbio che qualcuno desideri un altro caso Tartaglia”. Si accoda Gasparri, che annuncia “un'interrogazione urgente per sapere se il capo della Polizia Antonio Manganelli si avvale ancora della collaborazione di un personaggio del genere nel dipartimento della Pubblica Sicurezza. Se così fosse la cosa sarebbe sconcertante e non priva di conseguenze”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Alla fine gli altarini sono stati scoperti, e mai come ora una locuzione del genere è stata più appropriata. La storia la conosciamo ormai tutti: l’affaire Boffo è scoppiato come una bomba lo scorso 28 agosto, quando il prezzolato neo direttore de Il Giornale, Vittorio Feltri, accusò in prima pagina il direttore dell’Avvenire di essere “un noto omosessuale già attenzionato dalla Polizia” in virtù di una sentenza risalente all'agosto del 2004, in cui Boffo è stato condannato a pagare una multa di 516 euro a causa di reiterate igiurie e molestie telefoniche. Sei giorni dopo la pubblicazione della velina - di per sé già alquanto datata, dal momento che la prima versione risale al 2005 - Boffo lascia la direzione del giornale dei vescovi senza nemmeno una pacca sulla spalla, ma anzi sollecitato da ben più d’uno di quei porporati che in 20 anni di redazione aveva rispettosamente ossequiato.
Il polverone scatenato da Il Giornale si è chetato nel giro di poco tempo e, sebbene in molti avessero espresso ragionevoli dubbi sulla buone fede delle fonti di Feltri, è stato solo il 4 dicembre che il direttore si è pubblicamente scusato con il collega, titolando un editoriale “Su Boffo scandalo infondato”. Un autogol che a un qualunque giornalista professionista costerebbe come minimo la cancellazione dall’albo - il povero Alberto Castagna, era stato estromesso per molto meno - ma che al grande vecchio di via Negri ha fruttato solo qualche cenno di biasimo.
Sembrava che ormai la storia fosse finita, che questo brutto capitolo di giornalismo fosse definitavamente archiviato negli annali riservati al cattivo gusto. Questo fino ad un paio di giorni fa, quando Feltri è tornato a soffiare sul fuoco della polemica, fornendo a Il Foglio di Giuliano Ferrara l’identikit della famigerata fonte vaticana, rea di aver creato cotanto patatrac: “Una personalità della Chiesa di cui ci si deve fidare istituzionalmente” e di cui “non si poteva perciò dubitare”. Che questa evanescente fonte primaria fosse il direttore dell’organo ufficiale vaticano, l'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, sono stati in molti in questi giorni a ventilarlo.
La ragione di ciò risiederebbe nelle lotte intestine della Curia per l’affermazione delle nuove linee politico-pastorali: da mesi, infatti, sotto il Cupolone si sta consumando un duello serratissimo tra le posizioni progressiste dell’ex presidente della Cei, Camillo Ruini, e quelle più intransigenti del Segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone. Proprio lui sarebbe il “Sua Eccellenza” cui era indirizzata la nota informativa giunta nelle mani avide di Feltri; e, se a ciò si aggiunge il fatto che lo stesso Vian firmi da tempo articoli filogovernativi su Il Giornale sotto lo pseudonimo di Diana Alfieri, ben si capirà come mai buona parte dei commentatori abbia individuato nell’anomala coppia le figure papaline tirate in ballo tardivamente da Feltri. Ad ulteriore conferma delle illazioni della carta stampata, arriva poi la secca smentita del cardinale prefetto della Congregazione dei Vescovi, monsignor Giovanni Battista Re, che a La Repubblica bolla le rivelazioni di questi giorni come “una squallida manovra ordita da chissà chi per coprire la vera fonte ispiratrice”.
Trovati i personaggi, resta ora da ricostruire il movente dell’attacco a Boffo. La fonte ispiratrice menzionata da monsignor Re potrebbe essere in realtà un Giano bifronte. Il caso Boffo aveva infatti inevitabilmente evidenziato gli attriti tra Governo e Chiesa, seguiti allo scandalo che aveva coinvolto Berlusconi, la diciottenne Noemi Letizia e una folta schiera di giovani manze orbitanti tra Palazzo Chigi e Villa Certosa. Pare perciò più che plausibile che l’attacco all’ex direttore di Avvenire sia stato in realtà un’azione involontariamente concertata: da una parte il Presidente del Consiglio che aveva organizzato sul giornale di famiglia una macelleria mediatica contro chiunque (dall'ex moglie Veronica, all’alleato Fini, per arrivare anche al Boffo che, rispondendo alle lettere dei suoi confusi lettori, si portava inevitabilmente sulle posizioni dell’opposizione) abbia provato a calcare la mano sulle sue senili frivolezze; dall’altra il Vaticano, che aveva bisogno di rendere credibile l’atteggiamento fin troppo indulgente rivolto ad una figura istituzionale che, per quanto deprecabile negli atteggiamenti, è pur sempre un ottimo ricettacolo di rivendicazioni curiali.
Boffo insomma, con una sola mossa era riuscito a mettersi contro due dei più influenti centri di potere italiani e la nota del casellario giudiziario, pervenuta prima sulle scrivanie di oltre duecento vescovi e poi su quella di Feltri, ha avuto risvolti positivi per entrambe le parti in causa: Boffo si è dimesso lasciando il giornale dei vescovi in mani più malleabili, la Curia ha screditato la fazione Ruiniana rappresentata dall’Avvenire ed ha perciò ampliato lo spazio di manovra del braccio destro di Ratzinger - il segretario Bertone appunto - mentre il nostro caro Padron’ Silvio l’ha sfangata con la solita buona dose di vittimismo.
Allo stato attuale dei fatti è ancora però d'obbligo l'uso del condizionale. Il prossimo 22 febbraio Vittorio Feltri dovrà rispondere all'Ordine dei Giornalisti lombardo sulla sua pessima deontologia professionale, e sarà forse in quella sede che buona parte dell'intricato puzzle potrà risolversi. Per chi invece crede che in questa vicenda non ci sia solo la mano del Vaticano, basteranno le parole con cui l'ex direttore di Il Giornale, Mario Giordano, si accomiatò dai suoi lettori il 21 agosto: "Nelle battaglie politiche non ci siamo mai tirati indietro (...) Ma quello che fanno le persone dentro le loro camere da letto (siano essi premier, direttori di giornale, editori, ingegneri, first lady o avvocati) riteniamo siano solo fatti loro. E siamo convinti che i lettori de Il Giornale non apprezzerebbero una battaglia politica che non riuscisse a fermare la barbarie e si trasformasse nel gioco dello sputtanamento delle rispettive alcove". Il timido Giordano aveva deciso di tirarsi indietro, di non avvallare quel gioco sporco in cui lo stesso premier stava sguazzando. Il vecchio Feltri, da brava volpe del giornalismo nostrano, è fatto di tutt'altra pasta.
