- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
La sintesi dell'ambiguità italiana è tutta nell’ "errore" del Financial Times del 12 novembre. Quando, sulle pagine del giornale cartaceo più letto da Wall Street, viene pubblicato un articolo dove si sostiene che i mercati obbligazionari stanno già scommettendo sulla bancarotta "delle tre economie più deboli della zona euro: la Grecia, l'Italia e il Portogallo". C'è anche il grafico che evidenzia i picchi di rendimento dei Btp decennali italiani rispetto ai Bund tedeschi, cioè quanto il debito pubblico italiano sia percepito come più rischioso di quello tedesco. Poi lo stesso articolo viene pubblicato sull'edizione on-line e, sorpresa, le tre economie europee più deboli sono indicate (correttamente) come Irlanda, Portogallo e Grecia. Niente Italia quindi.
Si tratta di un errore dunque o forse c'è qualcosa di più? Appare infatti ai più maliziosi qualcosa di più di un refuso; assomiglia a un lapsus freudiano. Perché l'Italia non sarà tra le tre economie più fragili, ma in molti cominciano a pensare che arrivi subito dopo. Anche ieri il differenziale di rendimento tra Btp e Bund ha toccato un nuovo record da quando esiste l'euro e, quindi, da quando i diversi debiti pubblici sono apprezzati nella stessa valuta, eliminando gli effetti del cambio di valuta: 1,91%, poi sceso di poco.
Segno che gli investitori sono un po' nervosi riguardo l'Italia che, sei mesi dopo il panico finanziario innescato dalla Grecia, sembra molto più fragile: nel mezzo di una crisi politica, con stime di crescita del Pil dimezzate rispetto a un anno fa (all'1% annuo, se tutto va bene) e che si scopre più fragile del previsto, tutta protesa nel decidere come spendere miliardi di euro con la correzione al maxi-emendamento alla finanziaria mentre gli altri paesi insistono con ulteriori risanamenti.
Un segnale concreto è arrivato dall'asta del 12 novembre dei titoli di Stato italiani. La domanda degli investitori è rimasta alta, ma è stato alto anche il prezzo di vendita: per i Btp a 15 anni, per esempio, i tassi da riconoscere ai sottoscrittori sono saliti dal 3,98% al 4,81%. Conseguenza: il macigno del debito pubblico da ieri è un po' più pesante da portare per l'economia italiana. Lato positivo: secondo le stime degli analisti di Unicredit, nel 2010 restano soltanto altri 10 miliardi di euro di debito da piazzare sul mercato. Quindi, almeno per ora, non ci sono grossi rischi. Ma è solo una tregua.
 Il fondo europeo di salvataggio per gli Stati, come la Grecia ieri e l'Irlanda oggi, che faticano troppo a trovare credito a prezzi accettabili, scatterà solo per il debito emesso a partire dal 2013. La notizia è arrivata ieri a Bruxelles dal G20 di Seoul, dal quale la linea tedesca di rigidità estrema è uscita sconfitta ed ha riportato un po' di normalità: per ora sembra archiviata l'ipotesi del cosiddetto haircut, cioè l'idea che i detentori del debito pubblico di uno Stato in bancarotta vengano risarciti solo in parte dagli interventi di salvataggio, pagando quindi comunque un prezzo per aver sostenuto uno Stato sovrano attraverso l'acquisto dei suoi titoli pubblici.
Il fondo europeo di salvataggio per gli Stati, come la Grecia ieri e l'Irlanda oggi, che faticano troppo a trovare credito a prezzi accettabili, scatterà solo per il debito emesso a partire dal 2013. La notizia è arrivata ieri a Bruxelles dal G20 di Seoul, dal quale la linea tedesca di rigidità estrema è uscita sconfitta ed ha riportato un po' di normalità: per ora sembra archiviata l'ipotesi del cosiddetto haircut, cioè l'idea che i detentori del debito pubblico di uno Stato in bancarotta vengano risarciti solo in parte dagli interventi di salvataggio, pagando quindi comunque un prezzo per aver sostenuto uno Stato sovrano attraverso l'acquisto dei suoi titoli pubblici.
In compenso, la Germania di Angela Merkel è riuscita a moderare un po' la linea americana al G20: dal comunicato finale del vertice sono scomparsi i riferimenti ai tetti ai surplus commerciali. Tradotto: visto che Washington vuole che la Cina esporti di meno ma non riesce a convincerla a rivalutare drasticamente lo yuan, la sua moneta sovrana, per rendere le sue merci più costose rispetto quelle americane, sperava di ottenere l'impegno a limitare volontariamente l'export. Invece niente: la Repubblica Popolare Cinese rimane l’unico soggetto a poter determinare la propria politica economica e monetaria.
Il G20 s'impegna solo a vigilare sugli eccessi di volatilità delle monete e a condannare le svalutazioni competitive. In pratica una disapprovazione ufficiale della politica monetaria degli Stati Uniti che continuano a stampare dollari per sostenere la propria economia, mettendo però a soqquadro il mercato delle materie prime che è (ovviamente) quotato in dollari e danneggiando le economie emergenti come il Brasile che vedono le loro monete rafforzarsi indebitamente rispetto al dollaro, così che i loro prodotti da esportazione diventano meno competitivi.
 L'Italia, in tutto questo, si limita a fare da spettatore. E il Ministro degli Esteri Franco Frattini deve constatare: "L'impegno italiano di molti altri paesi contro le speculazioni internazionali è serio, ma c'è il problema sul regime dei cambi e come si è visto né gli Stati Uniti né la Cina sono in condizioni di risolverlo ora". L’unica sicurezza concreta per l'Italia è che l'Euro resta forte, scambiato a $ 1,37, nonostante le difficoltà di molti Stati dell'euro zona. Le esportazioni italiane, quindi, non vengono aiutate dal tasso di cambio, che le rende più costose sui mercati mondiali.
L'Italia, in tutto questo, si limita a fare da spettatore. E il Ministro degli Esteri Franco Frattini deve constatare: "L'impegno italiano di molti altri paesi contro le speculazioni internazionali è serio, ma c'è il problema sul regime dei cambi e come si è visto né gli Stati Uniti né la Cina sono in condizioni di risolverlo ora". L’unica sicurezza concreta per l'Italia è che l'Euro resta forte, scambiato a $ 1,37, nonostante le difficoltà di molti Stati dell'euro zona. Le esportazioni italiane, quindi, non vengono aiutate dal tasso di cambio, che le rende più costose sui mercati mondiali.
Il problema principale per l'Italia, infatti, resta quello della bassa crescita che, in prospettiva, rende più difficile sostenere il peso del debito. I parametri in base ai quali si decide oggi della vita e della morte delle nazioni sovrane sono infatti i rapporti debito/Pil (in Italia al 116%) e deficit/Pil (in Italia al 5,1%). Quindi se il Pil va giù il rapporto schizza alle stelle ed il nostro paese entra nel mirino degli speculatori.
Il Pil, dice l’Istat con gli ultimi dati, non crescerà più dell'1% nel 2010. E mentre il debito continua a crescere, le entrate si confermano in calo: -1,8%, dice Bankitalia nell’ultimo bollettino con il Tesoro che cerca come sempre di ridimensionare. Se a questo si aggiunge che dopo le prime analisi i tecnici della Camera stanno già mettendo in dubbio l'esistenza reale dei soldi che il governo vuole spendere con la finanziaria e che, elezioni o meno, c'è il rischio che la politica economica italiana resti congelata per molti mesi, si capisce perché, forse, quello del Financial Times più che un refuso, somigli ad un'anticipazione.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Ilvio Pannullo
di Ilvio Pannullo
Sono state diverse, ultimamente, le giornate difficili per i mercati. Piazza Affari di umore nero, perde nettamente più delle altre Borse continentali, complici alcuni spunti negativi e la debacle del comparto bancario, afflitto da alcune trimestrali non entusiasmanti e da rinnovati timori sul debito sovrano di alcuni paesi periferici. L'indice Ftse Mib cede il 2,41%, l'All Share il 2,15%. Ad innescare nuovamente la speculazione è la sua eccezionale redditività: sparare a zero sugli Stati e scommettere sul disastro è troppo vantaggioso. Chi può specula e vince, mentre il resto del mondo assiste impotente a questo gioco al massacro.
La storia è sempre la stessa: i mercati sono stati scoraggiati dalla speculazione sui titoli di Stato di alcuni paesi il cui debito pubblico è considerato troppo alto, come Portogallo, Grecia e Irlanda. A contribuire al clima da fine impero sono le politiche monetarie statunitensi. Le parole, infatti, sono importanti, soprattutto quando a pronunciarle sono i banchieri centrali.
La Federal Reserve americana ha deciso mercoledì 3 novembre di dare il via alla seconda ondata di “ quantitative easing". Il termine - di origine ovviamente anglosassone - si traduce in italiano con alleggerimento quantitativo ed indica la creazione di moneta da parte della banca centrale e la sua iniezione, con operazioni di mercato aperto, cioè effettuate direttamente in borsa, nel sistema finanziario ed economico. È essenzialmente il processo attraverso il quale un istituto monetario aumenta la base monetaria attraverso la stampa (termine non esatto, dato che oggi l'immissione avviene in forma elettronica) di nuova moneta. I tecnocrati la considerano una politica monetaria non convenzionale. Nella realtà l’operazione rende esplicito il problema del cosiddetto reddito monetario, ossia il guadagno che un istituto autorizzato per legge ad emettere moneta può ottenere dalla mera stampa di banconote.
L'espressione, all'apparenza freddamente scientifica, nasconde l'ultima mossa disperata dell’establishment americano: la Fed comprerà i titoli del debito pubblico americano semplicemente stampando denaro, ossia attraverso lo sfruttamento grossolano del cosiddetto signoraggio bancario. Gli Stati Uniti potranno così mantenere il rapporto deficit/Pil al 13% (superiore a quello della Grecia) confidando nel fatto di potersi comunque indebitare a bassi tassi attraverso l'emissione di obbligazioni. Perché ci sarà sempre la Federal Reserve pronta a comprare. Non viene creata ricchezza con la produzione industriale, con l'edilizia o la fornitura di servizi. Si crea solo moneta per comprare debito. Un debito che non avrebbe ragione d’esistere se l’istituto di emissione fosse controllato dallo stesso governo, ma di questo problema si è già discusso in abbondanza e non interessa qui riaprire la questione.
Ciò che invece è opportuno sottolineare è che la Federal Reserve aveva già acquistato 1700 miliardi di dollari in titoli immettendo nel sistema altrettanta liquidità e si appresta ora a comprarne altri per un valore pari a 600 miliardi di dollari. Se ne deduce che in meno di tre anni negli USA si è stampato denaro per un ammontare superiore al Pil dell'Italia nell’anno contabile 2010. Una creazione di moneta che non ha precedenti nella storia, una misura "unconventional” come dice con un eufemismo il presidente della Fed Ben Bernake. La verità è che una simile misura non è mai stata testata e gli effetti che provocherà sono tutti da verificare. La cavia ovviamente siamo noi, le economie del resto del mondo.
 Per ora la stampa eccessiva di biglietti verdi ha già portato il dollaro ai minimi rispetto alle altre valute, compreso l'euro. Sulla scacchiera i vari giocatori preparano le loro contromisure. La Corea del Sud si appresta a seguire Thailandia e Brasile nell'introduzione di misure che contengano il forte afflusso di moneta americana verso il proprio paese, cosa che provoca una valorizzazione eccessiva delle monete nazionali. I paesi emergenti sono in subbuglio.
Per ora la stampa eccessiva di biglietti verdi ha già portato il dollaro ai minimi rispetto alle altre valute, compreso l'euro. Sulla scacchiera i vari giocatori preparano le loro contromisure. La Corea del Sud si appresta a seguire Thailandia e Brasile nell'introduzione di misure che contengano il forte afflusso di moneta americana verso il proprio paese, cosa che provoca una valorizzazione eccessiva delle monete nazionali. I paesi emergenti sono in subbuglio.
Nella prima intervista pubblica, la neo eletta presidentessa brasiliana, Dilma Rousseff, ha detto quanto da molti pensato: "Non possiamo pensare che gli Stati Uniti facciano pagare i loro problemi a tutto il mondo attraverso la svalutazione del dollaro". Il prossimo G20 a Seul si annuncia dunque tempestoso, preludio di un ritorno a misure protezionistiche dagli esiti imprevedibili. L'Europa per il momento tace. Gli economisti tedeschi e inglesi sono molto più preoccupati dell'inflazione che questa massa di denaro può provocare piuttosto che dell'impatto immediato sui tassi di cambio.
Germania e Inghilterra hanno infatti inaugurato l'era dell'austerità estrema: hanno la fondata paura che questa massa incredibile di cartamoneta che si sta riversando nell'economia mondiale possa causare uno tsumami finanziario senza precedenti, che potrebbe scuotere dalle fondamenta la fiducia non solo nei governi ma nel sistema internazionale monetario. E’ dunque proprio per questo motivo che i tedeschi vogliono far passare a Bruxelles il principio che se un paese chiede un aiuto finanziario, i detentori dei titoli obbligazionari di quel paese "devono sopportare un sacrificio". Il riferimento alla Grecia è fin troppo esplicito: tutti sanno che nei prossimi tre anni il governo di Atene sarà costretto a ristrutturare il proprio debito e la Germania non intende offrire una garanzia in bianco ai creditori.
Inutile dire che nel giro di poche ore i titoli di Stato greci hanno perso il 20% del loro valore, ricacciando Atene nella quasi certezza del declino finanziario finale. L’Irlanda non gode di una salute molto migliore e deve pagare ai propri creditori un tasso quattro volte maggiore di quello tedesco, seguita a ruota dal Portogallo. Ma fino a quando questa situazione sarà sostenibile? I più pessimisti ritengono che fra poco più di un anno si vedranno gli effetti di queste politiche monetarie a dir poco spericolate e che ci troveremo di nuovo al centro della tempesta perfetta: crisi della fiducia negli stati, crisi della fiducia nella moneta ed inflazione alle stelle.
Insomma sembra già di sentire le sette trombe dell’apocalisse. Non sappiamo però se questo succederà davvero, ma il semplice rischio della catastrofe dovrebbe essere sufficiente per osservare più attentamente le politiche economiche di tedeschi e inglesi che, a differenza di altri, stanno prendendo la situazione molto sul serio.
 E noi? L'Italia come sempre è ferma. In questo momento siamo bloccati sulla manovra finanziaria di luglio che appare sempre più insufficiente e inadeguata a fronteggiare i rischi che ci riserva il futuro. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti, per ora, sembra non poter fare altro che arginare le richieste di spesa che gli arrivano dai colleghi di governo. Purtroppo per noi sembra non riesca neanche a delineare un piano strutturale che metta definitivamente al sicuro i nostri conti pubblici e ci preservi dai "rischi fatali" - per citare un suo libro di qualche anno fa - della globalizzazione economica e finanziaria. Appare semmai più preoccupato dell’ombra di Draghi, le cui proposte di regolarizzazione dei precari e di rilancio della domanda interna vengono insultate dal ministro con la proverbiale stizza da ragioniere isterico che lo contraddistingue.
E noi? L'Italia come sempre è ferma. In questo momento siamo bloccati sulla manovra finanziaria di luglio che appare sempre più insufficiente e inadeguata a fronteggiare i rischi che ci riserva il futuro. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti, per ora, sembra non poter fare altro che arginare le richieste di spesa che gli arrivano dai colleghi di governo. Purtroppo per noi sembra non riesca neanche a delineare un piano strutturale che metta definitivamente al sicuro i nostri conti pubblici e ci preservi dai "rischi fatali" - per citare un suo libro di qualche anno fa - della globalizzazione economica e finanziaria. Appare semmai più preoccupato dell’ombra di Draghi, le cui proposte di regolarizzazione dei precari e di rilancio della domanda interna vengono insultate dal ministro con la proverbiale stizza da ragioniere isterico che lo contraddistingue.
L'inevitabilità della catastrofe la si può osservare cristallizzata nell'esito delle elezioni di medio termine recentemente perse dalla Presidente Obama. Con quel voto gli americani hanno lanciato al mondo il messaggio peggiore che potessero lanciare. Quello che ci comunicano è che loro vogliono continuare a fare come hanno sempre fatto e che non sono disposti ad indietreggiare dalla loro posizione di dominazione e dunque accettare una loro diversa collocazione nel mondo. Gli americani vogliono cioè continuare a scaricare i loro problemi sulle spalle del resto del pianeta, ma quello che l'America vuole non lo può più ottenere e questo, semplicemente, perché non sono più il centro del mondo. La grande questione aperta rimane questa: chi riuscirà a far capire agli americani che non è più possibile continuare su questa strada? L’impero sta raschiando il fondo del barile.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giuliano Luongo
di Giuliano Luongo
Tutte le istituzioni internazionali, di livello più o meno alto, dalla maggiore o dalla minore consacrazione governativa, condividono una caratteristica peculiare: la rigidità, la scarsa adattabilità alle nuove sfide che si frappongono tra l’istituzione in questione ed i suoi scopi. Strano a dirsi, proprio il Fondo Monetario Internazionale, una di quelle meno reattive alle esigenze dei paesi che dovrebbe aiutare, ha recentemente cercato di invertire questo trend, almeno sulla carta, accettando la proposta di modifica dei poteri di voto all’interno della sua principale sede decisionale, l’Executive Board.
Il processo che pochi giorni fa è arrivato a questa tappa fondamentale è stato lungo e spesso apparentemente senza vere e proprie speranze. Il Fondo, erede della vecchia sovrastruttura del sistema di Bretton Woods, sentiva il bisogno di un cambiamento nei rapporti di forza interna da tempo immemore, a partire dal crollo del sistema che l’aveva visto nascere nel lontano 1976.
Sin dall’anno della sua istituzione, l’ancor più lontano 1944 (iniziò i lavori ufficialmente a dicembre ’45), il Fondo prende le sue decisioni tramite il citato Executive Board, composto da 24 membri, di cui cinque nominati dai cinque paesi membri con le quote di partecipazione più cospicue ed i restanti nominati dall’altro organo decisionale, il Consiglio dei Governatori, composto dai rappresentanti di tutti i paesi membri.
Per comprendere le dinamiche interne al Fondo, si ricordi che le decisioni vengono prese esclusivamente a maggioranza molto elevata (di solito all’85%) e che il voto è ponderato in base alla quota versata per la partecipazione all’organizzazione. In breve, decide il più “generoso”, che casualmente è anche il più ricco, che ancor più casualmente sono gli Stati Uniti. Il gruppo dei “grandi cinque” è stato sempre composto, accanto agli americani, da Francia, Gran Bretagna, Giappone e Germania: viste le quote, gli Stati Uniti hanno avuto sempre la possibilità di poter imporre un veto oggettivo ad una qualsiasi decisione prendibile dal Board, con il 16,74% dei voti ottenibili.
Accanto ad essi, l’Europa, in teoria, con un’azione coordinata, ha avuto per lungo tempo la possibilità di imporsi come secondo “membro” con potere di veto (32,07% dei voti totali in caso di intesa): ipotesi comunque alquanto difficile da raggiungere, salvo situazioni di grosso rischio per ampi interessi condivisi.
Il Fondo è stato dunque per larghissima parte della sua storia un ente diretto non solo formalmente dagli Stati Uniti e dai loro più stretti alleati, che sotto la maschera di guardiano della stabilità economica mondiale si è reso di fatto il garante di noti equilibri geopolitici mantenuti a suon di dollari e finanziamenti a politici poco raccomandabili: inutile dire che una tale struttura di controllo non fosse assolutamente interessata a rivedere il proprio ruolo e soprattutto il proprio sistema di funzionamento. Un cedimento in tal senso avrebbe significato far retrocedere il sistema di controllo economico internazionale che con tanta fatica si era imposto.
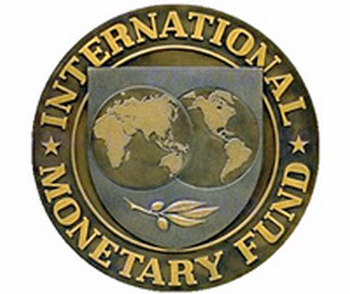 L’arrivo degli anni ’90 ed i terremoti nelle relazioni internazionali con essi venuti, parvero segnare una nuova era nell’espansione del Fondo: l’accettazione delle politiche di liberalizzazione estrema per i paesi più poveri voluta dal Washington Consensus e le linee guida stilate sulla medesima falsariga consigliate ad i paesi usciti dal blocco sovietico, parvero consacrare l’influenza del FMI. Ed è proprio dal momento del suo apice apparente che l’ideologia liberista espansionistica dei cervelloni di Washington iniziò a perdere colpi: l’impoverimento progressivo dei paesi che avevano seguito i suoi consigli, lo sfascio economico della Russia e dei suoi (non troppo) ex-satelliti mostrarono la fragilità delle sue teorie.
L’arrivo degli anni ’90 ed i terremoti nelle relazioni internazionali con essi venuti, parvero segnare una nuova era nell’espansione del Fondo: l’accettazione delle politiche di liberalizzazione estrema per i paesi più poveri voluta dal Washington Consensus e le linee guida stilate sulla medesima falsariga consigliate ad i paesi usciti dal blocco sovietico, parvero consacrare l’influenza del FMI. Ed è proprio dal momento del suo apice apparente che l’ideologia liberista espansionistica dei cervelloni di Washington iniziò a perdere colpi: l’impoverimento progressivo dei paesi che avevano seguito i suoi consigli, lo sfascio economico della Russia e dei suoi (non troppo) ex-satelliti mostrarono la fragilità delle sue teorie.
Accanto a questo, l’esistenza stessa della Cina continuava a dare colpi alla struttura creata dal Fondo: il fenomeno delle economie asiatiche in crescita faceva capire come la balance of power interna all’organizzazione non era più efficace nel mostrare i rapporti di forza economici del mondo. Il crack dell’Argentina del 2001, grande pupillo dell’economia neo-con, è stato uno delle ulteriori prove del fiasco sia politico che teorico del Fondo. La recente ascesa dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) come leaders del movimento dei paesi di nuova industrializzazione, ha fatto capire che l’organizzazione doveva seguire una strada diversa.
Da metà degli anni 2000, sono state numerose le richieste giunte dal movimento più o meno organizzato dei paesi emergenti per una generale riforma della governance dell’istituzione: il Gruppo dei 20 ha fatto da navigatore in questo senso, grazie anche alla progressiva affermazione dei quattro BRIC come nuovo ago della bilancia dell’economia mondiale.
E’ dunque dall’ultima riunione dei G-20 tenutasi lo scorso anno a Pittsburgh che i paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione hanno progettato una riforma del sistema decisionale del Fondo, per far sì che la propria voce avesse più peso: la richiesta più importante era quella di ottenere lo spostamento del 5% dei voti nelle mani delle nuove economie. Questo avrebbe dovuto far sì che gli equilibri di forza interni all’organizzazione rispecchiassero maggiormente la realtà dei fatti economici.
 Il lungo percorso delle trattative è giunto ad una svolta nelle ultime due settimane: l’Executive Board, infatti, ha dato il via libera alle richieste del sud del mondo. Evento definito come epocale dal Direttore Generale del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, il quale, sin dal momento del suo insediamento nel 2007, si è sempre mostrato favorevole ad una certa inversione di tendenza nella direzione dell’organizzazione. Sincero o meno, questo interesse verso una maggiore responsività alle esigenze della situazione economica internazionale ha finalmente trovato uno sbocco pratico.
Il lungo percorso delle trattative è giunto ad una svolta nelle ultime due settimane: l’Executive Board, infatti, ha dato il via libera alle richieste del sud del mondo. Evento definito come epocale dal Direttore Generale del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, il quale, sin dal momento del suo insediamento nel 2007, si è sempre mostrato favorevole ad una certa inversione di tendenza nella direzione dell’organizzazione. Sincero o meno, questo interesse verso una maggiore responsività alle esigenze della situazione economica internazionale ha finalmente trovato uno sbocco pratico.
Il gruppo dei “grandi cinque” è stato di fatto abolito: dieci seggi del board sono garantiti a Stati Uniti, Giappone, Brasile, India, Russia, Cina, più Germania, Regno Unito, Francia e Italia. Il Vecchio Continente vede fissato il numero dei suoi paesi a sette rispetto ai nove precedenti. Si concede il trasferimento del 6% dei diritti di voto dalle economie industriali a quelle dinamiche, tutelando i diritti di voto dei paesi meno abbienti (quelli con un reddito pro capite inferiore a 1135 dollari l’anno). Passa inoltre la riforma delle quote, che saranno raddoppiate (anche questo supera le iniziali richieste dei G-20). La Cina diviene il terzo paese per potere di voto all’interno dell’organizzazione.
L’operazione di riforma non sarà breve: si pensa alla metà del 2012 per l’ultimazione di tutti i dettagli, data in cui l’Europa dovrà decidere a chi sarà sottratta la sedia tra i suoi membri (si pensa ad esempio ad una rotazione tra Belgio ed Olanda).
Se è troppo presto per dire quanto questi cambiamenti saranno efficaci, bisogna comunque riconoscere la portata dell’evento: la vecchia élite ha accettato dei nuovi membri nelle sue file, ha fatto un passo indietro rispetto al nuovo mondo che avanza. Bisognerà di certo vedere in che misura questa evoluzione gioverà davvero alle “pedine” dell’economia mondiale o se, invece, ci troviamo davanti solo ad un parziale cambiamento di élite, utile solo ai diretti interessati. Di certo, non è tanto la liberalità europea a colpire. Colpisce che i BRIC siano riconosciuti finalmente come le nuove potenze economiche. E che le nuove potenze siano due economie pianificate, più una neo-socialista ed una in fervente ri-sovietizzazione.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Quando si tratta di fare quattrini la fantasia umana sembra non conoscere limiti. Da questo punto di vista l’ultima frontiera è rappresentata dai sistemi di trading automatizzati conosciuti come “arbitraggi meccanici”: in parole povere, si tratta di un software che compra e vende sfruttando in modo automatico ogni minimo disallineamento dei corsi dei titoli sulle varie Borse.
Il concetto è sempre lo stesso: si tratta di scandagliare il mercato alla ricerca di qualche cosa (azioni, obbligazioni, derivati) che costi un po’ meno di quello che dovrebbe, per poi venderlo un secondo dopo tenendo un piccolo margine per sé. E’ una cosa che una macchina, molto più veloce a scovare possibili arbitraggi e immune alle defaillances emotive degli esseri umani, è in grado di fare molto meglio di una persona, che dovrebbe restare inchiodata davanti ad una serie di schermi a scrutare ogni minima variazione di prezzo per poi cliccare abbassare l’indice sul mouse per validare un “buy” o un “sell”.
Spesso i disallineamenti di prezzo sono irrisori, ma con questa metodologia, lavorando sulle numeriche (ovvero moltiplicando all’infinito il numero delle transazioni vantaggiose) si riescono a portare a casa milioni di Euro praticamente senza alzare un dito (o meglio senza collegare due sinapsi) e per di più facendo “del bene” al mercato, poiché - sostengono i fan dei mercati perfetti - grazie agli speculatori seriali i valori vengono riportati in equilibrio.
La variabile critica, qui, è il tempo: quando si comprano azioni o commodities per tenerle qualche secondo per poi rivenderle, un vantaggio anche solo di pochi decimi di secondo sui “competitor” fa davvero la differenza. A tutti coloro che hanno vissuto o subito il salto quantico tra il sano (e lento) mondo analogico e l’orgia di “digitalismo” nel quale viviamo immersi volenti o nolenti, viene naturale pensare, oggi, che grazie ai nostri giocattoli elettronici tutto avvenga in tempo reale. Ma, come sanno benissimo i fisici, la velocità alla quale viaggiano l’informazione e le transazioni che di essa si nutrono è limitata dalla velocità della luce. Insomma, esistono limiti fisici alla velocità di reazione di un sistema di trading automatizzato.
 Una delle conseguenze di questo vincolo è che il concetto d’inevitabile contiguità fisica tra interlocutori (imprescindibile solo fino a qualche decennio fa, apparentemente obsoleto oggi) si impone di nuovo, e prepotentemente, alla nostra attenzione. Molti intermediari finanziari, infatti, proprio per ridurre i tempi di trasmissione degli ordini, spesso sistemano i propri server molto vicini a quelli della Borsa Valori sulla quale vogliono scambiare titoli - in alcuni casi, direttamente negli stessi locali (co-locazione delle macchine). Si noti, per inciso, come il libero mercato consenta ad alcuni operatori di essere “più uguali degli altri”, pagando qualche cosa per il disturbo, s’intende...
Una delle conseguenze di questo vincolo è che il concetto d’inevitabile contiguità fisica tra interlocutori (imprescindibile solo fino a qualche decennio fa, apparentemente obsoleto oggi) si impone di nuovo, e prepotentemente, alla nostra attenzione. Molti intermediari finanziari, infatti, proprio per ridurre i tempi di trasmissione degli ordini, spesso sistemano i propri server molto vicini a quelli della Borsa Valori sulla quale vogliono scambiare titoli - in alcuni casi, direttamente negli stessi locali (co-locazione delle macchine). Si noti, per inciso, come il libero mercato consenta ad alcuni operatori di essere “più uguali degli altri”, pagando qualche cosa per il disturbo, s’intende...
Quando però si parla di titoli trattati da più di un mercato regolamentato, è necessario trovare una collocazione fisica delle macchine che minimizzi la dispersione di tempo causata dalla trasmissione dei dati. E’ questo il senso della ricerca effettuata dal fisico Alex Wissener-Gross e dal matematico Cameron Freer (entrambi del MIT di Boston) e pubblicata sulla Physical Review E. I due scienziati hanno analizzato una cinquantina di borse valori mondiali, tracciando una mappa delle “zone” ideali dai quali si potrebbe operare in modo ottimale: si va da un punto nel bel mezzo dell’Oceano Indiano alle foreste remote del Canada o della Russia.
 “Anche solo fatto di avere la sovranità su un particolare punto della terra, per quanto apparentemente sterile o inutilizzabile, insomma, potrebbe rivelarsi un asso nella manica” argomenta Wissener-Gross, “benché, riconosce, la gran parte dei punti ottimali siano in luoghi remoti e dunque non dotati delle infrastrutture necessarie a connettersi. Vi sono certo anche eccezioni, come ad esempio Los Angeles, in posizione strategica per ottimizzare le operazioni che transitano tanto su Tokio che su New York (sarebbe questo un modo per dare un senso a quella specie di città...).
“Anche solo fatto di avere la sovranità su un particolare punto della terra, per quanto apparentemente sterile o inutilizzabile, insomma, potrebbe rivelarsi un asso nella manica” argomenta Wissener-Gross, “benché, riconosce, la gran parte dei punti ottimali siano in luoghi remoti e dunque non dotati delle infrastrutture necessarie a connettersi. Vi sono certo anche eccezioni, come ad esempio Los Angeles, in posizione strategica per ottimizzare le operazioni che transitano tanto su Tokio che su New York (sarebbe questo un modo per dare un senso a quella specie di città...).
Benché Wissener-Gross e Freer si dicano sicuri del fatto loro, al punto da affermare di essere già in contatto con numerosi intermediari finanziari per vendere loro la metodologia quantitativa alla base della pubblicazione del loro lavoro, non mancano voci critiche: come quella di Michael Kearns, esperto di finanza computazionale presso l’università della Pennsylvania di Philadelphia. Kearns ricorda che i punti ottimali costituiscono un eccellente esercizio teorico, che però ha il limite notevole di basarsi sull’ipotesi, invero molto irreale, che le informazioni circolino alla velocità della luce.
In verità, a meno che si disponga di un collegamento punto-punto in fibra ottica dalla postazione al trading floor della banca, i dati normalmente rimbalzano da un router all’altro viaggiando a velocità molto più basse anche nei casi più fortunati. Senza contare che la ricerca parla di un mondo perfetto (per la finanza) privo anche delle più elementari forme di regolamentazione - cosa che non accade nemmeno negli Stati Uniti, che dopo le batoste degli anni scorsi hanno per lo meno cercato di darsi qualche regola un po’ più seria. Insomma, sembra proprio che Wissener-Gross e Freer non abbiano (ancora?) trovato la pietra filosofale del trader.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giuliano Luongo
di Giuliano Luongo
Tra le tante e costanti critiche che il cittadino comune - spesso chiamato con dispregiativa arroganza “uomo della strada” dalla letteratura economica - sferra alle istituzioni europee ed a tutto il loro entourage, c’è quella della incommensurabile lentezza decisionale, che le fa percepire come una banda di cialtroni bravi solo a rimandare.
Di certo, nonostante i passi avanti, l’ultimo rinvio (stavolta a Dicembre) delle decisioni definitive sulle modifiche al Patto di Stabilità e sulle conseguenti variazioni del Trattato di Lisbona non gioveranno alla reputazione dell’Unione nei confronti del grande pubblico. Ma di certo, anche gli analisti più attenti avranno qualcosa da dire (se non ridire) riguardo gli ultimi avvenimenti del vertice UE del 28 ottobre.
Com’è noto, i lavori iniziavano sotto l’egida dell’intesa franco-tedesca sulle modifiche al Patto ed il pollice verso di Trichet a tali variazioni. Il clima della vigilia sembrava alquanto favorevole solo all’immobilità: non era solo il numero uno della Banca Centrale Europea ad essere foriero di dubbi, ma anche i rappresentanti di Stati di peso come la Gran Bretagna non sembravano avvezzi ad un esito positivo delle trattative. Così stranamente non è stato: l’inguardabile Cancelliera tedesca ha saputo sfoggiare inaspettate doti diplomatiche, riuscendo ad allargare il fronte dei riformatori per portare il vertice ad un esito relativamente positivo riguardo i cambiamenti annunciati.
“Relativamente”, perché le riforme saranno rese note solo nel prossimo vertice di Dicembre, ma “positivo” perché ormai la riforma del Patto è stata accettata dai 27. Le modifiche alle norme contenute nel Patto, discusse una decina di giorni fa durante l’incontro Ecofin, sono state gradite alla coscienza politica dell’Unione, che ha affidato alla task force del Presidente del Consiglio Van Rompuy il compito di elaborarle in dettaglio ed esporle fra poco più di un mese. Come sempre, un rinvio pur nell’accettazione.
N on di poco conto il punto sul quale l’iniziativa tedesca ha dovuto cedere, ossia quello del ritiro del diritto di voto ai paesi che violino le disposizioni sui conti pubblici: il Presidente della Commissione Barroso è arrivato a dire che “una misura del genere è inaccettabile, irrealistica e contraria allo spirito del Trattato”, nonostante la ferma convinzione della Merkel sulla validità di questa disposizione. E’ passata inoltre l’ipotesi di modifiche ai Trattati, seppur in maniera minima (ancora una volta, la Germania voleva di più). Sfuma invece la possibilità di un’intesa sul tipo di fondo anti-crisi da varare: i tedeschi volevano non solo un sistema di salvataggio, ma anche la previsione di un sistema di gestione “ordinata” del default di uno stato. Nessun altro paese ha appoggiato questa posizione.
on di poco conto il punto sul quale l’iniziativa tedesca ha dovuto cedere, ossia quello del ritiro del diritto di voto ai paesi che violino le disposizioni sui conti pubblici: il Presidente della Commissione Barroso è arrivato a dire che “una misura del genere è inaccettabile, irrealistica e contraria allo spirito del Trattato”, nonostante la ferma convinzione della Merkel sulla validità di questa disposizione. E’ passata inoltre l’ipotesi di modifiche ai Trattati, seppur in maniera minima (ancora una volta, la Germania voleva di più). Sfuma invece la possibilità di un’intesa sul tipo di fondo anti-crisi da varare: i tedeschi volevano non solo un sistema di salvataggio, ma anche la previsione di un sistema di gestione “ordinata” del default di uno stato. Nessun altro paese ha appoggiato questa posizione.
Riportiamo l’ultima decisione di rilievo per poi avviare alcune riflessioni d’obbligo: è passata l’idea che il fondo anticrisi riguarderà solo i paesi dell’area Euro. E di questo è stata molto felice l’Inghilterra, guarda caso. Non è stata brava diplomaticamente, la Merkel: ha in effetti fatto concessioni molto grandi al sentimento anti europeista britannico. Per avere il loro appoggio, ha fatto passare quest’ultima disposizione, togliendo così l’onere al più grande paese non-Euro dell’Unione di dover collaborare al fondo di soccorso per i Paesi che potrebbero andare in crisi economica. In secondo luogo, il “potente” asse franco-tedesco ha fatto passare la proposta Cameron di non far alzare i contributi nazionali al budget UE al 6% nel 2011, mettendo invece un tetto al 2,91%.
Queste intese costituiscono uno spunto interessante per analizzare i rapporti di forza all’interno dei paesi “di peso” dell’Unione. Ad essere passate, in fondo, sono state solo le modifiche vaghe ed esistenti solo in teoria alle disposizione “tecniche” del Patto di Stabilità, come il criterio numerico da adottare per il taglio del debito e l’impatto del debito privato, mentre i tentativi più rivoluzionari sono rimasti al palo.
L’idea di grande modifica dei Trattati per introdurre riforme economiche (e non) è stata ampiamente ridimensionata perché vista come rischiosa da gran parte dei rappresentanti presenti al meeting. Il concetto di modifica “light”, come definito dal capo dell’eurogruppo Juncker, al fine di introdurre un meccanismo anticrisi permanente, deve passare perché aiuterà la sopravvivenza della UE stessa, ma non si deve andare oltre: aprire la porta ad ulteriori modifiche potrebbe innescare una nuova spirale di divisioni che vanificherebbe la lunga e difficile strada che ci ha portato a Lisbona.
 Il vero fiasco della proposta Merkel può essere identificato con il “no” secco dei leader alla sospensione del diritto di voto. Si noti come la Merkel lo abbia giustificato tirando in ballo l’art.7 del Trattato di Lisbona, che prevede la sospensione per i paesi che “violino i principi fondamentali dell’Unione”: cercava di estendere una misura di principio legata prettamente all’ambito politico e sociale e a quello economico, creando un loop che di fatto avrebbe affermato il primato dell’economia sulla politica. Si nota semplicemente come la lettura dello scopo ultimo dell’Unione Europea è ancora quello di una comunità economica, non di una comunità di cittadini europei.
Il vero fiasco della proposta Merkel può essere identificato con il “no” secco dei leader alla sospensione del diritto di voto. Si noti come la Merkel lo abbia giustificato tirando in ballo l’art.7 del Trattato di Lisbona, che prevede la sospensione per i paesi che “violino i principi fondamentali dell’Unione”: cercava di estendere una misura di principio legata prettamente all’ambito politico e sociale e a quello economico, creando un loop che di fatto avrebbe affermato il primato dell’economia sulla politica. Si nota semplicemente come la lettura dello scopo ultimo dell’Unione Europea è ancora quello di una comunità economica, non di una comunità di cittadini europei.
A più di cinquant’anni dalla nascita del primo nucleo dell’Unione, risulta evidente come sia ancora l’economia il motore primario delle sue dinamiche interne: dal punto di vista dell’integrazione, le trattative tra i potenti dimostrano ancora come la via verso un’Europa politica sia ancora molto lunga. E mentre le definitive decisioni più o meno prettamente “contabili” vanno ancora elaborate e discusse, si nota come le spinte euroscettiche - per l’ennesima volta da parte inglese - abbiano peso nella definizione delle strategie comunitarie. Sullo sfondo, rimane una potenza franco-tedesca leggermente sminuita, sia dal rivale britannico sia dal resto dell’Unione stessa.
Non ci resta quindi che rimandare di un mese ulteriori considerazioni prettamente tecniche e di bilancio, non meno importanti per valutare lo stato di salute comunitario. Per ora si può solo constatare che l’Unione Europea politica e sociale nata a Lisbona, quella che dall’anno scorso sostituisce la comunità “solo economica”, non ha mostrato un volto all’altezza del suo ruolo.
