Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Maura Cossutta
di Maura Cossutta
La sentenza della Corte Costituzionale ha cancellato il divieto di eterologa previsto dalla legge 40 del 2004. Questa sentenza ha valore di legge e non è oppugnabile. Da oggi cioè non potrà mai più essere votata dal Parlamento una legge che prevede il divieto di fecondazione di tipo eterologa. Un colpo durissimo, definitivo, ad una legge sbagliata, crudele, ideologica, la prima legge confessionale della storia della Repubblica.
Legge contro la quale per ben 30 volte già si erano espresse altre sentenze di Tribunali civili e amministrativi regionali oltre che la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimi il divieto di produrre più di 3 embrioni e quello della diagnosi pre impianto. Pezzo dopo pezzo è crollato tutto l’impianto ideologico della legge, fino al colpo finale, questo sull’eterologa.
La Corte ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita». Di cosa si parla? Soprattutto di chi?
In sostanza è anticostituzionale la parte della legge in cui si vieta di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia per concepire un figlio. Sull’eterologa la discussione in Parlamento e fuori dal Parlamento è stata fortissima: si sono evocati scenari apocalittici, si è dato vita ad una comunicazione da terrore antropologico, prevedendo un blad runner di casi limite, come quelli di mamme/nonne che hanno guadagnato le prime pagine dei quotidiani. Invece, delle storie quotidiane di migliaia di persone normali nessuno parlava.
Eppure sono tante, tantissime le donne e gli uomini che si ritrovano sterili dopo un percorso di malattia, o dopo una chemioterapia,o dopo l’asportazione delle ovaie, o perché portatori di patologie potenzialmente trasmissibili di tipo infettivo o genetico, o perché ancora troppo giovani con una menopausa precoce.
Sono tutte persone con seri problemi di salute, che fino ad oggi non hanno potuto utilizzare la legge 40 per diventare genitori perché la procreazione assistita omologa per loro era inutile, in quanto i loro gameti non erano utilizzabili. L’unica possibilità fino ad oggi è stata quella di emigrare, cercare all’estero centri in cui si praticasse la fecondazione eterologa.
E infatti sono state più di 4 mila le coppie che ogni anno si sono rivolte a centri esteri, per lo più in Spagna (dove il 63% di trattamenti per fecondazione di gameti è rivolto a coppie italiane) e nei Paesi dell’Est, ma anche a Lugano e in Belgio, pagando un costo variabile tra gli 8 mila euro della Spagna, i 3- 5 mila del Belgio, ai 2 mila euro dei Paesi dell’Est, con l’Ucraina in testa.  Divieti quindi, quelli della legge 40, tanto crudeli quanto inefficaci perché non hanno potuto certo impedire i “viaggi della speranza”. Divieti assurdi, miopi, perché non hanno voluto e saputo prevedere la conseguenza più pericolosa, quella dell’assenza di controlli sull’insorgenza di eventuali infezioni nei genitori e nel neonato, che non vengono seguiti dal nostro Servizio sanitario nazionale, fino all’assenza di dati genetici del bambino nato con le tecniche.
Divieti quindi, quelli della legge 40, tanto crudeli quanto inefficaci perché non hanno potuto certo impedire i “viaggi della speranza”. Divieti assurdi, miopi, perché non hanno voluto e saputo prevedere la conseguenza più pericolosa, quella dell’assenza di controlli sull’insorgenza di eventuali infezioni nei genitori e nel neonato, che non vengono seguiti dal nostro Servizio sanitario nazionale, fino all’assenza di dati genetici del bambino nato con le tecniche.
Divieti ipocriti, perché dietro la rassicurazione di un divieto dentro i nostri confini, si chiudevano gli occhi di fronte al diffondersi ovunque del mercato di gameti. Oggi infatti in tutta Europa e in America non si contano più i siti che pubblicizzano centri per l’acquisto di un seme o di un ovocita, tutto senza controllo.
La decisione della Corte ristabilisce quindi il principio di equità, fra coppie sterili e infertili e il principio della tutela della salute, garantendo un sistema di controlli. L’eterologa sarà possibile, sono mantenute le tutele per i nati dalla tecnica eterologa (cioè il divieto di disconoscimento di paternità), la tecnica sarà gratuita, cioè non bisognerà pagare alcun donatore.
Dopo la sentenza della Corte non serve modificare la legge. Oggi spetta piuttosto al Ministero della Salute, insieme alle società scientifiche e con il supporto delle associazioni di cittadini e pazienti, predisporre un Regolamento e delle Linee Guida per definire il sistema appropriato per la donazione dei gameti. Per esempio - è questa la proposta che più merita attenzione - si potrebbe adottare il modello inglese con l’impiego gratuito dei gameti extranumerari, quelli prodotti con le tecniche omologhe e non utilizzati.
A 10 anni di distanza dalla legge, non serve quindi modificare la legge, quanto piuttosto attuare tutto quello che ancora non è stato attuato. Cosa? Innanzitutto occorre per esempio inserire la procreazione medicalmente assistita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (nazionali e non solo in alcune regioni) e includere le tecniche (FIVET e altro) in precise tariffe, prevedendo quindi una tariffa unica nazionale con il relativo ticket, correggere il sistema della mobilità sanitaria tra le varie regioni. Senza questo, oggi le coppie del sud non andranno magari all’estero, ma saranno comunque costrette ad emigrare al nord per accedere alle tecniche; la prescrizione dei farmaci per l’infertilità non potrà essere garantita a carico del Servizio sanitario nazionale; nelle regioni continuerà il “regno del fai da te”; i centri pubblici saranno sempre più soffocati dall’offerta del privato; cresceranno i costi inappropriati per la sanità pubblica.
Senza questo, oggi le coppie del sud non andranno magari all’estero, ma saranno comunque costrette ad emigrare al nord per accedere alle tecniche; la prescrizione dei farmaci per l’infertilità non potrà essere garantita a carico del Servizio sanitario nazionale; nelle regioni continuerà il “regno del fai da te”; i centri pubblici saranno sempre più soffocati dall’offerta del privato; cresceranno i costi inappropriati per la sanità pubblica.
A 10 anni di distanza dalla legge, per difendere il diritto di tutte le coppie a poter diventare genitori, è giusto quindi ripartire da qui: da questa sentenza e dalle cose ancora da fare, per garantire che la procreazione assistita possa continuare a essere un ambito della sanità pubblica.
Infine, un’ultima considerazione: questa sentenza è stata possibile solo perché alcune coppie hanno scelto di portare nei Tribunali le loro storie, perché hanno creduto nella Costituzione, utentico faro per i diritti individuali e collettivi, perché non si sono arrese. Nella storia della legge 40, invece, troppo poco si sono ascoltate queste storie: o parlavano i medici o parlavano i preti.
Uno scontro che andava oltre i soggetti, che restavano muti. Oggi hanno vinto innanzitutto loro, ma con loro abbiamo vinto tutti. Impariamo quindi da loro: una lezione per ognuno di noi, di soggettività politica, di impegno civile, di pratica di cittadinanza, di testimonianza dei valori costituzionali.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
L'euro è un argomento difficile in sé, ma si presta molto bene alla propaganda spiccia. E' semplicissimo parlare allo stomaco di chi non arriva alla fine del mese indicandogli un nemico ben definito contro cui scagliarsi, come insegna l'affermazione dell'estrema destra di Marine Le Pen alle amministrative francesi. E' anche un gioco scorretto, ma poco importa a chi cerca solo facili consensi. E ora che le elezioni europee sono a un passo, il baraccone dei nemici della moneta unica ce la metta tutta per far credere agli italiani che il ritorno alla lira sarebbe la panacea di tutti i mali.
L'armata degli anti-euro made in Italy è costituita da tre poli: da una parte Lega e Movimento 5 Stelle, gli oppositori più agguerriti, dall'altra Forza Italia, ben più moderata e ipocrita. Per il Carroccio di Matteo Salvini l'euroscetticismo è una scelta di campo obbligata, l'ultima strada praticabile per raschiare il barile elettorale dopo la demolizione del partito praticata dai vari Bossi, Belsito, Rosy Mauro, Cota, e via dicendo (anche Tosi ha fatto la sua parte). La crociata contro la valuta comunitaria è invece un carattere genetico del movimento grillino, la più genuina manifestazione italica del concetto di populismo antisistema.
Quanto a Silvio Berlusconi, come al solito il problema è che noi italiani abbiamo una pessima memoria. Nessun popolo con un minimo d'amor proprio accetterebbe sparate anti-euro da chi ha votato in Parlamento la ratifica del Fiscal compact, ma - per fortuna dell'ex Cavaliere - qui da noi bastano un paio di giorni per dimenticare ogni cosa. In questo caso sono passati addirittura due anni e l'ex Premier può così addossare alla moneta le colpe del proprio malgoverno.
Di fronte a un carrozzone così variopinto e assatanato, vale la pena ricordare per quali ragioni l'uscita dall'euro non sarebbe affatto un rimedio miracoloso per l'economia italiana, ma - al contrario - le darebbe il colpo di grazia.
In primo luogo, pensiamo ai conti correnti e ai depositi. Se dicessimo addio alla moneta unica, i risparmi di milioni di italiani sarebbero convertiti da euro in lire (o in qualsiasi nuova valuta) e varrebbero molto meno di oggi, perché il passaggio implicherebbe una massiccia svalutazione. Chiunque abbia dei soldi in banca, quindi, ne perderebbe una buona fetta (gli unici a salvarsi sarebbero i pochi ricchi titolari di conti all'estero).
La sola ipotesi che ciò possa accadere porterebbe i risparmiatori a fare la fila ai bancomat per accaparrarsi quanti più euro possibile ed evitare di rimetterci (nel 1992, prima della svalutazione della lira, in pochi mesi uscirono dall'Italia 50 mila miliardi di lire). Il prelievo di massa rischierebbe di far collassare il sistema bancario e con esso milioni d'imprese, che vedrebbero definitivamente cancellata ogni possibilità di ottenere finanziamenti. 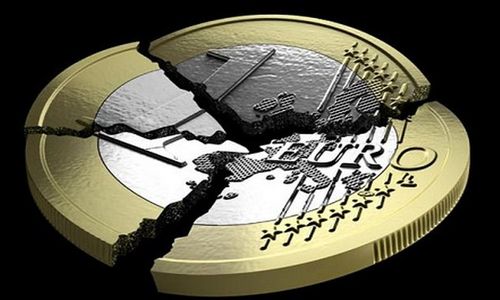 D'altra parte, sia le banche sia le altre aziende hanno debiti in euro che rimarrebbero in euro e sarebbero quindi molto più difficili da onorare rispetto ad ora, visto che bisognerebbe ripagarli in lire, ovvero con una moneta più debole. Un discorso analogo varrebbe per il Tesoro, che dovrebbe rimborsare in lire tutti i titoli di Stato fin qui emessi in euro.
D'altra parte, sia le banche sia le altre aziende hanno debiti in euro che rimarrebbero in euro e sarebbero quindi molto più difficili da onorare rispetto ad ora, visto che bisognerebbe ripagarli in lire, ovvero con una moneta più debole. Un discorso analogo varrebbe per il Tesoro, che dovrebbe rimborsare in lire tutti i titoli di Stato fin qui emessi in euro.
Una missione praticamente impossibile, a meno di non voler svalutare anche i bond legati al debito pubblico, il che vorrebbe dire causare una perdita a chi ha investito nel nostro Paese. A quel punto ci giocheremmo la fiducia dei mercati: nessuno sarebbe più disposto a comprare titoli di Stato italiani, se non a tassi d'interesse altissimi, che renderebbero il nostro debito molto più difficile da finanziare.
La svalutazione della nuova lira avrebbe effetti devastanti anche sulla bolletta energetica italiana, visto dovremmo comprare dall'estero petrolio e gas usando un'altra moneta molto più forte della nostra, ovvero il dollaro. Gli unici benefici arriverebbero sul fronte dell'export, perché la debolezza della moneta renderebbe più competitive le aziende che vendono all'estero (gli acquirenti, grazie al tasso di cambio favorevole, spenderebbero meno per comprare i nostri prodotti).
Infine, un aspetto decisamente più pragmatico: come si fa a uscire dall'euro? Nessuno lo sa, perché nei trattati questa ipotesi non è nemmeno contemplata. Grillo parla ancora di un "referendum sull'euro", ma un'eventuale consultazione avrebbe carattere meramente informativo e probabilmente andrebbe condotta sul blog del comico genovese, visto che la nostra Costituzione (articolo 75, comma 2) vieta espressamente di sottoporre a referendum abrogativo le leggi di ratifica dei trattati internazionali. La propaganda, invece, si può fare eccome.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
L'azzeramento del Senato è stato sempre un progetto di Silvio Berlusconi, non è un mistero per nessuno. Progetto perseguito e mai raggiunto in virtù di una opposizione che tanto sul piano del contenuto come su quello del (sacrosanto) pregiudizio politico verso il cesarismo del cavaliere ormai disarcionato, era riuscita ad evitare il pasticcio. Ora però, con il nuovo cesarismo incarnato da Renzi, il progetto si azzeramento del Senato è di nuovo calendarizzato nei lavori delle camere, di nuovo al centro del tavolo politico.
Perché tanta fretta? Perché un governo di comparse e neofiti si ostina a spostare lo sguardo dai problemi economici e sociali di questo Paese per indirizzarsi invece sulle architetture istituzionali? Si è parlato spesso di “bicameralismo perfetto” per descrivere il disegno istituzionale delle assemblee legislative, definizione calzante. In effetti, come in ogni democrazia degna, non solo la divisione dei poteri è d’obbligo, ma il bilanciamento strutturale degli stessi, tramite un sistema di pesi e contrappesi, è elemento imprescindibile.
Lo è per evitare semplificazioni ed approssimazioni, per tenere insieme l’opinione e gli interessi generali; ma, soprattutto, per evitare scorciatoie autoritarie da parte di un potere che, in Italia in particolare, ha la spiccata e reiterata tendenza all’autoreferenzialità e la disponibilità all’abuso, la perenne tentazione della contrazione degli spazi di dialogo e interlocuzione in favore delle “maniere spicce”. Ad ogni epoca storica, in ogni fase politica, questa propensione nazionale a non guardare tanto per il sottile quando si tratta di legiferare e governare a difesa e sostegno degli interessi dei poteri forti la si è chiamata in modi diversi, ultimo quello della “governabilità”.
E qui si manifesta ulteriormente Renzi. La sua ossessione per la cancellazione del CNEL è preoccupante; dal momento che nessuno può pensare che i risparmi vengano dalla sua abolizione, non può però sfuggire il carattere simbolico che il capriccio contiene. Organo di rilievo costituzionale, il CNEL (Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro) è organo consultivo di Camera, Senato e Regioni. Esprime pareri - se richiesti - ed ha diritto all’iniziativa legislativa; vede presenti sindacati e associazioni e rappresenta un punto di analisi, una lettura della realtà socioeconomica, che tiene conto dell’insieme degli interessi dei diversi settori del Paese.
Con la stessa logica insita nel rifiuto della concertazione con i sindacati, il vanesio premier ritiene di poter silenziare tutti coloro che sono dotati di capacità di analisi, elaborazioni e proposte diverse e qualificate. Renzi soffre l’esistenza dei luoghi di riflessione, dal momento che passare dalle battute alle politiche non gli è congeniale. La sua elaborazione è talmente povera sul piano culturale che confrontarsi con chi è in grado di leggere i mutamenti sociali del paese gli risulta insidioso.
Nel ddl Renzi manca, come nel personaggio, un minimo di equilibrio. Quando si eliminano i contrappesi, i pesi diventano eccessivi. Eliminare una delle due camere non ha niente a che vedere con i risparmi e, comunque, la democrazia non è soggetta ad analisi dei costi. Abolire il Senato corrisponde ad un disegno autoritario, che spinge sull’acceleratore della riduzione della dialettica politica in funzione di una maggiore agilità della struttura di comando. La possibilità di trasformare il Senato nella Camera delle Regioni - idea dotata di una sua legittimità storica - non ha niente a che vedere con questo papocchio isterico, dal quale risulta chiaro che la sua funzione prevista è meramente decorativa. L’unica certezza di sostanza è che il Senato secondo Renzi non può aprire bocca sul Bilancio; il che, diciamolo, non depone bene circa il ruolo. Insomma il sapore di un colpo di mano è forte. Più che lo snellimento dei processi legislativi (che normalmente giacciono molto più tempo alla Camera, sia detto) questa riforma del Senato manifesta piuttosto l’intenzione di limitare i poteri di controllo e d’intervento legislativo sugli atti di governo e sulle deliberazioni della Camera.
L’unica certezza di sostanza è che il Senato secondo Renzi non può aprire bocca sul Bilancio; il che, diciamolo, non depone bene circa il ruolo. Insomma il sapore di un colpo di mano è forte. Più che lo snellimento dei processi legislativi (che normalmente giacciono molto più tempo alla Camera, sia detto) questa riforma del Senato manifesta piuttosto l’intenzione di limitare i poteri di controllo e d’intervento legislativo sugli atti di governo e sulle deliberazioni della Camera.
Oltre al danno, c’è la beffa, visto che lo smontaggio della Carta avviene in un contesto politico dove il Presidente della Repubblica decide chi governa il paese, il premier è insediato da una manovra di Palazzo e il Parlamento che deve votare le modifiche alla Costituzione è illegittimo, giacché eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Consulta. Di ben altra legittimità politica ci sarebbe bisogno per procedere ad una modifica sostanziale dell’architettura istituzionale.
Il fatto che la Direzione nazionale del PD abbia appoggiato il progetto dell’ambizioso premier senza ricordarsi di aver bocciato identico progetto quando era farina del sacco berlusconiano, testimonia di come l’unica identità di quello che un tempo fu un partito di centrosinistra è la contrapposizione personale a Berlusconi, non una idea permanente della salvaguardia dell’architettura costituzionale della Repubblica.
La speranza è che gli intrecci d’interessi che si dipanano nei diversi schieramenti politici rendano impervia la salita delle truppe cammellate all’assalto della Carta. Il fatto stesso che Renzi minacci le dimissioni nel caso il suo disegno non si compia, quasi meriterebbe “a prescindere” che ciò avvenisse. Agitare lo spauracchio della palude della governabilità non basta: si rischia, per uscire dalla palude della governabilità senza sapere dove mettere i piedi, di sprofondare nelle sabbie mobili della democrazia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
I centri di espulsione, dove vengono detenuti i migranti irregolari sine die, stando ai numeri attuali, nascono in Italia ufficialmente nel 1998 con la legge Turco-Napolitano e, con una faccia e una sigla diversa, erano allora i CPT, sostanzialmente delle carceri per i quali l’Europa ci condanna in cui si sono trasformati oggi dalla legge Bossi - Fini in poi. Se le parole hanno un peso concreto, e ce lo hanno, averli declinati come luoghi di espulsione racconta molto di una linea politico e di un umore culturale diffuso o, ancor peggio, propagandato.
L’ex Ministro Kyenge, possibile candidata nella circoscrizione Pd centro-est, torna a parlare di immigrazione e di normativa arretrata e inadeguata, oltre che riprovevole in materia di diritti umani. La questione però, che finora sembrava di interesse politico solo per i sensibili alle politiche sui migranti, diventa adesso materia per tutti dato che al centro ci sono numeri. Spese stimate al minimo di 200 milioni l’anno per mantenere attive queste latrine più le spese per il rimpatrio. Soldi dei cittadini italiani dirottati per alimentare un meccanismo che di fatto non risolve il problema di nessuno, nemmeno dei fanatici in camicia verde.
Esiste infatti un problema a monte, di ordine politico-culturale, che ha partorito una legge di criminalizzazione, cui si aggiunge poi, beffando i suoi stessi propositori, un’incapacità di gestirne l’applicazione effettiva. Burocrazia, procedure, valutazioni errate e approssimative di iter di identificazione delle persone e dell’accompagnamento alla frontiera, hanno generato un autentico stallo.
E’salito da 60 giorni a 18 mesi il tempo medio in cui cittadini, che possono essere rifugiati, bambini o persone che hanno perduto il lavoro, sono costretti a rimanere dietro le sbarre e il filo spinato di malsane latrine. I rimpatri non sono aumentati, come osserva Kyenge, il che denuncia il flop clamoroso di strutture che avrebbero dovuto salvaguardare l’Italia dall’orda dei clandestini. Il pensiero corre all’Europa dove l’Italia deve ripartire non per stendere i soliti cahiers de doléances, ma per rilanciare la propria geografia, strategica ma anche di estrema vulnerabilità, in una chiave propositiva visto che le nostre forze armate, le associazioni, i volontari e tanti enti locali sono invece attivi, efficaci e spesso straordinarie nelle manovre di salvataggio dei disperati del mare.
Il pensiero corre all’Europa dove l’Italia deve ripartire non per stendere i soliti cahiers de doléances, ma per rilanciare la propria geografia, strategica ma anche di estrema vulnerabilità, in una chiave propositiva visto che le nostre forze armate, le associazioni, i volontari e tanti enti locali sono invece attivi, efficaci e spesso straordinarie nelle manovre di salvataggio dei disperati del mare.
Dirottare i fondi su chi opera nelle procedure di riconoscimento, nell’analisi delle domande di asilo politico, nella gestione separata e dedicata per i minori che arrivano. Nel ripensamento di questi luoghi di “ospitalità momentanea”, sarebbe più onorevole chiamarli in questo modo. Peraltro, i flussi migratori sul lungo periodo lo documentano, seguono delle linee e l’Italia per molti è solo terra di passaggio. Come fu per gli albanesi degli anni Novanta che finirono tutti negli USA.
Oggi, infatti, gli immigrati a pieno regime in Italia, legalmente o meno, sono quasi sempre cittadini comunitari quindi a maggior ragione si tratterebbe di affrontare la questione sul teatro europeo e non sui promontori di Lampedusa. Sul cimitero del mare e nelle gabbie dove quasi sempre, come sempre, a finire schiava è l’Africa. Quel vero peccato originale che aveva l’ex ministro congolese Kyenge.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Si uccidono a centinaia e ci provano a migliaia. Ogni due detenuti che muoiono, uno passa inosservato. Di alcuni si ha certa contezza. “Nel 2013 abbiamo contato, nelle carceri italiane, 6.902 atti di autolesionismo, 4.451 dei quali posti in essere da stranieri, e ben 1.067 tentati suicidi. Cinquecentoquarantadue sono stati gli stranieri che hanno provato a togliersi la vita in cella e che sono stati salvati dalla Polizia Penitenziaria. Più stranieri che italiani si sono resi protagonisti di episodi di ferimenti - quattrocentonovantacinque sui complessivi novecentoventuno - e di colluttazione.
Sulle morti in carcere, invece, il dato si inverte: più italiani. Dei quarantadue suicidi accertati nelle celle lo scorso anno, ventidue erano italiani e venti stranieri e, anche sui decessi per cause naturali, centoundici complessivamente, gli italiani erano la maggioranza, ottantasette. Trasversale, invece, la composizione del numero complessivo di detenuti che hanno dato vita, nel 2013, a ben settecentosessantotto manifestazioni contro il sovraffollamento carcerario a favore di indulto e amnistia: hanno aderito a queste proteste, complessivamente, 85.066 ristretti”.
Questi i dati forniti dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (ma per Ristretti Orizzonti, il notiziario dal carcere, i suicidi sono quarantanove) che confermano che la frequenza dei suicidi tra i detenuti è venti volte superiore a quella che si osserva fra i “liberi cittadini”. Sì perché, numeri a parte, i carcerati sono tutti soggetti a rischio se posti in una situazione a rischio. Con l’intensificarsi del sovraffollamento, con la diminuzione delle opportunità di lavoro interno, delle risorse economiche per il trattamento dei detenuti e del personale penitenziario che se ne occupa, la detenzione diviene appunto un rischio.
Nel dettaglio: la popolazione detenuta, dal sessanta a oggi, è raddoppiata, mentre la capienza delle galere è aumentata solo di diecimila posti; le celle sono ancora dimensionate - otto metri quadrati più quattro per il bagno annesso – in base al Regolamento di Igiene Edilizia delle Strutture ad Uso Collettivo del 1947 e ospitano anche fino a tre inquilini; il lavoro nelle carceri, obbligatorio, è raro; la Riforma della Medicina Penitenziaria, iniziata nel 1999, è ancora in corso e, nel frattempo, bassi investimenti da parte delle Aziende Sanitarie Locali hanno peggiorato i livelli di assistenza per i detenuti malati.
Condizioni disumane che esseri umani, già vulnerabili, percepiscono di meritare perché non più portatori di alcun diritto, di alcuna identità. Con l’horror vacui, tradotto dagli operatori del settore come mancanza di prospettive, che accomuna i suicidi appena arrestati e quelli che stavano per terminare la pena. Il tutto spiegato puntualmente ad Altrenotizie dalla coordinatrice nazionale dell’Associazione Antigone, Susanna Marietti: “Nello scorso 2013, nelle carceri italiane, si sono contati 6.902 atti di autolesionismo e ben 1.067 tentati suicidi, quarantadue dei quali riusciti. Sono numeri sproporzionati rispetto a qualsiasi paragone esterno. Il segno, certamente, di un’utenza carceraria già selezionata in ingresso e andata a pescare in quella fascia di marginalità sociale che più di tutte frequenta la disperazione e la mancanza di prospettive. Ma anche il segno di un’incapacità del sistema di intercettare le singole storie di vita. Dietro ogni suicidio c’è una scelta personale ma c’è anche il fallimento di un’istituzione che non sa leggere la disperazione individuale delle persone detenute”.
Il tutto spiegato puntualmente ad Altrenotizie dalla coordinatrice nazionale dell’Associazione Antigone, Susanna Marietti: “Nello scorso 2013, nelle carceri italiane, si sono contati 6.902 atti di autolesionismo e ben 1.067 tentati suicidi, quarantadue dei quali riusciti. Sono numeri sproporzionati rispetto a qualsiasi paragone esterno. Il segno, certamente, di un’utenza carceraria già selezionata in ingresso e andata a pescare in quella fascia di marginalità sociale che più di tutte frequenta la disperazione e la mancanza di prospettive. Ma anche il segno di un’incapacità del sistema di intercettare le singole storie di vita. Dietro ogni suicidio c’è una scelta personale ma c’è anche il fallimento di un’istituzione che non sa leggere la disperazione individuale delle persone detenute”.
Intanto, dopo appena tre mesi del 2014, i suicidi nelle celle sono già undici. E niente lascia intravvedere un panorama ancor più drammatico per i prossimi mesi. Amnistia, depenalizzazione dei reati minori, abrogazione della Bossi-Fini e della Fini-Giovanardi, che oltre ad essere incostituzionali e condannate dalla giurisprudenza europea, sono le cause principali dal punto di vista numerico del sovraffollamento, restano ancora cammini impercorribili. La politica, del resto, ha cose più importanti di cui occuparsi. O no?
