- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Si è finalmente chiuso, dopo febbrili trattative protrattesi nella nottata, il vertice di Bruxelles. Non poteva mancare, ovviamente, il colpo di teatro dell’ulteriore richiamo alla serietà, diretto all’Italia: cui del resto Silvio Berlusconi ha dato seguito da par suo con una missiva nella quale sostiene che il governo italiano ha finalmente raggiunto l’accordo sull’età pensionabile a 67 anni, oltre a dare una serie di rassicurazioni.
Peccato che, come ricorda stamattina Roberto Petrini su La Repubblica, la proroga dell’età pensionabile era già pienamente operativa già dopo la manovra di Ferragosto. E peccato che, in ossequio al signor Bossi (la cui consorte è andata in pensione d’anzianità molto prima dei cinquanta anni,) il nodo delle pensioni di anzianità non sia stato toccato: non a caso i percettori delle pensioni di anzianità sono soprattutto in “Padania”.
Insomma, alla forzatura politica dell’ulteriore appello in extremis all’Italia un personaggio come il nostro presidente del Consiglio non poteva che rispondere con una burla. Anche se a Bruxelles sembra che la storiella del ritocco alle pensioni e della brillante negoziazione con Bossi se la siano bevuta (o per lo meno, hanno finto in modo convincente).
Nella lettera di Berlusconi salta però fuori una brutta sorpresa che certifica le intenzioni del governo sul mercato del lavoro. Nella missiva, infatti, si promette di dar corso, entro maggio dell’anno venturo, a una riforma che ha come obiettivo rendere più agevoli i licenziamenti dei lavoratori privati a tempo indeterminato per “motivazioni economiche”. La misura non costituisce una novità assoluta, dato che aveva già fatto la sua comparsa nelle pieghe della seconda puntata della telenovela estiva sulla manovra. Nella più benevola delle ipotesi, essa dovrebbe rispondere alla tortuosa argomentazione politica secondo cui una maggior facilità di licenziamento dovrebbe consentire una maggiore facilità di assunzione, e tassi di occupazione più elevati equivarrebbero a più elevato prelievo dal lavoro dipendente.
I precedenti, sfortunatamente, censurano ogni ottimismo. E’ nei fatti la declinazione compiutamente classista con cui il governo ha finora dato seguito ai diktat europei: drenando risorse dall’IVA (che ovviamente pesa più sui lavoratori dipendenti con i redditi più bassi) piuttosto che tassare i patrimoni; proteggendo i ricchi che guadagnano fino a 150.000 euro, dando poi al popolo il contentino della simbolica “punizione” di una manciata di super-ricchi onesti (cosa che peraltro gli è valsa un gettito nell’ordine delle decine di milioni di euro); considerando il patrimonio dello stato come un’occasione per far fare agli amici ottimi affari a prezzo di realizzo anziché un possibile, interessante cespite (con possibili ricadute sociali positive sulle categorie più deboli, impossibilitate ad accedere ad un mercato delle locazioni ancora drogato a dispetto della crisi del mercato immobiliare); infine, non facendo nulla contro l’evasione fiscale, al netto di vuoti proclami dei cui gli evasori si sono abituati a non preoccuparsi.
 In effetti, in un Paese serio un dibattito di questo genere sarebbe accompagnato e sostenuto da proposte credibili di rinforzo del welfare per garantire un sussidio dignitoso fino alla successiva occupazione alle persone rimaste senza lavoro. Non in Italia, dove il Governo sembra un bambino intento a giocare al piccolo chirurgo, veloce di bisturi ma facile ad annoiarsi quando si tratti di ricucire. Non in Italia, appunto, forse l’unico paese al mondo dove programmi socialmente impervi vengono formalizzati ai massimi livelli di formalità internazionale, mentre al dibattito sulle ricadute sociali viene sostituito uno stucchevole monologo televisivo. Il tutto senza contare il piccolo dettaglio che l’eventuale ricorso alla Cassa Integrazione, sbandierato coram populo dal Premier nel salotto degli orrori, a occhio vuol dire maggiore spesa pubblica, in un momento in cui non si fa che parlare di tagli.
In effetti, in un Paese serio un dibattito di questo genere sarebbe accompagnato e sostenuto da proposte credibili di rinforzo del welfare per garantire un sussidio dignitoso fino alla successiva occupazione alle persone rimaste senza lavoro. Non in Italia, dove il Governo sembra un bambino intento a giocare al piccolo chirurgo, veloce di bisturi ma facile ad annoiarsi quando si tratti di ricucire. Non in Italia, appunto, forse l’unico paese al mondo dove programmi socialmente impervi vengono formalizzati ai massimi livelli di formalità internazionale, mentre al dibattito sulle ricadute sociali viene sostituito uno stucchevole monologo televisivo. Il tutto senza contare il piccolo dettaglio che l’eventuale ricorso alla Cassa Integrazione, sbandierato coram populo dal Premier nel salotto degli orrori, a occhio vuol dire maggiore spesa pubblica, in un momento in cui non si fa che parlare di tagli.
Lasciando da parte le deprimenti considerazioni sull’Italia, il vertice di Bruxelles si è chiuso con un accordo formale sui due temi più critici, ovvero la cosiddetta “partecipazione volontaria” alle perdite sui titoli di stato greci e sulla forma tecnica da dare al fondo di stabilità finanziaria europea (EFSF). Quanto al primo punto, l’Euro Summit Statement pubblicato ieri notte ribadisce l’obiettivo di ricondurre il debito greco al 120% del PIL (oggi è al 160%) entro il 2020. Per fare questo, gli Eurostati “chiedono” agli investitori privati di accettare, come rimborso dei loro titoli in portafogli, la metà del loro valore nominale. Per ogni titolo di stato in scadenza, diciamo del valore di 100 euro, il portatore potrà “scegliere” di accettarne 50 cash, ovvero vederselo sostituire con un altro titolo di stato greco con durata molto più lunga (in precedenza si è trattato di titoli trentennali).
Anche se il documento rimanda i dettagli ad una fase negoziale futura, la proposta porta già l’imprimatur di Charles Dallara, supremo capo della IIF (Institute of International Finance) che, stando a Bloomberg, avrebbe confermato per e-mail l’accordo della associazione bancaria. Dallara ha tenuto a precisare che l’eventuale sostituzione con titoli di più lunga durata dovrà avvenire alle stesse condizioni di quelle previste per il rimborso cash, ovvero al 50%. Questo vuol dire che per le banche internazionali è accettabile una dilazione nel rimborso tale che il valore attualizzato dei titoli non sia inferiore alla metà del loro valore nominale iniziale. La buona notizia è che, del pacchetto di 130 miliardi di euro (la famosa “seconda tranche”) ben 30 sono messi a disposizione del Private Sector Involvement, cosa che obiettivamente facilità la sua digeribilità.
 Quanto a EFSF, il summit si chiude con una conferma su “cosa” sarà chiamato a fare: “supportare l’accesso al mercato per gli stati membri che debbano affrontare pressioni di mercato ed assicurare un adeguato funzionamento del mercato del debito sovrano euro, senza compromettere il merito di credito di EFSF”. Tradotto, a regime EFSF prenderà il testimone dalla BCE, rilevandola dallo sgradito compito di acquistare i titoli di stato greci e italiani e fungerà da garante (a pagamento) per le nuove emissioni europee facilitandone il collocamento e tenendo sotto controllo i tassi.
Quanto a EFSF, il summit si chiude con una conferma su “cosa” sarà chiamato a fare: “supportare l’accesso al mercato per gli stati membri che debbano affrontare pressioni di mercato ed assicurare un adeguato funzionamento del mercato del debito sovrano euro, senza compromettere il merito di credito di EFSF”. Tradotto, a regime EFSF prenderà il testimone dalla BCE, rilevandola dallo sgradito compito di acquistare i titoli di stato greci e italiani e fungerà da garante (a pagamento) per le nuove emissioni europee facilitandone il collocamento e tenendo sotto controllo i tassi.
Ma come si finanzierà? Chiuso il possibile rubinetto della BCE e vietato l’incremento di garanzie da parte degli stati membri (come voleva la Germania), EFSF si sosterrà finanziariamente con le commissioni ricevute dagli investitori privati come contropartita della garanzia da un lato e sollecitando il mercato degli investitori privati tramite una serie SPV (“special purpose vehicle”). Sembra davvero che la Merkel sia riuscita nel disperato tentativo di tenere assieme tutti gli angoli della coperta, impedendo un aggravio di costi per i suoi contribuenti, garantendo l’indipendenza della banca centrale, e trovando una soluzione per le nuove emissioni dei paesi a rischio.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF) non avrà la configurazione che gli voleva attribuire Nicholas Sarkozy, ovvero quella di una superbanca pubblica con accesso al credito della Banca Centrale Europea. Troppo forte la contrarietà della Cancelliera e dello stesso Trichet al progetto. Tuttavia, si può ben dire che le divergenze tra Merkel e Sarkozy abbiano trovato una composizione attorno alla visione francese, ovvero al rafforzamento del ruolo di EFSF nella risoluzione della crisi, fortemente ridimensionato dal concetto tedesco di “non un euro di più”.
Il vero compromesso riguarda il modo in cui EFSF verrà messo in condizioni di agire. Esclusa la possibilità di finanziarsi presso la BCE, le ipotesi allo studio sono due: utilizzarlo come una sorta di garante di una quota percentuale delle nuove emissioni dell’eurozona; ovvero lasciargli il suo ruolo di cassaforte per le emergenze, attraverso un “veicolo speciale” dove affluirebbero denari dal Fondo Monetario Internazionale e forse anche quelli di paesi esterni all’area europea (Cina, Brasile, India).
A ben vedere, le due soluzioni riescono in qualche modo a sorpassare il rifiuto tedesco ad immettere in EFSF altro denaro dei contribuenti tedeschi. Per utilizzare una coperta divenuta rapidamente troppo corta, come chiedono il buon senso (ma anche gli americani), solo due erano le possibilità: ridurre l’intervento a una percentuale delle necessità (da qui l’idea di garantire solo una quota delle nuove euroemissioni), oppure chiedere aiuto “fuori casa” (ed ecco che arriva il possibile coinvolgimento dei BRIC).
Non che la soluzione abbozzata sia politicamente indolore per la Cancelliera. Alcuni deputati del suo stesso partito politico le hanno infatti chiesto di riferire nei dettagli il contenuto degli interventi abbozzati nel corso del fine settimana: c’è particolare curiosità sul tema dell’ulteriore rafforzamento patrimoniale del fondo. Così la Merkel ha deciso di sottoporsi un’altra volta allo scrutinio del Parlamento, dove dovrà ottenere l’approvazione prima di volare a Bruxelles per mettere il suo sigillo sulle nuove misure “salva stati”. E’ stato proprio il partito della Merkel a pretendere il passaggio parlamentare, anziché l’approvazione in commissione bilancio, dove i voti ci sono. Ancora più grave il fatto che la richiesta di esporre i dettagli del nuovo piano, avanzata dall’opposizione (socialisti e verdi), era stata rispedita al mittente non più tardi di tre giorni fa.
Sembra comunque che la Cancelliera sia convinta di poter portare a casa l’approvazione parlamentare della nuova versione del pacchetto di salvataggio europeo, usando la sua maggioranza, senza dover ricorrere ai voti dell’opposizione. Il tutto considerando che i famosi 15 parlamentari “amici” che hanno cercato di impallinare il precedente pacchetto di fine settembre sull’incremento della contributo a EFSF con ogni probabilità mercoledì faranno il bis.
Resta aperto, in ordine logico, il tema del deprezzamento del valore dei titoli greci. Se non si sarà fatta chiarezza su tale argomento, è del tutto inutile ragionare di quanto debbano essere ricapitalizzate le banche europee. Sostenere che le discussioni sul rafforzamento patrimoniale delle banche siano a buon punto, perché si è raggiunto un accordo sul quantum (circa 100 miliardi circa) ha pochissimo senso finché non si sia capito con certezza di quanto verranno abbattuti gli attivi delle banche europee, gravati di diverse decine di miliardi di euro di titoli greci nel portafoglio (per non parlare di quelli spagnoli, italiani e portoghesi).
 A guidare il delicato processo di negoziazione con le banche c’è Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro italiano. Il quale, secondo il Financial Times, sabato sera avrebbe ricevuto un mandato da Trichet, Sarkozy e da Madame Lagarde, cioè governo francese, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di un’importante vittoria per Grilli, il quale da sempre ha sostenuto l’idea di aggiungere alla negoziazione politica propriamente detta, una seconda gamba, basata sul dialogo diretto con le banche (rappresentate dall’Institute of International Finance, associazione globale tra istituzioni finanziarie, che conta ben 450 membri in 70 Paesi, o IIF). In effetti, il compito (non facile) di Grilli è di far digerire alle banche la linea dura tedesca, abbracciata ormai anche da Sarkozy: deprezzamento del valore nominale dei titoli.
A guidare il delicato processo di negoziazione con le banche c’è Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro italiano. Il quale, secondo il Financial Times, sabato sera avrebbe ricevuto un mandato da Trichet, Sarkozy e da Madame Lagarde, cioè governo francese, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di un’importante vittoria per Grilli, il quale da sempre ha sostenuto l’idea di aggiungere alla negoziazione politica propriamente detta, una seconda gamba, basata sul dialogo diretto con le banche (rappresentate dall’Institute of International Finance, associazione globale tra istituzioni finanziarie, che conta ben 450 membri in 70 Paesi, o IIF). In effetti, il compito (non facile) di Grilli è di far digerire alle banche la linea dura tedesca, abbracciata ormai anche da Sarkozy: deprezzamento del valore nominale dei titoli.
Nel corso del primo accordo sul salvataggio della Grecia si era riusciti ad evitare il default di Atene, offrendo in alternativa ai portatori di bond ellenici titoli sostitutivi trentennali. Un buon modo per mascherare l’impossibilità di rimborsare i denari presi in prestito e che comunque crea notevoli problemi a tutte le banche, specialmente a quelle che si finanziano prevalentemente con i conti correnti dei clienti (a vista).
Secondo un calcolo di IIF, la dilazione del rimborso dal capitale per un trentennio equivale ad un taglio del valore nominale del 21% (per l’effetto dell’attualizzazione dei flussi futuri). Un taglio del 21% ha ovviamente provocato parecchi malumori tra le banche. Figuriamoci quanto sia facile il compito di Grilli, il cui briefing è convincerle ad accettare un taglio del valore nominale (presente) del 60%.
In altre parole, chi detiene titoli greci per 100 euro, dovrebbe far finta che essi valgano 40 euro e mettere tra le perdite la differenza. E’ evidente che nessun bilancio di nessuna banca europea esposta verso i titoli greci può “tenere” in questa prospettiva; per questo, qualsiasi dibattito sulla ricapitalizzazione delle banche europee è, allo stato, puramente nominalistico. Tanto più che, sempre secondo IIF, sommando l’effetto di dilazione già portato a casa, la perdita in conto capitale arriverebbe a toccare il 75% - 80% del valore nominale.
 Tradotto: i 100 euro nel portafoglio sarebbero così ridotti a circa 20. IIF ha fatto già sapere di non essere in grado di accettare una riduzione del valore attuale dei titoli greci in portafoglio superiore al 40% (il che vuol dire che può accettare al massimo una riduzione del valore corrente di un ulteriore 20%); nel contempo, ha chiesto di portare le garanzie greche (?) dai 35 ai 55 miliardi di euro.
Tradotto: i 100 euro nel portafoglio sarebbero così ridotti a circa 20. IIF ha fatto già sapere di non essere in grado di accettare una riduzione del valore attuale dei titoli greci in portafoglio superiore al 40% (il che vuol dire che può accettare al massimo una riduzione del valore corrente di un ulteriore 20%); nel contempo, ha chiesto di portare le garanzie greche (?) dai 35 ai 55 miliardi di euro.
Il problema del cosiddetto haircut (taglio di capelli, immaginifico nome che nasconde il meno piacevole concetto di banconote in fiamme) non è solo che rischia di mandare in bancarotta diverse banche tedesche e francesi (e pure la BCE, che ha rilevato diverse decine di miliardi di titoli praticamente in default). C’è, infatti, da tenere conto di un possibile effetto a catena, che preoccupa molti analisti, più le persone del Fondo Monetario Internazionale che il governo tedesco, per la verità: se la svalutazione dei titoli greci del 100% (o quasi) dovesse essere accettata (o imposta), si potrebbe parlare di un “credit event” ovvero del fallimento dell’emittente Repubblica greca.
Dunque potrebbero trovarsi seriamente nei guai tutte quelle istituzioni che hanno “scritto” credit default swap sulla Grecia; che, cioè, hanno assicurato terzi (sperabilmente portatori di bond greci) sull’evento “fallimento Grecia”, ricevendone un premio contro rimborso del capitale in caso di sinistro. Anche in questo caso l’equilibrio da trovare è molto difficile. Come spiega una persona a conoscenza dei colloqui al Financial Times, “non c’è bisogno di essere paranoici per essere terrorizzati; [gli attori in gioco] devono trovare un punto di equilibrio tale da non generare il default e allo stesso tempo garantire la sostenibilità del debito greco nel medio periodo.” A differenza di quanto si pensava domenica sera, quando la capitolazione della Francia sulla bancarizzazione di EFSF faceva ben sperare, le difficoltà a trovare una soluzione condivisa sono ancora molte, visto che il 26 ottobre non si riuniranno i ministri finanziari europei, come inizialmente previsto.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Emanuele Vandac
di Emanuele Vandac
Il Vaticano entra nel dibattito sulla crisi finanziaria globale e lo fa con un suo articolato rapporto, presentato ieri mattina in sala stampa vaticana dal cardinale Peter Turkson e dal monsignor Mario Toso, presidente e segretario del Pontificio consiglio per la giustizia e la pace (titolo: “Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di una autorità pubblica a competenza universale”).
Il sistema finanziario è malato, questa la premessa da cui si articola il ragionamento della Santa Sede: dopo la parentesi caratterizzata dagli accordi di Bretton Woods (1944 - 1971), in cui la politica impose al mercato alcuni principi cardine (ruolo centrale del dollaro americano, convertibilità in oro, ancoraggio del tasso di cambio delle principali divise mondiali), sembra proprio che gli animal spirits del libero mercato stiano facendo una gran fatica a mantenere stabilmente in equilibrio i mercati globali.
Secondo il Vaticano, il nuovo ordine sorto dopo la fine di Bretton Woods (1971) è dominato dall’abuso di posizioni dominanti travestite da libero mercato; non solo, la furia speculativa e la sostanziale assenza di regole ha spacciato la “stabilità del sistema monetario globale”, vista come un “bene pubblico universale”. E’ interessante notare come la Chiesa cattolica riconosca all’equilibrio sui mercati finanziari un ruolo non troppo dissimile a quello di altri beni materiali e non, quali il cibo e l’acqua, la libertà e la giustizia.
Si tratta di un riconoscimento importante ed apprezzabile, specie se si considera come la speculazione globale sia in grado di influire (negativamente) sul destino di milioni di cittadini greci, italiani, spagnoli o portoghesi, in gran parte incolpevoli degli eccessi e degli errori dei loro governanti. E come la speculazione sui mercati delle commodities, operando in modo non troppo dissimile da una catastrofe naturale, abbia reso più costoso il cibo, consegnando milioni di uomini donne e bambini alla malnutrizione quando non alla morte per inedia. E’ evidente che la stabilità di un sistema economico fortemente sbilanciato sul versante della finanza non possa essere affidato completamente al libero mercato.
In questo senso, il documento presentato ieri costituisce l’elaborazione di concetti già espressi dal Papa nella sua Enciclica Caritas in Veritas. In quella missiva, inviata il 29 giugno del 2009, Ratzinger chiariva che la Chiesa non ha mai considerato l’agire economico in sé e per sé “antisociale”. E tuttavia metteva in guardia dal rischio che il mercato possa essere orientato in senso negativo per la società, “non perché questa sia la sua natura, ma perché una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso.” Non è dunque lo strumento ad essere sottoposto a scrutinio, quanto l’“uomo, la sua coscienza morale e la sua responsabilità personale e sociale”.
Qui, ovviamente il discorso si fa più attinente allo specifico del magistero della Chiesa e, dunque, meno politicamente fruibile. Eppure, già in Caritas in Veritas, il Papa sosteneva che “l'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica.”Si tratta dunque di ridare alla politica il suo ruolo di guida sul mercato, in modo da consentire la correzione delle storture provocate da interpretazioni estremistiche del liberismo, quali finanziarizzazione patologica e deficit di democrazia e di rappresentatività all’interno dei “club” dove si prendono decisioni che toccano milioni di persone.
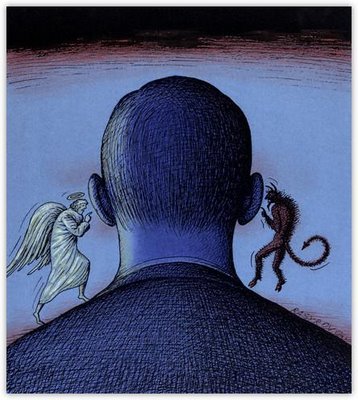 La Chiesa sembra avere le idee chiare su chi dovrebbe farsi carico di questo fardello: una nuova autorità mondiale, figlia di un “accordo libero e condiviso” tra i vari stati, idealmente collocata nell’ambito delle Nazioni Unite. Ad una diagnosi condivisibile si associa dunque una ricetta non troppo convincente: è infatti evidente come venga eluso il tema, centrale, della leadership all’interno del futuro super-organismo di controllo della finanza.
La Chiesa sembra avere le idee chiare su chi dovrebbe farsi carico di questo fardello: una nuova autorità mondiale, figlia di un “accordo libero e condiviso” tra i vari stati, idealmente collocata nell’ambito delle Nazioni Unite. Ad una diagnosi condivisibile si associa dunque una ricetta non troppo convincente: è infatti evidente come venga eluso il tema, centrale, della leadership all’interno del futuro super-organismo di controllo della finanza.
In effetti, anche quello nato nel 1944 a Bretton Woods era un sistema che rispondeva alle esigenze delle nazioni militarmente ed economicamente più forti, e che infatti si è dissolto precisamente quando la nazione militarmente ed economicamente più forte ha deciso che esso non era più sostenibile per suoi motivi interni (i quali per inciso, avevano a che fare con una guerra troppo dispendiosa e non proprio di successo).
In ogni caso è vero che in un mondo fortemente interconnesso, il coordinamento tra gli stati costituisce fattore chiave di successo e la sua mancanza un disastro, come sta dimostrando in questi giorni il teatrino di Francia e Germania in seno all’Eurozona. Tuttavia, prima ancora di speculare su superorganismi sovranazionali, sarebbe più urgente che i singoli stati disciplinassero correttamente i mercati finanziari, impedendone gli eccessi. In questo senso, non sono forse tanto efficaci le tassazioni delle transazioni finanziarie, su cui pure anche il documento vaticano si esercita, quanto piuttosto una misura semplice, che equipari gli strumenti derivati ai farmaci: finché non si comprenda pienamente il loro senso e la loro utilità (nel caso di specie, anche sociale) dovrebbero semplicemente essere vietati dalla legge.
E non da un solo Paese, ma da tutti, per evitare distorsioni. In ogni caso, è quantomeno ironico che uno stato come il Vaticano, che oggi parteggia per un aumentato ruolo delle istituzioni, possieda una banca come lo IOR, che ha impiegato ben 53 anni costellati di episodi non edificanti prima di accettare di essere soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Emanuele Vandac
di Emanuele Vandac
Non si trova ancora un accordo tra Francia e Germania sulle decisioni da prendere nel super-summit che si terrà a Bruxelles il prossimo fine settimana. O per lo meno questa è l’impressione che si sono fatti i mercati. L’agenda ufficiale prevede un primo incontro venerdì tra i 17 ministri delle finanze dell’Eurozona, ed una seconda tornata di incontri che includono anche i rimanenti dieci. Domenica, invece, sono previsti meeting dei leader europei, e 27 e poi a 17.
Nella serata di giovedì, a mercati europei chiusi, un comunicato congiunto dei rappresentanti di Francia e Germania ha spiegato che sarà necessario un secondo incontro, da tenersi al più tardi il mercoledì successivo, per dare piena implementazione alle decisioni prese durante il week end. Una decisione senza precedenti, che tra l’altro sembra sia stata presa dal duumvirato franco-tedesco senza nemmeno consultare i rappresentanti degli altri Paesi.
La gravità del disaccordo tra Francia e Germania è segnalata anche dall’improvviso viaggio di Sarkozy a Francoforte, dove si è recato lo scorso mercoledì dopo aver visitato la moglie in travaglio. Non sembra però che questo incontro programmato abbia appianato le controversie dei due. Uno dei temi più controversi è il ruolo dell’EFSF (European Financial Stability Facility). Sembra ormai chiaro che la dotazione attuale, recentemente portata a 440 miliardi di euro, non sarà sufficiente a farne quel “super-bazooka” contro la speculazione che vorrebbero Oltralpe. Come rendere il fondo patrimonialmente più robusto è tutta un’altra cosa. Sarkozy, spera che EFSF gli tolga le castagne dal fuoco, ovvero sostenga le banche francesi che potrebbero andare incontro a serie difficoltà nel caso passasse la linea dell’haircut (taglio di capelli, ovvero svalutazione) del 50 - 60% sui titoli greci.
Poiché però “nulla si crea e nulla si distrugge” (e se qualcuno dice che in finanza è possibile anche il contrario é meglio non dargli retta) lo ESFS potrebbe affrontare la possibile futura grana francese solo in due modi: con nuove garanzie prestate dagli euro-stati oppure trasformandosi in una super-banca pubblica. Poiché Sarkozy sembra pronto perfino a mandare a fondo il continente pur di non rischiare la tripla A del suo debito sovrano (tema elettoralmente pesante, pare), la strada delle garanzie della République non è praticabile. Da qui nasce la sua idea di trasformazione di ESFS in una vera e propria banca pubblica, che chiederebbe soldi in prestito alla Banca Centrale Europea. E qui naturalmente Sarkò non può che scontrarsi con il tonante “nein” della Cancelliera. Non solo, anche il presidente della BCE, il connazionale Trichet, è contrario: tutto da vedere quale sarà l’atteggiamento di Draghi.
 A complicare le cose, c’è la Grecia, con il suo bisogno spasmodico di cash: se entro novembre non verrà sbloccata la seconda tranche di 8 miliardi di aiuti messi a punto da EU e da Fondo Monetario Internazionale, il paese ellenico sarà ormai anche ufficialmente in default. La pressione della Grecia da un lato e le visioni inconciliabili dei due leader europei dall’altro irritano comprensibilmente il Fondo Monetario Internazionale che, a quanto riporta stamani il quotidiano britannico The Independent, ha fatto sapere che la sua approvazione alla seconda tranche arriverà solo al termine del meeting europeo (quello “vero”, non quello inizialmente programmato per questo fine settimana, evidentemente ormai privo di qualsiasi autorevolezza). Il Fondo, infatti, attende risposte dagli europei sul tema delle stime di riduzione del debito greco fatte dai politici europei, bollate come “troppo ottimistiche”dall’organizzazione internazionale.
A complicare le cose, c’è la Grecia, con il suo bisogno spasmodico di cash: se entro novembre non verrà sbloccata la seconda tranche di 8 miliardi di aiuti messi a punto da EU e da Fondo Monetario Internazionale, il paese ellenico sarà ormai anche ufficialmente in default. La pressione della Grecia da un lato e le visioni inconciliabili dei due leader europei dall’altro irritano comprensibilmente il Fondo Monetario Internazionale che, a quanto riporta stamani il quotidiano britannico The Independent, ha fatto sapere che la sua approvazione alla seconda tranche arriverà solo al termine del meeting europeo (quello “vero”, non quello inizialmente programmato per questo fine settimana, evidentemente ormai privo di qualsiasi autorevolezza). Il Fondo, infatti, attende risposte dagli europei sul tema delle stime di riduzione del debito greco fatte dai politici europei, bollate come “troppo ottimistiche”dall’organizzazione internazionale.
Ci sono varie “ricette” sul tavolo per uscire dalla crisi, anche se un vero progresso è impossibile a causa dei veti incrociati dei singoli attori: il deprezzamento dei titoli greci incontra il favore della Grecia, che vedrebbe così tagliati i suoi debiti. Ma è fortemente avversato dalle banche e dalla BCE, che, assieme, detengono circa 65 miliardi di euro di obbligazioni “made in Greece”. Tutti i leader, in generale, sono d’accordo sul tema della (necessaria) ricapitalizzazione delle banche europee. Il vero tema è: come? Ricorrendo al mercato o con l’aiuto pubblico (e nel secondo caso, pubblico vuol dire stato sovrano o EFSF?).
I banchieri europei (ovvero i diretti interessati) vedono il ricorso al mercato come il fumo negli occhi. E hanno gioco facile: infatti, qui si parla di mantenere un certo “ratio” (rapporto, frazione) tra attivo e passivo, il quale, per definizione, può essere conseguito anche con livelli diversi di numeratore (attivo) e denominatore (patrimonio).
Se le banche non vogliono rafforzare il patrimonio battendo cassa sui mercati, possono sempre ridurre il loro attivo, senza toccare il patrimonio. Tradotto: possono cominciare a non prestare più denaro alle aziende e ai privati, lavorando nella direzione della crisi e dandole nuove munizioni. Fa sorridere pensare che tutti questi problemi, che si trasformano in un gigantesco e pericolosissimo esercizio a chi tira la coperta da una parte o dall’altra, si risolverebbero semplicemente procedendo convintamente al salvataggio della Grecia. Ma sembra che i leader siano troppo preoccupati di ossequiare dogmi per evitare il disastro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Non bastavano i contrasti tra i premier dei due Paesi più importanti dell’Unione Monetaria sul modo in cui l’Europa debba affrontare la crisi indotta dalla speculazione anti-euro; né l’incertezza e la preoccupazione generate dalla crisi di Dexia, una banca con un’esposizione al rischio credito pari al 170% del PIL greco. A quanto pare, alla finanza pubblica europea e alla sua deprimente politica non poteva mancare il tocco surrealista, assicurato in questo caso dal governo di coalizione slovacco, che alla fine ha mantenuto la sua folle minaccia di non approvare il pacchetto di intervento finalizzato a rafforzare la European Financial Stability Facility (EFSF).
Già, perché mentre il Continente è in fiamme, il governo di un paese con una popolazione di cinque milioni di abitanti, che ha adottato l’euro il primo gennaio del 2009 e attualmente contribuisce al Fondo di stabilità finanziaria con una quota inferiore all’1% si sta comportando da bambino viziato. E ciò a dispetto del fatto che, secondo un sondaggio citato da Reuters, poco meno della metà degli slovacchi si sia detta favorevole al piano anti-crisi e il 36% contraria.
L’assurda situazione di stallo è causata dalle norme europee, secondo cui le modifiche al Fondo, per essere valide, devono essere ratificate da 17 degli Stati che adottano l’euro: i governi di sedici Paesi hanno approvato le disposizioni di ratifica, e ora manca solo Slovacchia. Una regola certamente ispirata dalla più pura delle aspirazioni democratiche, ma che, applicata senza riguardo al peso demografico ed economico di ogni singolo Paese, è solo un pericolosissimo impaccio.
 Va dato atto alla premier Iveta Radicova di essersi molto spesa tanto sul fronte esterno che internamente per tentare di rassicurare i partner europei da un lato e per convincere il suo governo ad approvare il pacchetto dall’altro. Il voto di fiducia, però, è servito solo a far cadere il suo governo. Infatti, su 124 deputati presenti in aula, solo 55 si sono espressi a favore della ratifica (per l’approvazione sarebbero stati necessari 76 voti), mentre nove sono stati i deputati che hanno votato contro.
Va dato atto alla premier Iveta Radicova di essersi molto spesa tanto sul fronte esterno che internamente per tentare di rassicurare i partner europei da un lato e per convincere il suo governo ad approvare il pacchetto dall’altro. Il voto di fiducia, però, è servito solo a far cadere il suo governo. Infatti, su 124 deputati presenti in aula, solo 55 si sono espressi a favore della ratifica (per l’approvazione sarebbero stati necessari 76 voti), mentre nove sono stati i deputati che hanno votato contro.
Molti gli assenti e i “non registrati per il voto”, tra cui diversi appartenti a SaS (Libertà e Solidarietà), il partito liberal/libertarian euroscettico fondato nel 2009 e presieduto dall’economista ed imprenditore Richard Sulik. Fino a ieri, il SaS è stato uno dei quattro partiti della coalizione di governo di centro destra presieduto dalla Radicova (gli altri sono L’unione cristiana e democratica slovacca, il Movimento Democratico Cristiano ed il partito etnico ungherese).
Sulik non ha fatto mai mistero della sua contrarietà al provvedimento, che considera un’iniqua redistribuzione di denaro pubblico al settore privato. Dimostrando una miopia e una ristrettezza di visioni non comune e un’aperta indifferenza alla gravità della crisi che sta attraversando l’Unione monetaria, Sulik ha dichiarato candidamente: “La Slovacchia non ha la responsabilità di salvare il mondo (...). Lasciamo che le Borse crollino, e le azioni scendano di prezzo. Vorrà dire che saranno meno care e che la gente vorrà comprarle. Si chiama libero mercato, domanda e offerta”.
Biascicando il suo mantra libertarian ai media europei, Sulik avrà anche avuto il suo quarto d’ora di notorietà, ma ora è isolato grazie al buon senso degli altri membri del Parlamento slovacco. Il ministro delle finanze, Ivan Miklos, ha infatti dichiarato che “in un modo o nell’altro” il provvedimento verrà approvato. Si lavorerà nella direzione suggerita dalla premier alla conferenza stampa organizzata subito dopo il voto, nel corso della quale pare che abbia a stento trattenuto le lacrime: i tre partiti residui della coalizione cercheranno un accordo con Smer, il partito di centro sinistra dell’opposizione, al fine di arrivare all’approvazione entro la fine della settimana. A quanto risulta a Reuters, esisterebbe già un patto che prevede un rimpasto o le dimissioni del governo in carica (per l’ordinaria amministrazione) come contropartita del voto favorevole del partito di centro sinistra capeggiato dall’ex primo ministro Robert Fico.
Una volta incassato in un modo o nell’altro l’ok della Slovacchia, l’Europa dovrà affrontare problemi meno grotteschi, ma altrettanto preoccupanti: prima tra tutti, la questione dell’insufficienza delle misure tanto faticosamente ratificate.
