- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Ynet, il sito web del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, non ha dubbi: lo Stato ebraico sta per subire un nuovo attacco. L’informazione si riferisce ad una indiscrezione divulgata dalla testata saudita Ozak, secondo la quale in Libano sono certi che le crescenti tensioni tra Gerusalemme e Damasco sarebbero dovute all’atteggiamento di sfida di Hezbollah, che si starebbe preparando ad affrontare una escalation militare tesa a colpire Israele.
La possibilità che in Medio Oriente si stia andando incontro ad un nuovo conflitto viene confermata anche dal giornale pan-arabo Al Sharq Al Awsat, il quale rivela che l’esercito del presidente Bashar al-Assad starebbe già richiamando in servizio i militari incorporati nella riserva, e dalla stessa stampa siriana, che in editoriale pubblicato sabato 6 febbraio dal quotidiano filo-governativo Tishreen, parla di una esplicita volontà israeliana di dare il via ad una nuova guerra e delle possibili conseguenze.
Nonostante Benjamin Netanyahu si sia impegnato in una storica apertura verso il mondo arabo - “Israele anela ad accordi di pace con tutti i suoi vicini. Lo abbiamo fatto con l'Egitto e con la Giordania, possiamo farlo anche con la Siria e i palestinesi” - la tensione è ormai alle stelle. A buttare benzina sul fuoco sarebbe proprio il presidente iraniano Ahmadinejad, che nel Giorno della Memoria non ha perso l’occasione per ricordare al mondo la sua posizione: “Arriverà il giorno della vostra distruzione”. Un avvertimento che, alla luce degli scontri verbali che negli ultimi tempi hanno visto di fronte lo Stato ebraico ed Hezbollah, accentua la certezza che in Medio Oriente la crisi politica potrebbe presto trasformarsi in un nuovo conflitto. E proprio in questo contesto che va anche vista la risposta del ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman, che dall’Università Bar-Ilan di Tel Aviv ha ricordato a Damasco che “il regime siriano è destinato a cadere se continuerà a provocare Israele….. Se la Siria dichiarerà guerra allo Stato ebraico non solo perderà il conflitto ma il regime di Bashar Assad crollerà”.
Le affermazioni di Lieberman si riferiscono ad un carico di armi che comprende circa 100 missili terra-terra a medio raggio e che a gennaio l’Iran avrebbe fornito alla Siria. Scaricato in una non meglio precisata base militare, il carico avrebbe poi preso la via del Libano della Striscia di Gaza e sarebbe andato a rinforzare l’arsenale del movimento sciita Hezbollah e dei gruppi armati legati ad Hamas. A conferma di tale tesi ci sarebbe il ritrovamento di due casse, contenenti ciascuna circa 10 chilogrammi di esplosivo, rinvenute il 1° febbraio scorso sulle spiagge di Ashkelon e Ashdown, porti israeliani a circa 25 chilometri da Gaza. Il sospetto è che il materiale bellico faccia parte di un carico ben più consistente e che i due container siano stati lasciati alla deriva in attesa che qualche peschereccio li recuperasse per poi scaricarli di fronte alle coste della Striscia di Gaza.
Il 3 febbraio scorso era stato lo stesso presidente Assad a puntare il dito contro Gerusalemme, accusando gli israeliani di essere alla ricerca di un pretesto per scatenare un conflitto e il ministro degli Esteri siriano, Walid Moallem, tuonava: “Israele sa che questa volta gli effetti della guerra arriveranno fino alle sue città … lo Stato ebraico non deve più indirizzale le sue minacce contro Gaza, il Libano meridionale, l’Iran ed ora anche contro la Siria”. Dichiarazioni che, per Tel Aviv, confermerebbero i sospetti israeliani sull’esistenza di un patto segreto che legherebbe la Siria e l’Iran ai due movimenti armati e che sarebbe stato sottoscritto nel dicembre scorso a Damasco dal ministro della Difesa siriano, Generale Ali Habib, dall’omologo rappresentante iraniano, Generale Ahmad Validi, e dal leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Israele è seriamente preoccupata per il riarmo del movimento sciita libanese e, nel caso di un altro scontro, ha già minacciato che questa volta l’attacco sarebbe devastante; l’allerta è tale che nelle scorse settimane le Forze di Difesa Israeliane sono state impegnate in una manovra militare su vasta scala che ha interessato anche il confine settentrionale con il Libano: l’esercitazione Home Front Command. Chi sembra piuttosto tranquillo è il leader di Hezbollah, che al contrario, nei confronti di Israele, continua a mantenere un atteggiamento di apparente sfida; Nasrallah non nasconde che i suoi miliziani sono pronti ad affrontare un nuovo conflitto e si dice fiducioso in una “nuova e schiacciate vittoria”. Una guerra psicologica che rientrerebbe nel normale confronto tra due acerrimi nemici se non fosse per le informazioni che arrivano dai servizi d’intelligence, che smentiscono quanto sostiene la forza di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano, e cioè che non c’è alcuna indicazione che sia in atto la preparazione di una nuova escalation militare.
In Israele c’è chi pensa che Teheran stia già preparando il terreno per rispondere ad un sempre più probabile attacco israeliano agli impianti nucleari di Natanz e Isfahan, soprattutto ora che la Repubblica Islamica ha pubblicamente dichiarato di voler produrre uranio arricchito al 20%, gradazione di U235 che potrebbe già aver raggiunto e che sarebbe sufficiente per la costruzione di un’arma nucleare cruda, molto inefficiente ma estremamente pericolosa. Per far questo starebbe cercando di stimolare uno scontro che impegni Israele su tre fronti: con Hamas lungo la Striscia di Gaza, con la Siria sulle alture del Golan e con Hezbollah attraverso il confine libanese. Migliaia di miliziani addestrati in Iran a combattere nelle aree urbanizzate della Galilea sarebbero pronti ad invadere Israele da diversi settori: dalla comunità di Ramot Naftali, con i kibbutz di Malkia e Yiftah e la collettività agraria di Dishon, alla città costiera di Nahariya, sul Mar Mediterraneo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Benedetti
di Carlo Benedetti
Mosca. C’erano pacche sulle spalle, scene da caserma, mosse per nulla diplomatiche. In pratica, una serie di azioni tipiche di un parvenù alla corte del re di Russia. Tutto mostrato e raccontato dai media occidentali. Ma in Russia - quanto a diffusione delle notizie e delle immagini - ogni aspetto era sempre programmato e incanalato da un ben protetto ordine di servizio che il Cremlino aveva imposto alla stampa. Ora, però, sembra che qualcosa si sia rotto. Perchè su Berlusconi arriva il tormentone di un programma televisivo che lo vede al centro di un serial di cartoon satirico in 3D, lanciato dal primo canale e diffuso in tutto il paese.
Ed ecco che accanto ai pupazzetti di Medvedev e Puntin che ballano il saltarello russo nella piazza Rossa compare un compunto Berlusconi che si impegna a ballare con alcune tettone locali, con la cantane Alla Pugaciova, ad esempio... Ma non disdegna la snella Julia Timoshenko... Poi fa il bello con l’Angela Merkel e via di seguito. Nulla di male - dice il direttore del canale, Konstantin Ernst - perché non dobbiamo rendere conto a nessuno. E così il nostro premier entra nella galleria dei personaggi sui quali la Russia si ritrova unita nelle risate.
Ma non c’è solo la tv che si impegna sul fronte della riscoperta del Cavaliere. Arrivano su di lui dieci pagine a colori nel mensile Biografia. Il titolo di copertina è già tutto un programma: “Silvio Berlusconi: noi tutti siamo dei play boy”. E via con fotocolor che per i russi sono una vera novità in quanto rompono quel clima di ufficialità che sempre caratterizza Mosca nei rapporti con i leader stranieri. Ecco le immagini seguite da ben precise didascalie: “Berlusconi, comandante dell’equipaggio”; “Pensatore”; “Religioso”, “Ottimista”; “Vigile del fuoco”; “Patriota”. Seguono le foto dell’infanzia e della famiglia. Tutto per passare poi ad una affermazione di Veronica Lario: “Sono stanca delle sue donne” ...
Seguono quindi altre foto con relative note di commento. C’è un Berlusconi che guarda, soddisfatto, le gambe di una miss. Il titolo è: “La bellezza salva Roma”, con un testo che sottolinea che il premier è convinto del fatto che “le italiane sono le donne più belle del mondo. Ecco quindi un Berlusconi che accarezza Sarkozy e la didascalia che riporta una sua frase a proposito delle donne francesi... poi di nuovo al summit del 2009 con Barak Obama e Sarkosy impegnato a guardare il sedere di una hostess.
Eccolo con Putin in un’immagine non protocollare, seguìta dalla notizia dove si precisa che Berlusconi ha cantato al premier russo una canzone che dice: Io penso sempre a te...”. E ancora c’è il nostro che passa in rassegna un picchetto d’onore, ma la didascalia ricorda che in Italia lo definiscono come “un appassionato della dolce vita o un imperatore del XXI secolo”. E per finire viene ripreso sorridente, soddisfatto e sicuro: “Fa sempre ginnastica, rispetta una dieta e nel 2004 addirittura si è sottoposto ad un trapianto di capelli”.
Ma in questa orgia di foto e di battute c’è anche spazio per qualche pagina sul Berlusconi politico. E in questo s’impegna uno degli osservatori più attenti alle questioni italiane: il giornalista Aleksei Bukalov. E’ lui che sul settimanale moscovita Novoe Vremja - The new times si occupa delle vicende giudiziarie del premier e della decisione della Corte Costituzionale relativa all’immunità per le più alte cariche dello Stato. Il settimanale non manca di rilevare che “il 73enne Berlusconi è accusato di servirsi di servizi di prostitute e di avere relazioni con minorenni”. Anche per l’autore del servizio in questione vale quel motto che rese famoso il “Panorama” di Lamberto Sechi: “I fatti separati dalle opinioni”...
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mazzetta
di Mazzetta
Gilgel Gibe è il nome di una serie di opere idrauliche molto discusse, pensate e realizzate dalla ditta Salini in Etiopia con il placet e i finanziamenti dei governi italiani. Gilgel Gibe I è una diga tradizionale, costata 280 milioni di Euro, che non ha dato i risultati sperati, finendo per procurare grossi danni ambientali e materiali senza contribuire minimamente allo sviluppo del paese. Il problema è che la dittatura etiope ha fame di “sviluppo”, ma di quello dei patrimoni dell'oligarchia etiope, stretta intorno alla sanguinaria dittatura di Meles Zenawi.
Per questo nei piani dell'azienda di stato per l'energia elettrica EEEPCo, spunta di quando in quando una diga. La diga è un ottimo progetto sul quale lucrare, perché produce energia pulita che è sinonimo di sviluppo sostenibile; poco importa poi se l'energia prodotta viene venduta all'estero e i guadagni spariscono nelle tasche dei soliti noti. Un'epopea raccolta nel rapporto “L'affare Gilgel Gibe”, lo stesso rapporto che ha spinto la BEI a chiamarsi fuori dal progetto sotto la pressione di Counter Balance, “Friends of Lake Turkana”, “International Rivers” e l'italiana “Campagna per la riforma della Banca Mondiale”.
Numerose organizzazioni internazionali hanno cercato di contrastare l'andazzo e alla fine anche la Banca Europea per gli Investimenti ha deciso di non finanziare la costruzione di Gilgel Gibe III, giudicata inutile perché all'energia che dovrebbe produrre non risponde ad alcuna domanda di consumo. In mezzo i due progetti ci sta Gilgel Gibe II, l'impianto inaugurato pochi giorni fa da Frattini con un profluvio di buone parole e subito fermato dal crollo dell'opera. Ovviamente l'inaugurazione e il viaggio di Frattini hanno ricevuto ampia copertura dai media nazionali, mentre il crollo dell'opera ha attirato scarsa attenzione. Gilgel Gibe II ha avuto una genesi singolare, già finita all'attenzione della magistratura; la costruzione dell'opera è stata affidata - senza gara - alla ditta Salini, uno dei maggiori gruppi italiani nel campo delle costruzioni.
Il contratto per Gilgel Gibe II è stato affidato in difformità dalle leggi etiopi, ma da là nessuna protesta e nessuna collaborazione alle diverse inchieste internazionali. Difficile dire che fosse almeno in conformità alle leggi italiane ed europee, vista l'assenza di una gara (obbligatoria) e visto che un documento fondamentale come la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) e tutte le perizie sono state prodotte in Italia da associate alla ditta Salini. Ma i problemi non sono solo formali, perché l'accordo per la costruzione dell'opera restituisce uno scenario a dir poco curioso.
Il progetto è stato finanziato in parte simbolica da organismi internazionali (su tutti la BEI con 50 milioni di Euro), per buona parte dai fondi che l'Italia mette a bilancio per gli aiuti allo sviluppo e per parte comunque rilevante dall'Etiopia, che si è indebitata per l'intera cifra, visto che gli aiuti sopra elencati sono prestiti. L'iter dell'accordo è stato sicuramente facilitato dalla cancellazione di oltre 300 milioni di Euro di debito etiope, concessa dall'Italia e ratificata nei giorni immediatamente successivi alla firma dei contratti.
Per Gilgel Gibe II non sono stati d'ostacolo nemmeno i pareri negativi di diversi uffici ministeriali, così l'Italia ha concesso un credito di 220 milioni di Euro (più 505.000 “donati” per retribuire un “esperto” a controllare i lavori). In pratica abbiamo abbuonato i debiti agli etiopi e loro in cambio si sono indebitati subito più o meno per la stessa somma per costruire Gilgel Gibe II, che è una galleria di 27 km che per produrre energia sfrutta la differenza di quota tra il bacino di Gilgel Gibe I e il letto del fiume Omo più a valle. Poi è successo che una scavatrice è rimasta imprigionata nella galleria (è ancora là) e i costi per l'Etiopia sono lievitati.
Curiosamente, il rischio geologico in questo caso non era a carico del costruttore; così l'opera, che era partita senza nemmeno uno studio geologico, è diventata più cara e il debito dell'Etiopia ha superato quanto abbuonato. Poi si arriva ai giorni nostri, con Frattini che inaugura e la galleria, che dopo qualche giorno crolla. Danno questa volta a carico del costruttore, già lanciato verso il perfezionamento del contratto per Gilgel Gibe III, una miniera da un miliardo e mezzo di dollari che, se realizzata, comporterà un aumento di tre o quattro miliardi di dollari per il debito estero etiope. I 220 milioni a Salini li ha dati il governo italiano, che ha garantito anche i crediti nei confronti dell'Etiopia: se gli etiopi non pagheranno, se l'opera dovesse risultare inutilizzabile o se emergeranno altri inconvenienti, bisognerà far causa a Salini per riavere almeno parte del denaro, sempre che ci sia la volontà politica per farlo rischiando di attirare attenzione su questo disastro e sempre che non arrivi prima l'inchiesta penale a sparigliare le carte.
Questo incidente rischia di essere per Salini un problema superiore all'aperta ostilità della BEI, che rifiuta di finanziare il progetto, o alle relative difficoltà burocratiche in Italia, anche se ormai il contratto tra governo etiope e Salini è stato firmato nel 2006. Oltre ai finanziamenti manca la copertura della SACE (la Società assicuratrice del credito all’esportazione), la società pubblica che in questi casi garantisce gli impegni dei paesi esteri nei confronti delle aziende italiane, senza la quale il rischio di mancati pagamenti è a carico di Salini, che per ora ha rifiutato di fornire la sua garanzia.
Ma la fretta ha provocato altri inconvenienti. La VIA, ad esempio, riguarda solo la parte monte della diga, un'anomalia evidentissima, ed è stata prodotta dalla CESI (associata di Salini, la stessa che ha firmato la VIA per Gilgel Gibe II) appena un mese prima della firma del contratto, rendendo molto difficile l'approvazione di un'opera con una genesi del genere, a meno di non nominare Bertolaso commissario per Gilgel Gibe e dotarlo della solita discrezionalità di spesa in nome dell'emergenza.
Per ora sembra che solo la Banca Africana d'Investimento abbia promesso un prestito modesto, vincolato all'acquisto dei macchinari necessari, da effettuarsi obbligatoriamente con una gara internazionale. Tra i possibili cavalieri in aiuto restano solo il governo italiano e quello etiope, che ha già speso parecchio (indebitandosi ulteriormente) per la fase III e che dovrebbe quindi ricorrere al mercato per esporsi con una cifra altissima, pagando interessi più alti di quelli offerti in passato dai partner nell'impresa. Difficoltà che colpiscono i progetti futuri di Salini, ma che non incrineranno la redditività delle operazioni pregresse.
Simonpietro Salini (già iscritto egli elenchi P2 al numero 531 “in sonno” e noto come Simone l'africano) è già uscito vittorioso da imprese simili in Uganda, in Sierra Leone e ancora in Etiopia, ai bei tempi dei governi del Caf, quando il Fondo Aiuti Italiani spendeva migliaia di miliardi tra Somalia ed Etiopia e Salini ne vaporizzava una buona parte nel progetto del Tana Beles, voluto da Menghistu, dove ora non rimane nulla.
Le donazioni e i prestiti del governo Berlusconi sono criticati dall'OSCE, perché hanno di fatto trasformato gli aiuti ai paesi poveri (anche quella quota tanto misera da far guadagnare a Berlusconi l'accusa di “taccagno”) in aiuti di Stato alle aziende italiane e in finanziamenti occulti alla corrotta dittatura etiope. Una mascherata che non ha ingannato nessuno, ma che grazie alla collaborazione dei corrotti governi locali e al disinteresse dei media italiani sembra destinata a passare impunita e a ripetersi nel tempo.
L'ultima evoluzione di Salini è infatti la sua acquisizione da parte di Todini Spa, che fa del nuovo gruppo il terzo per dimensione in Italia. Probabilmente Luisa Todini, esponente di spicco di Forza Italia e leader del nuovo gruppo, avrà meno difficoltà a trovare le coperture finanziarie necessarie a completare questa e altre opere discutibili.
Forse è il caso di prepararsi a “donare” ancora una volta all'Etiopia e a un'altra sceneggiata come quella con la Libia. Berlusconi chiederà perdono all'Etiopia per il colonialismo e offrirà come riparazione i soldi per la grossa diga alla dittatura etiope e vivranno tutti felici e contenti, superando con brillantezza tutti i lacci e laccioli che penalizzano la nostra imprenditoria nella sua proiezione sui mercati esteri. Peccato solo che gli etiopi che vivono nella zona interessata dai lavori vedranno le loro vite sconvolte, che gli altri etiopi non potranno comunque usare l'energia prodotta dalla diga e che i contribuenti italiani continueranno a finanziare questo genere di buchi nel fango che inghiottono centinaia di milioni di Euro in nome dell'aiuto ai paesi sottosviluppati.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Giuseppe Zaccagni
di Giuseppe Zaccagni
Messa in archivio la “rivoluzione culturale” l’attuale dirigenza cinese lancia ora - nel quadro di una politica caratterizzata da ampi spazi di ripensamento - la “rivoluzione commerciale”. Lo fa, come ebbe a spiegare il vicepremier Li al Forum di Davos, per incrementare la domanda interna e sganciare l’industria “dall’eccessiva dipendenza dalle esportazioni”. Ed è questo, da oggi, il nuovo modello di sviluppo che si concentra su un mercato potenziale di oltre un miliardo di consumatori. Di conseguenza l’ingresso in Cina di merci estere verrà sempre più regolamentato e limitato.
Per ora, quindi, rimane una situazione di protezione delle ditte cinesi e il governo vuole fare leva anche su ciò per incrementare il consumo interno e trovare un “nuovo” mercato per i molti prodotti finora esportati. I dati in merito sono chiari: le importazioni cinesi sono state pari a oltre 1.000 miliardi di dollari nel 2009, ponendo Pechino come secondo maggior Paese importatore dopo gli Stati Uniti; anche se il dato - come scrive il magazine Time Asia - non consente di accertare quale sia la parte di materie prime e quali i prodotti lavorati o semilavorati.
E’ noto comunque, tra quanti seguono gli andamenti dei mercati finanziari asiatici, che i rapporti economici tra Cina e Stati Uniti sono strettissimi e per l’America il legame è sempre più “strangolante”. Un dato significativo riguarda il bilancio dell’import-export: lo scorso anno gli Stati Uniti hanno importato da Pechino beni per 27,9 milioni di dollari contro i 5,8 milioni di export delle industrie statunitensi verso la Cina. Pechino, inoltre, detiene circa 790 miliardi di dollari di buoni del tesoro Usa (o “debito” Usa), più di un decimo del totale, e ogni anno incassa 50 miliardi di dollari di interessi.
Ma non tutto fila liscio. Anzi, si delineano alcune nubi cariche di problemi che sollecitano una certa pluralità di interpretazioni. Perchè nonostante una crescita prevista del 16%, questo 2010 potrebbe anche essere un anno durissimo dal punto di vista finanziario. Il rischio, infatti, è che esploda la bolla relativa alle proprietà immobiliari e che aumenti in maniera vertiginosa l’inflazione, facendo così decollare il costo della vita. Lo sostengono due ricercatori che operano nelle stesse strutture del governo cinese, Yao Zhizhong e He Fan, che in un articolo sull’organo ufficiale China Securities Journal avvertono: “Se il governo continua a immettere stimoli economici pari a quelli del 2009, l’anno appena iniziato sarà molto pericoloso”.
I problemi principali riguardano l’inflazione, in rapida crescita dopo l’immissione di troppo denaro contante da parte di Pechino e la bolla immobiliare. Se questa dovesse esplodere, l’economia reale del Paese - considerando l’indotto collegato alla produzione edile - ne risentirebbe fortemente, con conseguente aumento della disoccupazione e lo stop del settore.
L’allarme dei due economisti (che potrebbe anche annunciare effetti devastanti) nasce dai prestiti bancari concessi dalla Cina nella prima settimana di gennaio, per un valore totale di 600 miliardi di yuan (circa 60 miliardi di euro). Ovviamente, la cifra scaturisce dallo sblocco dei fondi delle richieste presentate alla fine del 2009, ma rappresenta comunque un introito valutario estremamente ampio. I prestiti sono confermati sempre dal China Securities Journal, che cita come fonte Ba Shusong, vice direttore dell’Istituto di finanza del Consiglio di sviluppo statale.
Secondo i due economisti, Pechino dovrebbe dunque limitare gli stimoli. Ma il ministro cinese delle Finanze, Xie Xuren, non è d’accordo. Ha definito “pericoloso” interrompere troppo presto le politiche di sostegno all’economia. Secondo Xie, tuttavia, le misure “dovrebbero aiutare a implementare il consumo interno dei nostri prodotti”. All’atto pratico, ha concluso il ministro, “dovremmo agire per aumentare i salari, in particolar modo quelli degli operai e dei contadini; riformare le politiche di tassazione e continuare a spendere per i lavori pubblici, come scuole e ospedali”.
E mentre informazioni e polemiche si susseguono il vicepremier Li promette “ampie riforme” al fine di permettere al mercato di giocare un ruolo primario nella distribuzione delle risorse. A commento delle sue dichiarazioni, Usa e Ue dicono che Pechino tiene basso il valore della sua moneta in modo artificiale, per favorire i prodotti cinesi a danno di quelli degli altri Paesi. Ma non pare che per ora la Cina intenda lasciare che la sua valuta si allinei secondo le leggi di mercato.
Una tale condotta viene annunciata a Shangai dove il Divy caijing ribao - un giornale dedicato alle questioni economiche economiche - rileva tra l’altro che la Cina nel 2009 ha registrato un crescita dell’8,7% e ha superato la Germania come primo esportatore mondiale. Di qui l’aspirazione di molti paesi industrializzati ad entrare con i loro prodotti nel mercato cinese che, oggi più che mai, è in grande espansione. Ma qui si scontrano varie linee di interpretazione. Con molti esperti occidentali che - scrivono gli analisti del South China Morning Post - sostengono che non è possibile verificare i dati sulla crescita cinese e che le imprese cinesi e il mercato interno appaiono molto sostenuti, sia dai finanziamenti statali, sia dai moltissimi prestiti bancari erogati per tassi minimi.
Secondo dati ufficiali, le banche, nei primi venti giorni di gennaio, hanno concesso nuovi finanziamenti per oltre 1000 miliardi di yuan (altre fonti parlano di 1.450 miliardi). Dato assai superiore al limite fissato per l’intero 2010 di 7.500 miliardi di prestiti bancari. E in occidente si invitano gli istituti a valutare con grande attenzione i nuovi prestiti, nel timore che i finanziamenti bancari siano impiegati in manovre speculative (ad esempio per acquistare azioni oppure immobili da rivendere in breve tempo) piuttosto che per favorire la produzione. E così la Banca di Cina e la Banca Commerciale hanno sospeso temporaneamente nuovi finanziamenti, con la Banca centrale che ha anche indicato a diverse banche di aumentare le riserve di denaro, così da drenare la liquidità dal mercato dei finanziamenti.
Nessuno, quindi, può tirare un sospiro di sollievo, pur se la strategia attuale di Pechino - quella di puntare sul mercato interno - coinvolge sempre più vasti strati del mondo economico locale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
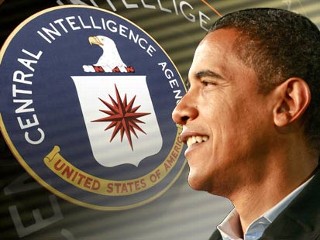 di Michele Paris
di Michele Paris
Tra le eredità dell’amministrazione Bush non ripudiate dal presidente Obama nonostante la retorica del cambiamento, ma anzi consolidate, vi è quella dei bombardamenti in paesi esteri per colpire presunti terroristi. La lunga mano di Washington finisce per colpire, talvolta senza alcuno scrupolo, anche cittadini americani sospettati di appartenere o fornire supporto ad una qualche rete terroristica in territorio straniero. La prassi dell’eliminazione fisica di connazionali che vengono definiti “nemici combattenti” è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica statunitense in tutta la sua pericolosità solo recentemente, in seguito ad una testimonianza del numero uno dell’intelligence a stelle e strisce, ammiraglio Dennis C. Blair.
Chiamato a rispondere alle domande dei membri della Commissione per i Servizi Segreti della Camera dei Rappresentanti, Blair ha ammesso che gli Stati Uniti conducono operazioni per colpire deliberatamente cittadini americani coinvolti in operazioni terroristiche. Secondo il direttore dell’Intelligence Nazionale, quando i servizi stabiliscono la necessità dell’uccisione di un cittadino americano legato a gruppi estremisti sul territorio di un altro paese sovrano, viene inoltrata una specifica richiesta alla Casa Bianca per poter procedere con l’operazione.
Le dichiarazioni dell’ammiraglio Blair seguono in realtà di qualche giorno un articolo di Dana Priest, la reporter-premio Pulitzer del Washington Post. Nell’articolo veniva spiegato l’impiego diffuso da parte dell’amministrazione Obama di questa pratica, promossa da Bush e Cheney già all’indomani degli attacchi dell’11 settembre. L’ex presidente repubblicano aveva infatti accordato alla CIA, e successivamente all’esercito, l’autorità di colpire cittadini americani all’estero in caso di “prove concrete” di un loro coinvolgimento in operazioni di pianifica di attentati o in azioni terroristiche vere e proprie.
Le persone da eliminare dovrebbero rappresentare una “minaccia costante ed imminente” nei confronti di altri cittadini o interessi americani. Una definizione alquanto generica che ha provocato incursioni dirette a colpire persone la cui colpevolezza era stata provata unicamente da un rapporto dell’intelligence americana. Sempre secondo il Post, attualmente sulla lista nera della CIA e del comando delle forze speciali (Joint Special Operations Command, JSOC) ci sarebbero tre cittadini americani da uccidere oppure catturare.
Tra gli obiettivi più famosi delle incursioni statunitensi, c’è il cittadino di passaporto americano Ahmed Hijazi, meglio noto come Kamal Derwish, ucciso in Yemen nel novembre 2002 da un missile lanciato da un drone RQ-1 Predator. Anche se l’attacco era ufficialmente destinato a colpire cinque sospetti affiliati ad Al-Qaeda che viaggiavano su un’auto assieme a Derwish, quest’ultimo era nel mirino della CIA per essere uno dei presunti organizzatori dell’attentato alla nave da guerra USS Cole, saltata in aria nell’ottobre del 2000 nel porto di Aden, causando la morte di 17 marinai americani.
Ugualmente bersaglio delle azioni segrete inizialmente approvate da George W. Bush per giustificare la caccia ai membri della rete di Osama bin Laden, e ampiamente adottate da Obama, è stato più recentemente anche Anwar al-Awlaqi, ex imam nativo del Nuovo Messico da qualche anno emigrato in Yemen. Considerato dal governo americano reclutatore e motivatore di futuri terroristi, al-Awlaqi il 24 dicembre scorso è sopravvissuto a un bombardamento approvato da Washington in territorio yemenita mentre era in corso quello che è stato descritto come un meeting tra alcuni leader del gruppo denominato Al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP).
Da parte delle associazioni a difesa dei diritti civili, le reazioni all’articolo del Washington Post e alla testimonianza dell’ammiraglio Blair al Congresso sono state molto accese. Oltre alle critiche per le poche informazioni rese pubbliche in quasi un decennio di operazioni coperte in varie parti del globo, grande preoccupazione è stata espressa per possibili abusi e la mancanza di controlli sull’operato del governo, dei servizi segreti e dei militari.
Il totale disprezzo per la legalità, che ha portato all’istituzione di una pratica che permette al presidente degli Stati Uniti di autorizzare l’esecuzione di omicidi di cittadini americani sul suolo di altri paesi, sembra superfluo ricordare, non può che indebolire ulteriormente l’autorità morale di un paese che si autodefinisce in guerra contro il terrore. Tanto più che queste operazioni, che si vorrebbero mirate a limitare i danni collaterali, finiscono quasi sempre per mietere un più o meno elevato numero di vittime civili innocenti.
La sola accusa di avere legami con un’organizzazione considerata terroristica, se sollevata da un’agenzia d’intelligence basta a scatenare la caccia all’uomo, indipendentemente dalla sua nazionalità e, teoricamente, in qualsiasi angolo del pianeta. Ciò può accadere anche nel caso in cui il sospettato non abbia mai intrapreso azioni violente nei confronti degli interessi USA, ma sia ritenuto semplicemente una non ben definita “minaccia” per possibili azioni future.
Una condotta colpevolmente abbracciata da un presidente che aveva promesso chiaramente la fine delle distorsioni di cui si era reso responsabile il suo predecessore. Una condotta che viola le leggi internazionali sui diritti umani e colpisce al cuore gli stessi principi sui cui si fonda la democrazia americana, andando a contraddire direttamente il Quinto Emendamento della Costituzione dove afferma senza equivoci che “nessuno… può essere privato della vita” - così come della “libertà o della proprietà” - “senza un regolare procedimento legale”.
