- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
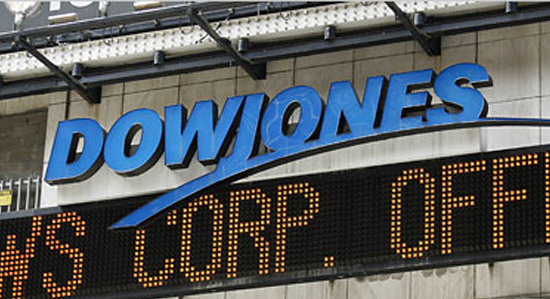 di Michele Paris
di Michele Paris
Tra l’entusiasmo a malapena celato dei media istituzionali d’oltreoceano, l’indice Dow Jones di Wall Street ha fatto segnare martedì il livello più alto della propria storia, superando il primato registrato nel 2007 alla vigilia della più devastante crisi economica e finanziaria che ha colpito il sistema capitalistico dagli anni Trenta del secolo scorso. Ben lontano dall’essere un motivo di celebrazioni, il record toccato dal Dow Jones prefigura la probabile esplosione di una nuova rovinosa bolla finanziaria nel prossimo futuro e dimostra in maniera inequivocabile la natura di classe delle politiche messe in atto dall’amministrazione Obama, responsabile in questi ultimi quattro anni di un colossale trasferimento di ricchezza a favore dell’oligarchia parassitaria americana.
Nonostante il Dow Jones tenga in considerazione soltanto il prezzo dei 30 principali titoli quotati a Wall Street, il fatto che abbia superato il precedente primato è altamente significativo della fiducia che pervade gli speculatori finanziari grazie agli interventi della politica di Washington e della Banca Centrale statunitense. Con prospettive di ulteriori picchi nei prossimi giorni, nella giornata di martedì il più vecchio indice della borsa di New York ha guadagnato lo 0,9%, chiudendo a 14.253,77 punti, vale a dire oltre il doppio rispetto al livello più basso mai toccato, risalente al marzo del 2009.
Il sostenuto “rally” della borsa americana in questi quattro anni è andato di pari passo con il peggioramento o quanto meno con il ristagno dell’economia reale, nonché soprattutto con il progressivo deterioramento delle condizioni di vita di decine di milioni di lavoratori, pensionati, giovani e disoccupati. Simbolicamente e forse non a caso, il record del Dow Jones è giunto inoltre a pochissimi giorni di distanza dall’entrata in vigore del cosiddetto “sequester”, cioè i tagli automatici alla spesa pubblica pari a 85 miliardi di dollari scattati in seguito al mancato accordo tra democratici e repubblicani per contenere il debito federale.
Questi tagli dovranno essere implementati entro la fine di settembre e andranno a colpire ancora una volta le fasce più povere della popolazione che fanno affidamento su programmi pubblici sempre più esili. Allo stesso modo, il livello ufficiale di disoccupazione negli Stati Uniti rimane a livelli allarmanti (7,9%) - mentre durante il precedente record del Dow Jones era abbondantemente al di sotto del 5% - e svariate ricerche condotte negli ultimi mesi indicano come le retribuzioni di lavoratori e classe media siano ai livelli più bassi da oltre mezzo secolo a questa parte. In un clima di sfiducia generalizzata e di gravissimo affanno per la maggior parte della popolazione, appare perciò evidente che il motivo dell’impressionante recupero della borsa americana, e non solo, è legato pressoché interamente, come ha scritto mercoledì il New York Times, “all’enorme stimolo monetario offerto dalla Fed e dalle altre Banche Centrali”. Questo fatto conferma il totale scollamento tra il parassitismo finanziario e l’economia reale, risultato delle politiche di deregulation e della distruzione dell’industria manifatturiera negli Stati Uniti per consegnare alle banche e agli speculatori di Wall Street il ruolo di motore, sia pure artificioso, del sistema economico.
In un clima di sfiducia generalizzata e di gravissimo affanno per la maggior parte della popolazione, appare perciò evidente che il motivo dell’impressionante recupero della borsa americana, e non solo, è legato pressoché interamente, come ha scritto mercoledì il New York Times, “all’enorme stimolo monetario offerto dalla Fed e dalle altre Banche Centrali”. Questo fatto conferma il totale scollamento tra il parassitismo finanziario e l’economia reale, risultato delle politiche di deregulation e della distruzione dell’industria manifatturiera negli Stati Uniti per consegnare alle banche e agli speculatori di Wall Street il ruolo di motore, sia pure artificioso, del sistema economico.
Secondo i dati della Banca dei Regolamenti Internazionali, infatti, a partire dalla fine del 2007 le cinque principali Banche Centrali del pianeta hanno immesso sui mercati qualcosa come 6 mila miliardi di dollari, ufficialmente per tenere a galla l’intero sistema economico. Più recentemente, da parte sua la Fed americana ha messo in atto un’aggressiva politica monetaria, definita “quantitative easing”, una pratica che consiste sostanzialmente nello stampare denaro per mettere a disposizione delle grandi banche una quantità virtualmente illimitata di fondi. La Fed, cioè, acquista attualmente azioni e titoli finanziari per 85 miliardi di dollari ogni mese (più di mille miliardi all’anno), consentendo agli investitori di Wall Street di continuare ad accumulare enormi profitti tramite rischiose operazioni finanziarie.
Una simile pratica, oltre a contraddire clamorosamente la pretesa delle classi dirigenti che non esistono risorse per sostenere i precedenti livelli di spesa pubblica, rischia di innescare una nuova bolla ancora più grande di quella esplosa nell’autunno del 2008 con il tracollo di Lehman Brothers, dal momento che un tale scenario lascerebbe esposte anche le stesse Banche Centrali che oltre quattro anni fa garantirono il salvataggio del sistema venendo in soccorso degli istituti sull’orlo del collasso.
Per questo motivo, il governatore della Fed, Ben Bernanke, solo qualche giorno fa ha confermato il persistere del “quantitative easing” fino a quando, a suo dire, il livello di disoccupazione non sarà sceso sensibilmente. La decisione di proseguire con questa politica monetaria ha ricevuto molte critiche all’interno della Fed proprio per i timori che essa possa alimentare una bolla distruttiva e, recentemente, soltanto l’ipotesi di una sospensione del “quantitative easing” ha fatto registrare una rapida discesa degli indici di borsa.
Questa stessa politica monetaria continua peraltro ad essere adottata anche da altre Banche Centrali nei paesi più avanzati, anche perché contribuisce alla svalutazione della loro moneta, rendendo più competitive le esportazioni a discapito dei rispettivi concorrenti, con il rischio però di scatenare una pericolosa guerra delle valute su scala globale. Il Giappone, in particolare, con il ritorno al potere del premier conservatore Shinzo Abe ha dato inizio in queste settimane all’immissione sul mercato di enormi quantità di denaro per “stimolare l’economia” sull’esempio della Fed americana. Negli Stati Uniti, il rialzo artificioso del Dow Jones, ma anche degli altri indici di borsa più importanti, è da collegare dunque a quella che ancora il New York Times qualche giorno fa ha definito “l’età dell’oro per i profitti delle corporation”, saliti a livelli vertiginosi proprio in concomitanza con l’impoverimento delle masse.
Negli Stati Uniti, il rialzo artificioso del Dow Jones, ma anche degli altri indici di borsa più importanti, è da collegare dunque a quella che ancora il New York Times qualche giorno fa ha definito “l’età dell’oro per i profitti delle corporation”, saliti a livelli vertiginosi proprio in concomitanza con l’impoverimento delle masse.
A confermare l’allargamento senza precedenti delle disuguaglianze di reddito in America sono i dati ufficiali che indicano, ad esempio, come i profitti delle compagnie private nel terzo trimestre del 2012 abbiano fatto segnare il livello più alto dal 1950 in termini di percentuale del redito totale del paese (14,2%), mentre le entrate dei lavoratori dipendenti hanno sfiorato il punto più basso dal 1966 (61,7%). Inoltre, il fatturato delle corporation a partire dallo scoppio della crisi nel 2008 è cresciuto alla media annuale del 20,1% contro un misero 1,4% al netto delle tasse per il resto del paese.
A differenza di quanto generalmente scritto in questi giorni dai principali media americani, questa esplosione dei profitti non è giunta nonostante la disoccupazione ancora elevata o i tagli alla spesa pubblica che hanno frenato l’economia, bensì precisamente in conseguenza di tutto questo. Grazie ad una classe politica interamente al loro servizio, l’aristocrazia parassitaria statunitense sta infatti raggiungendo livelli di ricchezza mai visti, appropriandosi delle risorse sottratte a decine di milioni di persone che continuano a pagare a carissimo prezzo una crisi per il cui scoppio non hanno avuto alcuna responsabilità.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
La notizia è arrivata in tarda serata, dura, secca, dolorosa come un colpo allo stomaco. Il Presidente del Venezuela, Comandante Hugo Chavez Frias, è morto. E’ l’esito di una lotta lunga due anni contro il cancro e di una battaglia senza sosta lunga una vita intera contro l’imperialismo Usa in America Latina. Stati Uniti che vengono accusati dal vicepresidente Nicolas Maduro di aver complottato contro la vita stessa di Chavez oltre che contro la stabilità politica del Paese.
Si parla di avvelenamento e da Washington, ovviamente, smentiscono sdegnati. Nelle stesse ore, intanto, Caracas ha espulso due alti funzionari della locale ambasciata statunitense per ingerenza negli affari interni del Venezuela. I prossimi giorni ci saranno maggiori elementi per capire la dimensione precisa delle accuse dei vertici della Rivoluzione bolivariana, per ora prevale l’emozione di un paese che è stato colpito direttamente al cuore.
Le decine di migliaia di persone che si riversano in strada a testimoniare l’amore per il loro leader, raccontano di un paese che si troverà da domani alle prese con un necessario riassetto della leadership in grado di far fronte all’offensiva di una destra tra le peggiori del pianeta per corruzione, servilismo e odio sociale nei confronti dei nullatenenti. Una storia che proprio Chavez ha saputo ribaltare, portando alla ribalta le ragioni del suo popolo e mettendo all’angolo, elezione dopo elezione, referendum dopo referendum, le ambizioni di una borghesia nazionale dominante verso l’interno e telecomandata dall’esterno.
Nelle due occasioni che ho avuto di parlargli, l’impressione di avere di fronte un uomo capace di superare i suoi stessi limiti pur di raggiungere gli obiettivi che si proponeva, si sommava a quella di avere di fronte un leader davvero completamente immedesimato con il suo popolo, immerso fino in fondo nel suo destino. Proprio aver incontrato tanti leader di tanti paesi mi facilitava la sensazione di avere di fronte qualcuno di assolutamente diverso.
La lotta dell’impero e dei suoi funzionari contro Chavez non ha avuto sosta, nulla è stato risparmiato per disarcionare il presidente venezuelano dal potere. Ma nemmeno con il colpo di stato del 2002, come sempre deciso e organizzato a Washington, riuscirono ad aver ragione della rivoluzione bolivariana. Chavez, deposto dai militari traditori, nel giro di poche ore venne rimesso al suo posto da una sollevazione popolare e i golpisti dovettero riparare all’estero o finirono agli arresti. Sia il Venezuela che l’intera America Latina sono state sedotte e conquistate da un uomo che ha saputo realizzare una rivoluzione autentica, rovesciando con le due idee e i suoi atti l’ordine preesistente. Capace di comunicare come nessuno mai con il suo popolo, Chavez è stato il nemico giurato dell’oligarchia venezuelana e uno dei più accaniti sostenitori delle ragioni di un nuovo socialismo - il socialismo del terzo millennio - che tanto impulso ha dato al pensiero progressista proprio nella fase storica nella quale la sinistra cominciava a pagare, internazionalmente, il costo di una sconfitta epocale. Ma pur nell’epoca del pensiero unico, il Presidente venezuelano seppe porsi in prima fila nella rielaborazione di una teoria politica socialista, che si compone di indipendenza nazionale, giustizia sociale e solidarietà internazionalista, sul piano regionale come su quello globale.
Sia il Venezuela che l’intera America Latina sono state sedotte e conquistate da un uomo che ha saputo realizzare una rivoluzione autentica, rovesciando con le due idee e i suoi atti l’ordine preesistente. Capace di comunicare come nessuno mai con il suo popolo, Chavez è stato il nemico giurato dell’oligarchia venezuelana e uno dei più accaniti sostenitori delle ragioni di un nuovo socialismo - il socialismo del terzo millennio - che tanto impulso ha dato al pensiero progressista proprio nella fase storica nella quale la sinistra cominciava a pagare, internazionalmente, il costo di una sconfitta epocale. Ma pur nell’epoca del pensiero unico, il Presidente venezuelano seppe porsi in prima fila nella rielaborazione di una teoria politica socialista, che si compone di indipendenza nazionale, giustizia sociale e solidarietà internazionalista, sul piano regionale come su quello globale.
Dedicò ogni sforzo al consolidamento delle relazioni continentali e non lesinò aiuti e sostegno ai paesi con minori possibilità. Da essi venne sempre ricambiato con la disponibilità totale a combattere le stesse battaglie, a perseguire gli stessi obiettivi, a disegnare un nuovo continente unito, libero dal giogo del Washington consensus. Il suo rapporto straordinario con Fidel Castro ha in qualche modo rappresentato, anche simbolicamente un passaggio di testimone dalla resistenza di un’isola orgogliosa e ribelle ad un intero continente oggi profondamente immerso nella sua nuova storia democratica e socialista.
Nella storia del Venezuela Chavez può ben essere definito l’erede di Simon Bolivar. Una personalità debordante, un carisma raro, una connessione di sentimenti ed emozioni con il suo popolo difficile da riscontrare con frequenza. Un amore verso gli ultimi della sua terra assolutamente ricambiato. Il Venezuela di Chavez, lungi dall’essere un paradiso in terra e pure ancora alla ricerca di una dimensione finalmente libera dalle contraddizioni violente di una società complessa, è stato infatti negli ultimi dodici anni un paese diverso; più giusto, più umano, lontano sideralmente dal covo d’ingiustizia e apartheid sociale ed etnico che decenni di dittatura militare e democrazie fantoccio, entrambe stabilite a Washington e applicate a Caracas come in ogni dove dell’America Latina, avevano caratterizzato. Tutto cambiò nel 1998, quando l’ex ufficiale dei paracadutisti strappò il suo paese al destino di republica petrolera prima nei profitti e ultima nell’equità. Analfabetismo, morti per povertà, fame strisciante e diffusa, mancanza di case e di assistenza sanitaria per i poveri ebbero i mesi contati. La riconversione dei proventi del petrolio in investimenti di politiche sociali a favore degli ultimi in patria, mentre fuori dai confini l’intensa attività di Chavez, ispiratore dell'alleanza bolivariana delle americhe (ALBA) ha dato un enorme, fondamentale contributo alla rete straordinaria di alleanze politiche con i governi progressisti di tutta l’America Latina e che rappresenta oggi la nuova stagione democratica del continente.
Analfabetismo, morti per povertà, fame strisciante e diffusa, mancanza di case e di assistenza sanitaria per i poveri ebbero i mesi contati. La riconversione dei proventi del petrolio in investimenti di politiche sociali a favore degli ultimi in patria, mentre fuori dai confini l’intensa attività di Chavez, ispiratore dell'alleanza bolivariana delle americhe (ALBA) ha dato un enorme, fondamentale contributo alla rete straordinaria di alleanze politiche con i governi progressisti di tutta l’America Latina e che rappresenta oggi la nuova stagione democratica del continente.
Entro trenta giorni verranno convocate nuove elezioni e l'appuntamento elettorale sarà il primo passaggio politico che dirà se la rivoluzione bolivariana potrà continuare senza Chavez. Le parole di Maduro, in lacrime, in rappresentanza del governo e delle Forze Armate, al momento della comunicazione della morte di Chavez, non lasciano dubbi circa l’unità del gruppo dirigente che dovrà raccoglierne, nel modo che potrà e saprà darsi, l’eredità del chavismo: “Noi civili e militari assumiamo la tua eredità, le tue sfide, il tuo progetto; accompagnati dal nostro popolo, le nostre bandiere saranno sventolate con dignità. Grazie Comandante, mille volte grazie”.
Le forze armate del Venezuela sono state dispiegate in tutto il paese, a garantire ordine e a fornire un messaggio chiaro a tutti coloro che, dall’interno e dall’esterno del Paese, fossero accarezzati dall’idea di approfittare della situazione. Sono ore di commozione e di rimpianti, di dolore e sgomento, non di debolezza. Ore nelle quali il popolo prenderà le sue strade e suoi nemici troveranno luogo solo al riparo delle loro case. Senza essere visto, armato della la spada di Bolivar e del suo sorriso aperto, Chavez passeggia e passeggerà ancora a lungo per le strade del suo Venezuela.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il neo-segretario di Stato americano, John Kerry, sta per ultimare in questi giorni il suo primo viaggio all’estero da successore di Hillary Clinton alla guida della diplomazia a stelle e strisce con visite in paesi strategicamente fondamentali per gli interessi del suo paese in Africa settentrionale e in Medio Oriente. Dopo le soste in Europa, le più importanti tappe della trasferta dell’ex senatore del Massachusetts sono state in Egitto e in Arabia Saudita, durante le quali i toni adottati nelle sue apparizioni pubbliche non hanno lasciato intravedere alcun sostanziale cambiamento nella politica estera di Washington nel secondo mandato di Obama alla Casa Bianca.
Anche se appare del tutto scontato che gli interessi strategici dell’imperialismo statunitense continueranno a caratterizzare le scelte del Dipartimento di Stato, in molti, soprattutto tra i sostenitori “liberal” del presidente, si aspettavano da Kerry almeno un ammorbidimento dei toni e, ad esempio, una maggiore predisposizione da parte del nuovo segretario a ricercare una soluzione negoziata e pacifica per le crisi di Siria e Iran.
In merito al conflitto che mette di fronte le forze del regime di Bashar al-Assad ai “ribelli” sunniti armati dall’Occidente e dalle dittature del Golfo Persico, alla vigilia del vertice dei cosiddetti “Amici della Siria” di Roma, John Kerry settimana scorsa aveva invece annunciato che gli Stati Uniti avrebbero aumentato il loro impegno a favore delle opposizioni, facendo perciò intravedere un nuovo intensificarsi del sanguinoso scontro settario in atto. Da Kerry, dunque, non è giunto finora alcun segnale che l’amministrazione Obama sia disposta ad impegnarsi nell’apertura di un dialogo tra le due parti per gettare le basi di una soluzione negoziata della crisi.
La linea dura di Washington anche sul nucleare iraniano è stata poi sostanzialmente ribadita per bocca dello stesso segretario di Stato nella giornata di lunedì a Riyadh, in Arabia Saudita. Infatti, nella conferenza stampa seguita al loro incontro, Kerry e il suo omologo saudita, Saud al-Faisal, hanno fatto ampio ricorso alla consueta retorica intimidatoria utilizzata dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel discutere del legittimo programma energetico di Teheran.
Le dichiarazioni di Kerry, in particolare, hanno talvolta ricalcato parola per parola quelle pronunciate nel recente passato dalla Clinton, da Obama e da altri esponenti del governo o del Congresso di Washington. Così, ad esempio, il candidato democratico alla Casa Bianca nel 2004 ha ribadito che “la finestra per trovare una soluzione diplomatica non può rimanere aperta indefinitamente” e che gli iraniani stanno mostrando “una serietà insufficiente” nella discussione in corso.
Inoltre, su un altro aspetto attorno al quale ci si poteva aspettare una sia pur timida svolta da parte del nuovo responsabile della diplomazia americana le aspettative sono andate deluse. Kerry ha infatti escluso categoricamente che i negoziati sul nucleare possano essere estesi fino a comprendere altre questioni relative alla sicurezza della regione e alle aspirazione dell’Iran in questo ambito. Tale allargamento della discussione, al contrario, è fortemente auspicato dalle autorità di Teheran, ben consapevoli che le pressioni occidentali relativamente al loro programma nucleare sono in gran parte un pretesto per contenere l’influenza iraniana in Medio Oriente a tutto vantaggio degli alleati americani nella regione. Durante la visita a Riyadh, Kerry è tornato poi a parlare della crisi in Siria, cercando di spiegare nuovamente la decisione di non fornire direttamente armi ai ribelli anti-Assad per evitare che esse possano finire nelle mani dei gruppi integralisti che stanno combattendo per rovesciare il regime di Damasco. Questa pretesa viene avanzata quotidianamente ad uso e consumo dei media ufficiali, dal momento che non solo gli USA da tempo coordinano le spedizioni di armi letali a favore dell’opposizione siriana e finanziate da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi e Turchia, ma che gli stessi ribelli descritti come moderati e perciò presentabili all’opinione pubblica internazionale operano a stretto contatto con jihadisti sanguinari che hanno già compiuto innumerevoli attentati nei quali sono morti centinaia di civili innocenti.
Durante la visita a Riyadh, Kerry è tornato poi a parlare della crisi in Siria, cercando di spiegare nuovamente la decisione di non fornire direttamente armi ai ribelli anti-Assad per evitare che esse possano finire nelle mani dei gruppi integralisti che stanno combattendo per rovesciare il regime di Damasco. Questa pretesa viene avanzata quotidianamente ad uso e consumo dei media ufficiali, dal momento che non solo gli USA da tempo coordinano le spedizioni di armi letali a favore dell’opposizione siriana e finanziate da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi e Turchia, ma che gli stessi ribelli descritti come moderati e perciò presentabili all’opinione pubblica internazionale operano a stretto contatto con jihadisti sanguinari che hanno già compiuto innumerevoli attentati nei quali sono morti centinaia di civili innocenti.
A fianco di Kerry, in ogni caso, Saud al-Faisal - fin dal 1975 ministro degli Esteri di un paese tra i più repressivi e autoritari del pianeta - ha elargito una lezione di democrazia al presidente Assad e ai suoi alleati, rivendicando il ruolo di Riyadh nel mettere a disposizione del “popolo siriano” gli strumenti per “esercitare il loro legittimo diritto di autodifesa” contro le forze del regime.
La visita di Kerry a Riyadh, che sarà seguita dalle ultime tappe del suo tour di 11 giorni ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, e a Doha, in Qatar, non ha previsto un incontro con il quasi 90enne sovrano saudita, Abdullah, mentre ha incluso un pranzo con il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), in vista del prossimo viaggio di Obama in Israele per cercare di rianimare un sempre più moribondo processo di pace.
Prima della sosta in Arabia Saudita, John Kerry aveva incontrato nel fine settimana al Cairo il presidente egiziano, Mohamed Mursi, assieme al ministro della Difesa, generale Abdul Fatah al-Sisi, e ad altri esponenti di spicco dei Fratelli Musulmani al potere. In particolare, ai vertici di un paese che rappresenta un pilastro della strategia americana nel mondo arabo, il successore di Hillary Clinton ha annunciato lo stanziamento di 250 milioni di dollari in aiuti immediati.
Questa promessa è stata accompagnata da forti pressioni su Mursi per chiudere finalmente i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale (FMI), così da ottenere un prestito da 4,8 miliardi di dollari, teoricamente per salvare un’economia in grave affanno fin dall’esplosione della rivolta che ha deposto Hosni Mubarak più di due anni fa. Il prestito del FMI è allo studio da tempo ma il governo islamista del Cairo lo ha più volte rimandato per evitare un intensificarsi delle proteste popolari che continuano a caratterizzare la quotidianità egiziana. Anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli del prestito, è infatti pressoché certo che il FMI chiederà come al solito in cambio le consuete impopolari misure che si tradurranno in nuovi assalti alle condizioni di vita delle classi più disagiate, come la fine dei sussidi sui prodotti di prima necessità, da cui dipendono decine di milioni di persone, nonché, più in generale, l’ulteriore apertura del mercato interno al capitale internazionale.
Il prestito del FMI è allo studio da tempo ma il governo islamista del Cairo lo ha più volte rimandato per evitare un intensificarsi delle proteste popolari che continuano a caratterizzare la quotidianità egiziana. Anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli del prestito, è infatti pressoché certo che il FMI chiederà come al solito in cambio le consuete impopolari misure che si tradurranno in nuovi assalti alle condizioni di vita delle classi più disagiate, come la fine dei sussidi sui prodotti di prima necessità, da cui dipendono decine di milioni di persone, nonché, più in generale, l’ulteriore apertura del mercato interno al capitale internazionale.
Ciò che Kerry ha chiesto alle élite politiche egiziane, comprese le opposizioni guidate dall’ex direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Mohamed ElBaradei, è stato in definitiva uno sforzo per mettere da parte le divisioni e serrare i ranghi per fare cessare le proteste popolari e gli scioperi che ostacolano il ritorno allo sfruttamento del paese nord-africano da parte degli investitori internazionali. Per il momento, il cosiddetto Fronte di Salvezza Nazionale che si oppone al governo Mursi continua invece a sostenere il boicottaggio delle elezioni generali programmate per il mese di aprile.
La manipolazione degli eventi che hanno seguito la caduta di Mubarak, sostenuto da Washington fino a quando è stato possibile, e la doppiezza della politica estera USA sono risultate evidenti dalle parole di John Kerry al Cairo. Il segretario di Stato ha cinicamente affermato di voler portare un messaggio ai “coraggiosi egiziani” che hanno rischiato le loro vite a Piazza Tahrir per un futuro migliore, sostenendo poi che le loro legittime aspirazioni potrebbero essere soddisfatte solo con l’implementazione di “riforme” che assicurino l’approvazione del prestito del Fondo Monetario Internazionale, unico in grado di generare una ripresa dell’economia.
Nel paese in fermento, la totale incapacità di Kerry e del governo di Washington di interpretare le aspettative di un popolo egiziano sempre più ostile al governo di Mursi e dei Fratelli Musulmani è apparso però evidente dalle proteste pacifiche andate in scena al Cairo contro la politica americana prima e durante la sua visita. Le manifestazioni hanno avuto più di un eco in altre località del paese e nella serata di domenica hanno anche bloccato a lungo il traffico diretto all’aeroporto della capitale, ritardando di alcune ore la partenza di Kerry per l’Arabia Saudita.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Un’animata discussione di fronte ai giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti è sembrata preannunciare, nella giornata di mercoledì, il prossimo smantellamento di un altro pezzo dell’impalcatura legale di stampo progressista costruita negli USA nei decenni successivi al secondo conflitto mondiale. All’attenzione del più alto tribunale americano è stata portata questa settimana la costituzionalità di alcune disposizioni contenute nel Voting Rights Act (VRA), una legge che dal 1965 cerca di prevenire le minacce al diritto di voto delle minoranze etniche e razziali negli stati più problematici dell’Unione.
Il caso in questione - “Contea di Shelby contro Holder” - era stato accettato dalla Corte Suprema nonostante il parere contrario delle corti federali e d’appello degli Stati Uniti e il massiccio sostegno assicurato dal Congresso alle varie proroghe del VRA decise tra il 1970 e il 2006. L’origine di questo provvedimento si inserisce nell’ambito delle lotte del movimento per i diritti civili degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, quando i diritti costituzionali nominalmente garantiti ai cittadini afro-americani fin dal termine della Guerra Civile venivano puntualmente negati, soprattutto nel sud degli Stati Uniti.
Tra i sistemi messi in atto fin dalla fine del XIX secolo per privare dei loro diritti i cittadini appartenenti a minoranze, ma anche i bianchi delle classi più povere, vi erano appunto delle leggi che, assieme a violenze e intimidazioni, limitavano l’accesso alle urne, ad esempio tramite l’imposizione di tasse sul voto o l’obbligo di test di alfabetizzazione.
L’approvazione del Voting Rights Act, seguito di un anno al Civil Rights Act del 1964, intendeva perciò porre fine a simili discriminazioni e imponeva ad una serie di stati di ottenere un permesso preventivo dal governo federale per poter modificare le proprie procedure di voto. Originariamente, gli stati coperti pressoché interamente dal VRA erano sette (Alabama, Alaska, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Virginia) più alcune contee e municipalità di Arizona, Hawaii e Idaho. Nel 1975 venne poi aggiunto il Texas e ad oggi sono coperte da questa legge totalmente o in parte 16 stati americani, tra cui anche alcune zone di California, Florida e New York. Le sezioni del VRA oggi all’esame della Corte Suprema sono la n. 4 e la n. 5, le quali riguardano rispettivamente la scelta delle giurisdizioni sottoposte alla legge stessa e il permesso preventivo che esse devono richiedere al governo di Washington per cambiare le loro leggi elettorali.
Le sezioni del VRA oggi all’esame della Corte Suprema sono la n. 4 e la n. 5, le quali riguardano rispettivamente la scelta delle giurisdizioni sottoposte alla legge stessa e il permesso preventivo che esse devono richiedere al governo di Washington per cambiare le loro leggi elettorali.
Ad appellarsi al tribunale costituzionale degli Stati Uniti è stata la contea di Shelby, in Alabama, i cui legali sostengono che il VRA non deve più essere applicato poiché qui non si verificano ormai discriminazioni nei confronti di elettori appartenenti a minoranze in misura maggiore che in altre giurisdizioni del paese.
La Corte Suprema, in realtà, aveva già affrontato la questione nel 2009 e con una maggioranza di 8 a 1 aveva declinato di esprimersi sulla costituzionalità della legge, invitando però il Congresso ad aggiornare i criteri con cui viene deciso quali parti del paese devono essere soggette al VRA, cosa che a tutt’oggi non è ancora stata fatta. Per questo motivo, il caso attualmente all’analisi dei giudici, per il quale una sentenza definitiva è attesa entro il mese di giugno, ruota attorno alla legittimità del Congresso di prolungare il VRA, come ha fatto per altri 25 anni nel 2006, basandosi su dati e valutazioni relative a pratiche elettorali messe in atto decenni fa e non più attuali.
A giudicare dal tono dell’audizione di mercoledì, all’interno della Corte Suprema potrebbe esserci una maggioranza di giudici intenzionati ad accettare la versione della contea di Shelby, in Alabama, cancellando di fatto il VRA, dal momento che le implicazioni politiche della questione e le divisioni che caratterizzano da anni il Congresso americano renderebbero alquanto improbabile un riesame dei criteri di scelta delle giurisdizioni da sottoporre al dettato della legge del 1965.
A dare questa sensazione sono stati i giudici attestati su posizioni ideologiche di estrema destra, ponendo domande ed esprimendo considerazioni che hanno lasciato intendere una chiara volontà di dichiarare incostituzionali le sezioni 4 e 5 del VRA.
 Nel corso del dibattimento, l’osservazione più sconcertante è giunta dal giudice Antonin Scalia, il quale ha definito gli effetti di uno dei provvedimenti cardine del periodo anti-segregazione come il “perpetuarsi di un privilegio razziale”, tanto che una decisione in proposito “non andrebbe lasciata alla discrezione del Congresso”.
Nel corso del dibattimento, l’osservazione più sconcertante è giunta dal giudice Antonin Scalia, il quale ha definito gli effetti di uno dei provvedimenti cardine del periodo anti-segregazione come il “perpetuarsi di un privilegio razziale”, tanto che una decisione in proposito “non andrebbe lasciata alla discrezione del Congresso”.
La dichiarazione di Scalia è stata indirettamente condannata dal giudice moderato Sonia Sotomayor, quando ha chiesto ad un avvocato della contea di Shelby se a suo parere “il diritto di voto corrisponda ad un privilegio razziale” e se effettivamente “la discriminazione razziale nel diritto al voto sia cessata” o persista tuttora da qualche parte nel paese.
Sulla stessa linea di Scalia si è espresso anche il presidente della Corte, John Roberts, chiedendosi ad esempio se i “cittadini del Sud siano più razzisti di quelli del nord”. Soprattutto, un certo scetticismo verso la validità del VRA è stata espressa dal giudice centrista Anthony Kennedy, perennemente considerato l’ago della bilancia nelle decisioni più controverse della Corte Suprema.
L’eventuale allineamento del cosiddetto “swing Justice” Kennedy ai quattro giudici ultra-conservatori (Roberts, Scalia, Samuel Alito e Clarence Thomas) assesterebbe dunque un colpo mortale al Voting Rights Act, dando per scontato che i rimanenti giudici moderati o progressisti (Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg e Stephen Breyer) finiranno invece per confermarne la costituzionalità.
In ogni caso, l’intervento della Corte Suprema per limitare il diritto di voto e il potere decisionale degli elettori è tutt’altro che nuovo. In questo ambito, la svolta in senso profondamente anti-democratico era iniziata dopo le elezioni del 2000 con la vergognosa sentenza nel caso “Gore contro Bush” che assegnò la presidenza degli Stati Uniti a quest’ultimo fermando il riconteggio dei voti nello stato della Florida.
Più recentemente, con la decisione nel caso “Citizens United contro Commissione Elettorale Federale” del 2010, la maggioranza conservatrice della Corte aveva invece stabilito il diritto delle corporation di donare quantità illimitate di denaro alle organizzazioni che fanno campagna elettorale per i candidati ad una carica politica. Sempre nell’anno giudiziario in corso, infine, il supremo tribunale americano sarà chiamato ad esprimersi anche sulla legittimità dei limiti individuali stabiliti per legge ai contributi elettorali.
La fine del Voting Rights Act negli Stati Uniti, con ogni probabilità, darebbe il via libera in molti stati all’implementazione di nuove misure volte proprio a restringere il diritto di voto delle minoranze etniche e, soprattutto, degli elettori più poveri. Questa tendenza è d’altra parte risultata già evidente in questi anni di crisi economica con l’intensificarsi dell’opposizione nel paese verso le politiche anti-sociali messe in atto dalla classe dirigente americana. Alla vigilia delle ultime tornate elettorali, infatti, svariate legislature statali, in particolare quelle guidate da una maggioranza repubblicana come in Alabama, hanno approvato leggi che rendono più difficile l’accesso al voto per le classi più disagiate.
Alla vigilia delle ultime tornate elettorali, infatti, svariate legislature statali, in particolare quelle guidate da una maggioranza repubblicana come in Alabama, hanno approvato leggi che rendono più difficile l’accesso al voto per le classi più disagiate.
Questi provvedimenti comprendono, tra l’altro, obblighi più onerosi per dimostrare l’identità di chi si reca alle urne, il riesame delle liste elettorali per escludere dal voto più o meno arbitrariamente il maggior numero di persone possibile, la drastica limitazione del voto anticipato o per corrispondenza e la ridefinizione dei distretti elettorali per favorire un determinato partito.
La difesa da parte dell’amministrazione Obama del VRA, d’altro canto, si fonda in gran parte su motivazioni di opportunità politica, dal momento che le classi sociali e le minoranze etniche colpite da queste leggi discriminatorie votano generalmente in maggioranza per il Partito Democratico.
In definitiva, anche la Corte Suprema, come le altre istituzioni americane, continua a dare il proprio contributo alla demolizione delle fondamenta democratiche negli Stati Uniti in concomitanza con il progredire della crisi del capitalismo americano, avallando allo stesso modo la concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo.
Solo il giorno prima dell’apertura della discussione sulla costituzionalità del Voting Rights Act, infatti, con una maggioranza risicata la Corte Suprema aveva respinto un appello presentato da giornalisti e organizzazioni a difesa dei diritti civili per invalidare la legge che consente al governo di monitorare segretamente, e senza il regolare mandato di un tribunale, tutte le comunicazioni elettroniche con l’estero di qualsiasi cittadino americano.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
BERLINO. Il candidato Cancelliere tedesco Peer Steinbrueck ridicolizza i risultati delle elezioni italiane e solleva un gran polverone mediatico, nascondendo così le vere preoccupazioni di una Germania ormai incatenata alle decisioni del Belpaese e della sua politica, che poco capisce e che di sicuro non stima. Steinbrueck ha definito “clown” i due vincitori del recente appuntamento elettorale, Silvio Berlusconi e Beppe Grillo: l’Italia si è unita nell’offesa e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è rifiutato di partecipare a una cena con il candidato Cancelliere.
Eppure l’aneddoto potrebbe essere solo la punta di un iceberg: perché i partiti che hanno guadagnato più voti a Roma si sono costruiti la campagna elettorale su politiche anti euro e la Germania è preoccupata per il peso che questa decisione ha a livello europeo. Per i tedeschi, i rischi dei recenti risultati elettorali superano i confini dell’Italia.
Angela Merkel (CDU), in realtà, si è mantenuta diplomatica e ha espresso la sua fiducia nella politica italiana e nel senso di responsabilità dei suoi rappresentanti. La Cancelliera ha ribadito la propria stima nei confronti di Giorgio Napolitano, sottolineando l’importanza del suo ruolo e augurandosi delle scelte politiche felici da parte del Presidente della Repubblica. Tra i politici è il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble ad aggiustare il tiro e a riportare l’attenzione sulla vera inquietudine della Germania, e cioè il ruolo dell’economia italiana nel sistema europeo. Schaeuble invita l’Italia a continuare il programma di risparmio iniziato da Mario Monti per mantenersi all’interno dell’Eurozona: perché la paura reale dei tedeschi, al di là del giudizio personale (che non hanno mai nascosto) sui nostri politici, è il rischio di un affossamento della moneta unica e del progetto economico europeo. Il quotidiano popolare Bild, da parte sua, non perde tempo e paragona indirettamente l’Italia alla Grecia. Indebitato, corrotto e ammorbato dalla piaga della disoccupazione, il Belpaese assomiglia alla Grecia di qualche tempo fa, sull’orlo della bancarotta, bisognoso di aiuti, incapace di portare avanti un piano di risparmio per tenere il passo con le nazioni più ricche dell’Eurozona e ingestibile politicamente.
Il quotidiano popolare Bild, da parte sua, non perde tempo e paragona indirettamente l’Italia alla Grecia. Indebitato, corrotto e ammorbato dalla piaga della disoccupazione, il Belpaese assomiglia alla Grecia di qualche tempo fa, sull’orlo della bancarotta, bisognoso di aiuti, incapace di portare avanti un piano di risparmio per tenere il passo con le nazioni più ricche dell’Eurozona e ingestibile politicamente.
Il riferimento del tabloid, uno dei più diffusi in Germania tra i giornali meno autorevoli, va forse alle elezioni greche del 2012, quando i principali partiti a favore dell’euro (Nuova democrazia e Movimento Socialista Panellenico) non hanno ottenuto la maggioranza e i loro leader, non potendo formare il Governo, hanno chiesto un novo appuntamento elettorale. Lo spettro della crisi è sempre presente e la scelta degli italiani è pericolosa perché non assicura nessuna stabilità di governo, che sarebbe, secondo Bild, “un miracolo”.
E, in effetti, per molti giornali tedeschi i risultati delle elezioni italiane sono legati a doppio filo alla situazione finanziaria europea e alla crisi. “Le elezioni italiane mostrano la spaccatura della zona euro”, titola un editorialista del Tagesspiegel, un quotidiano di sinistra berlinese. Il voto degli italiani è la reazione a Mario Monti e al piano di risparmio imposto dall’Europa e, più in particolare, dalla linea economica della Cancelliera Angela Merkel.
Ancora una volta le necessità dei cittadini si sono mostrate in chiaro contrasto con le esigenze dell’economia: i mercati non hanno gioito della scelta politica dell’Italia, ma gli italiani hanno espresso la loro opinione sulla moneta unica e i sacrifici che richiedono i mercati. Per il giornale, a questo punto, ci si dovrebbero porre domande più ampie: “I cittadini dovrebbero poter esprimere il loro voto sull’euro”, provoca Tagesspiegel.
A esprimere i dubbi più concreti della finanza è il quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), che si chiede come reagirà la Banca centrale europea (Bce) ai risultati poco chiari delle elezioni italiane. La Bce ha già detto che non interverrà sui mercati a favore di quegli Stati in cui non si portano avanti i piani strutturali di risanamento.
I recenti risultati elettorali non fanno pensare a una prosecuzione dei programmi previsti dal Meccanismo europeo di stabilità (Esm), per il momento c’è una grande confusione che porta insicurezza politica. Sta all’Italia ora dimostrare il contrario, e cioè di saper rispettare le scelte dei cittadini senza dimenticare il suo ruolo in Europa.
