- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Se punti tutto sul rosso e la pallina della roulette cade sul nero, perdi. Finisce così, non hai diritto ad alcun rimborso. Ma se il croupier, pagato dal casinò, ti ha indotto a rischiare spiegandoti male le regole del gioco, allora il discorso cambia. E’ più o meno in questi termini che si pone il dilemma etico-giuridico nato dopo il salvataggio di Pop Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti.
La procedura attivata per risolvere le crisi dei quattro istituti ha causato gravi perdite a molti piccoli risparmiatori. Dalla sera alla mattina queste persone hanno visto sparire tutti i soldi investiti nelle obbligazioni subordinate della propria banca, titoli ad alto rendimento e quindi ad alto rischio. Chi di loro ha diritto a essere risarcito, almeno in parte, con fondi pubblici?
Rispondere a questa domanda è difficile, perché non tutti i risparmiatori coinvolti sono uguali. E’ probabile che molti non fossero nelle condizioni di comprendere l’entità del rischio cui si esponevano quando hanno comprato i bond: davanti a decine di pagine scritte in linguaggio tecnico, di solito, si firma quello che c’è da firmare, fidandosi dei consigli (interessati) che arrivano dall’altra parte della scrivania.
Ma anche ammettendo la malafede delle banche (che andrà dimostrata in tribunale), il quadro non può essere completo. A molte altre persone, infatti, non sarebbe giusto concedere alcun indennizzo. Si pensi a chi, pur avendo gli strumenti per capire il pericolo associato all’investimento, ha scelto di non informarsi per superficialità o per pigrizia. Oppure agli investitori mossi da semplice fame speculativa, visto che i bond subordinati garantivano tassi d’interesse fino al 6-7 per cento.
Il problema è che, sotto il profilo giuridico, risulta complicato stabilire quali vittime siano innocenti e in quali casi siano state raggirate dalle banche. A questo punto, perciò, bisogna fare una scelta e il criterio della condizione economica generale sembra sensato: se dobbiamo selezionare qualcuno da aiutare, è giusto cominciare da chi dopo la perdita dell’investimento si ritrova con le difficoltà materiali più gravi.
Alcuni risparmiatori, poi, sostengono di aver chiesto indietro il denaro dopo aver ricevuto una comunicazione relativa all’aumento del rischio dell’investimento (ma prima che fosse necessario il salvataggio), e di aver ricevuto un rifiuto da parte delle banche ala loro richiesta di uscire. Se ciò fosse vero e dimostrabile, probabilmente gli investitori avrebbero diritto a un indennizzo completo.
Insomma, non esiste una soluzione valida per tutti: è necessario valutare caso per caso. Al governo e al Parlamento, però, si richiede anche qualcosa di più, ovvero nuove norme per impedire che situazioni come questa si ripetano in futuro (magari con banche più grandi). In primo luogo, come sostiene da tempo la Banca d’Italia, bisognerebbe proibire la vendita alle persone fisiche di strumenti finanziari ad altissimo rischio come i bond subordinati in questione, che andrebbero riservati ai soli investitori istituzionali, certamente più attrezzati nella valutazione dei pro e dei contro legati a ogni investimento.
In primo luogo, come sostiene da tempo la Banca d’Italia, bisognerebbe proibire la vendita alle persone fisiche di strumenti finanziari ad altissimo rischio come i bond subordinati in questione, che andrebbero riservati ai soli investitori istituzionali, certamente più attrezzati nella valutazione dei pro e dei contro legati a ogni investimento.
Alle banche, inoltre, non dovrebbe essere consentito di smerciare autonomamente le proprie emissioni, perché così facendo operano in evidente conflitto d’interessi. Se un impiegato (per mantenere il posto) deve piazzare i titoli della stessa banca per cui lavora, ha un tornaconto personale sulle transazioni ed è incentivato a non agire nell’interesse esclusivo del cliente.
In alcuni casi particolari, infine, si può immaginare di prevedere l’obbligo di doppia firma sui moduli di sottoscrizione degli investimenti, in modo da tutelare ulteriormente il risparmiatore dal rischio di raggiro. Perché quando punti alla roulette devi sapere cosa stai facendo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
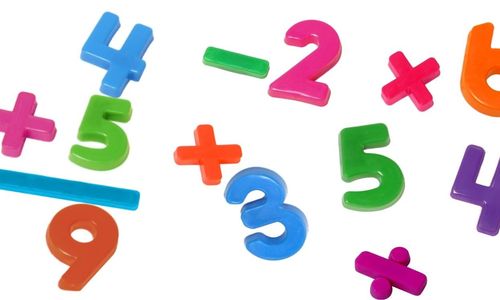 di Antonio Rei
di Antonio Rei
Si dice che le previsioni economiche servano soprattutto a rivalutare l’astrologia. In effetti, a questo punto sarebbe interessante sapere cosa pensano Branko e Paolo Fox del Pil italiano nel 2015, visto che negli ultimi giorni è andato in scena un simpatico “teatro dello zero virgola” molto simile a quello dell’assurdo.
In principio fu il Documento di economia e finanza, in cui tre mesi fa il governo scrisse che quest’anno l’economia del nostro Paese sarebbe cresciuta dello 0,9 percento. Anzi, a essere precisi la stima fu corretta al rialzo dal precedente +0,7% e, naturalmente, il ritocco fu annunciato in tono trionfale dal premier Matteo Renzi. Con il senno di poi viene da chiedersi chi glielo abbia fatto fare.
Già, perché la settimana scorsa il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, ha dato il via a una gustosa girandola di dubbi e ripensamenti. Prima, in un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso il timore che la difficile situazione internazionale prodotta dai fatti di Parigi si ripercuota sulla crescita italiana. Il giorno dopo si è smentito.
A quel punto è entrata in gioco l’Istat, che prima ha seminato il panico conquistando titoli strillati sui giornali, poi ha aggiustato il tiro snocciolando una spiegazione iper-tecnica da cui emerge in modo chiaro soltanto che nessun giornalista italiano è laureato in statistica.
In sostanza, l’Istituto ha scritto che ad oggi la previsione è di un +0,7% rispetto al 2014 (la stessa del governo prima della revisione estiva), ma il dato “non è immediatamente confrontabile con la previsione formulata dal governo, pari a +0,9%, come invece messo in evidenza dalla stampa”. E perché mai no?
Suvvia, è intuitivo: il 2015 ha avuto ben tre giornate lavorative in più rispetto all’anno scorso e, “sulla base delle regolarità empiriche registrate in serie storica si può stimare che tre giorni in più abbiano un effetto al rialzo dell’ordine di +0,1 punti percentuali”. Morale della favola: per l’Istat quest’anno si cresce dello 0,8%. Sarà un buon compromesso per tagliare la testa al toro?
Deve essere piaciuto perlomeno a Renzi, che, impreziosendo l’ennesima presentazione dell’ultima fatica letteraria di Bruno Vespa, ha messo in scena un siparietto mica male: “Noi - ha detto - abbiamo fatto a inizio anno una previsione dello 0,7% ; poi, visto che le cose andavano meglio, l'Istat ha portato la stima allo 0,9% (idem il Governo, ma ora l’amnesia torna utile, ndr), forse chiudiamo allo 0,8 percento. I dati sono ancora in movimento, comunque migliori delle previsioni di inizio anno”. Poi però è arrivato in diretta un messaggino stizzito da via XX Settembre: “Sulla crescita del Pil, +0,8 o + 0,9%, la mia posizione è quella di Padoan. Lo dico perché - ha aggiunto - sono stato appena richiamato all'ordine dal ministro: mi ha scritto di tenere la linea dello 0,9%”.
Infine, Padoan stesso si è deciso a chiudere la querelle con un’affermazione che getta una luce grottesca sull’intero dibattito: “Il ministero non cambia le sue previsioni - ha detto il numero uno del Tesoro - ma se ci dovesse essere un risultato inferiore allo 0,9%, ciò avrebbe effetti marginali sulla finanza pubblica”. E allora che ne abbiamo parlato a fare così a lungo? Perché accapigliarsi per uno 0,1 o 0,2% in più o in meno? E’ politica, bellezza.  In termini reali, che il Pil cresca dello 0,7, dello 0,8 o dello 0,9% non cambia nulla a nessuno: si tratta comunque di una ripresa debole, che non può contare su una decisa ripartenza né degli investimenti né dei consumi interni e perciò resta esclusiva conseguenza di fattori esterni al nostro Paese (il prezzo del petrolio, l’euro debole, l’oceano di liquidità in arrivo dalla Bce).
In termini reali, che il Pil cresca dello 0,7, dello 0,8 o dello 0,9% non cambia nulla a nessuno: si tratta comunque di una ripresa debole, che non può contare su una decisa ripartenza né degli investimenti né dei consumi interni e perciò resta esclusiva conseguenza di fattori esterni al nostro Paese (il prezzo del petrolio, l’euro debole, l’oceano di liquidità in arrivo dalla Bce).
Quel decimale ha molto più a che vedere con le vicende di Palazzo che con quelle economiche. E’ la prima volta che una statistica così rilevante come il Pil sbugiarda la vanagloria di questo governo, il cui sport preferito in ambito economico è attribuirsi meriti altrui.
Magari esiste anche qualcuno disposto a credere che gli 80 euro abbiano rilanciato la domanda, che il Jobs act abbia rianimato il mercato del lavoro o che “la fiducia e la consapevolezza nei propri mezzi” facciano miracoli, ma prima o poi la distanza fra le chiacchiere del Premier e il mondo reale diventerà sempre più evidente. In fondo, per qualsiasi cosa, si comincia sempre da uno 0,1.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Metti insieme il regno delle class action, gli Stati Uniti, e i prodotti finanziari più redditizi e oscuri, i derivati. Il risultato è un’azione legale (l’ennesima) contro le 10 banche più potenti del pianeta: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS e Royal Bank of Scotland.
La settimana scorsa questo dream team della finanza mondiale è finito sotto accusa per aver creato un cartello che, “almeno dal 2007”, avrebbe impedito l’ingresso d’intermediari non bancari sul mercato degli “interest rate swap”, un tipo particolare di derivati.
A presentare l’azione giudiziaria sono stati il Public School Teachers’ Pension e il Retirement Fund of Chicago, due fondi pensione che sostengono di aver pagato più del dovuto i contratti di swap a causa delle limitazioni alla concorrenza generate dal presunto cartello.
Insieme alle banche, sono state citate in giudizio davanti alla Corte distrettuale di Manhattan anche due piattaforme di scambio degli swap: Icap e Tradeweb. Quest'ultima è controllata al 40% dall'agenzia di stampa anglo-canadese Thomson Reuters, che però non è stata accusata di alcun illecito.
Il caso ha suscitato grande clamore non solo per i nomi degli istituti coinvolti, ma anche per il peso nel sistema finanziario globale degli “interest rate swap”. Con questa espressione si fa riferimento ai contratti swap più diffusi, attraverso i quali due parti si scambiano - per un periodo di tempo prestabilito - pagamenti calcolati sulla base di tassi d’interesse differenti e predefiniti, applicati a una somma di riferimento. In sostanza, non c'è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due tassi d’interesse (di solito uno fisso e uno variabile).
Il mercato degli “interest rate swap” è ciclopico: vale circa 320mila miliardi di dollari, una cifra difficile da immaginare. Solo per avere un termine di paragone, basti pensare che il Prodotto interno lordo degli Stati Uniti è pari a circa 16.700 miliardi, venti volte meno del business legato agli Irs.
Insomma, da soli questi derivati costituiscono una larga fetta di quell’attività speculativa che non ha nulla a che vedere con l’economia reale e che garantisce ai colossi di Wall Street la massima parte dei loro guadagni. E’ come una gigantesca nube finanziaria che sovrasta la realtà produttiva senza più bisogno d’intrattenere con essa alcun rapporto.
Proprio dalla folle compravendita di derivati (tossici) è iniziata la crisi del 2007, che, nata negli Usa, ha poi attraversato l’Atlantico per trasformarsi a poco a poco nella crisi dei debiti sovrani europei. All’epoca il peccato originale fu nei “credit default swaps” legati ai mutui subprime, ovvero titoli derivati che funzionavano come assicurazioni sulla fragile vita dei mutui immobiliari più criminali della storia contemporanea.  Non più tardi dello scorso settembre si è conclusa negli Stati Uniti un’altra class action che aveva come oggetto proprio i Cds (il cui mercato a fine 2014 valeva 16mila miliardi di dollari). In quel caso erano coinvolte 12 banche - fra cui Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Citigroup -, accusate dagli investitori di aver manipolato il mercato dei “credit default swaps” per controllare le informazioni, limitare la concorrenza e manipolare i prezzi.
Non più tardi dello scorso settembre si è conclusa negli Stati Uniti un’altra class action che aveva come oggetto proprio i Cds (il cui mercato a fine 2014 valeva 16mila miliardi di dollari). In quel caso erano coinvolte 12 banche - fra cui Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Citigroup -, accusate dagli investitori di aver manipolato il mercato dei “credit default swaps” per controllare le informazioni, limitare la concorrenza e manipolare i prezzi.
Alla fine gli istituti, pur senza ammettere alcuna responsabilità, hanno patteggiato, accettando di pagare un risarcimento da 1,87 miliardi di dollari. Una conclusione analoga a quella di molte altre cause intentate contro banche americane per il far west che ancora regna nel mondo dei derivati.
E alle banche non potrebbe andare meglio di così: per quanto costoso, il patteggiamento chiude la causa particolare senza mettere in discussione il sistema generale. Non sarà perciò una grande sorpresa se anche la class action aperta la settimana scorsa si chiuderà in questo modo. In fondo, non è bastata una crisi globale per regolamentare il mercato in cui si fanno soldi dai soldi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Di fronte al terrorismo, l'Europa riesce finalmente a mettere nel cassetto il vangelo secondo Maastricht. Dopo i fatti di Parigi, il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha ammesso che la Francia "deve affrontare dei costi supplementari" per la sicurezza e queste spese non possono "ricevere lo stesso trattamento delle altre" rispetto al Patto di Stabilità. Un principio che, secondo il premier italiano Matteo Renzi, è "positivo, giusto e sacrosanto", perciò dovrà "valere anche per gli altri Stati: figurarsi se uno sta attento allo 'zero virgola' sulla sicurezza".
L'apertura alla flessibilità in funzione anti-terrorismo è arrivata dopo che Bruxelles aveva già concesso indulgenza contabile sulle spese eccezionali annunciate da François Hollande. A spiegare la presa di posizione politica e ideologica alla base di questa scelta è stato Pierre Moscovici, commissario europeo agli Affari economici nonché ex ministro francese delle Finanze: "Una cosa è chiara nelle circostanze attuali - ha detto - in questo momento terribile la sicurezza dei cittadini in Francia e in Europa è la priorità assoluta e la Commissione Ue lo capisce pienamente".
Com'era ovvio, nessuno ha protestato quando il premier francese Manuel Valls ha fatto sapere che i parametri di budget concordati da Parigi con l'Ue "saranno ampiamente superati" e che l’Europa "dovrà comprendere" tali necessità della Francia e permetterle di utilizzare nuovi fondi per Polizia, Gendarmeria e Intelligence. Per la verità, è ormai da anni che la Francia non rispetta i vincoli di bilancio europei e di solito quando ha bisogno di una deroga non la chiede, semmi la annuncia, e Bruxelles si limita a mettere il timbro in silenzio.
Stavolta però il trattamento di favore riservato a Parigi non ha a che vedere con il potere politico-economico di cui la Francia dispone, ma con la gravità della minaccia terrorista che incombe su tutta l'Europa. Di conseguenza, qualsiasi concessione a Hollande e a Valls in termini di finanza pubblica non varrà più solo per loro, ma dovrà essere estesa a ogni membro dell'Eurozona. In questo modo entra in vigore una nuova regola finora mai enunciata con tanta chiarezza: il patto di Sicurezza vince su quello di Stabilità.
E' chiaro a tutti che si tratta di un principio "giusto e sacrosanto", per dirla con Renzi. La domanda a cui rispondere, semmai, è un'altra: era davvero necessario arrivare a questo punto per capire che il rispetto dei vincoli di bilancio non è il primo obiettivo da perseguire quando in gioco c'è la vita delle persone? In nessun Pese i conti pubblici esplodono se a fine anno il deficit è al 3,2 piuttosto che al 2,9% del Pil. E questo non significa che sia giustificabile o auspicabile una spesa pubblica fuori controllo, ma che in caso di necessità gli Stati hanno il dovere d'intervenire, deficit o non deficit.  L'urgenza imposta dal terrorismo è particolarmente evidente e oggi, giustamente, siamo tutti convinti che la tutela della sicurezza fisica dei cittadini sia più importante delle questioni di budget. Quello che si fa più fatica a comprendere è per quale ragione finora l'Europa non abbia dato lo stesso valore alla sicurezza sociale.
L'urgenza imposta dal terrorismo è particolarmente evidente e oggi, giustamente, siamo tutti convinti che la tutela della sicurezza fisica dei cittadini sia più importante delle questioni di budget. Quello che si fa più fatica a comprendere è per quale ragione finora l'Europa non abbia dato lo stesso valore alla sicurezza sociale.
Per quanto in lieve diminuzione, lo scorso settembre i disoccupati nell'Eurozona erano ancora 17,3 milioni, pari a un tasso del 10,8%, secondo Eurostat. A ottobre, inoltre, lo stesso istituto di statistica comunitario ha fatto sapere che nel 2014 le persone a rischio povertà o esclusione sociale nell’Unione europea erano 122 milioni, circa il 25% del totale, contro il 23,8% del 2008. In altre parole, solo l'anno scorso un europeo su quattro versava "in condizione di grave deprivazione di beni materiali". Peggio della media l'Italia, dove nel 2014 la quota delle persone a rischio povertà ha raggiunto il 28,1%, in aumento del 2,8% rispetto al 2008.
Purtroppo a Bruxelles questi numeri vengono ancora considerati dei danni collaterali tutto sommato accettabili. O, perlomeno, non sono visti come una motivazione sufficiente per interrompere il culto del vangelo secondo Maastricht.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Costerà meno, ma non diventerà né più semplice né più equo. Per ora sono queste le sole certezze sul nuovo canone Rai. La legge di Stabilità arrivata in Parlamento la settimana scorsa prevede che nel 2016 l'importo da pagare calerà da 113,5 a 100 euro e che l'imposta sarà inserita nella bolletta elettrica. I dettagli tecnici sulle modalità di pagamento e sulle sanzioni sono demandati a un decreto del Tesoro che dovrà essere emanato di concerto con il ministero dello Sviluppo economico e con l'Autorità per l'Energia entro i 45 giorni successivi all'approvazione della manovra.
La novità del canone in bolletta dovrebbe abbattere l'evasione: le risorse così recuperate nel biennio 2016-2018 (e in eccesso rispetto ai bilanci di previsione Rai, s'intende) saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il governo, per prudenza, non quantifica il maggiore gettito che prevede d'incassare, ma la somma non deve essere irrisoria, considerando che oggi il tasso di evasione del canone è stimato al 27% (pari a 540 milioni di euro l’anno), il più alto fra quelli di tutte le imposte italiane e di tutti i canoni radiotelevisivi d'Europa. Il pagamento sarà probabilmente diviso in sei rate da 16,66 euro l'una e inizierà con la prima bolletta della luce successiva alla scadenza del pagamento della tassa sulla tv, fissata al 31 gennaio.
L’imposta sarà dovuta solo per la prima casa, partendo dal presupposto che l'esistenza di una fornitura di "energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo". Chi non ha in casa né una televisione né una radio (tablet e smartphone, per ora, sono esclusi dalla norma) potrà richiedere l'esenzione inviando un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate. Ciò implica che dall'anno prossimo gli evasori, oltre a dover pagare una sanzione amministrativa (fin qui si è parlato di 500 euro, ma in molti pensano che sarebbe una multa eccessiva), saranno perseguibili anche in sede penale, perché violeranno la legge 445 del 2000 sull'autocertificazione.
Insomma, le novità non sono poche e andranno digerite in breve tempo. La difficoltà tecnica più complicata da superare riguarda l'inserimento del canone nelle bollette, visto che in Italia - dopo la liberalizzazione del 2007 - le società autorizzate a emettere fatture elettriche sono ben 461, si fanno una concorrenza spietata e (giustamente) non hanno alcun interesse a collaborare per diventare esattori dello Stato.
Già l'anno scorso le utility coinvolte mettevano in luce diversi problemi legati a questa innovazione. Innanzitutto, con l’aggiunta del canone aumenterebbero per le imprese gli oneri di gestione e di riscossione, il che potrebbe riflettersi sulle bollette, rischiando di annullare i risparmi prodotti dalla riduzione del canone. Gli utenti, poi, sono liberi di cambiare fornitore anche più volte nel corso di un anno e ciò provocherà verosimilmente un gran caos nella riscossione dell'imposta sulla tv pubblica.
Anche l'equazione bolletta della luce = presenza di una tv o di una radio in casa, per quanto in apparenza ragionevole, rischia di risolversi in uno di quei pasticci che producono fiumi di ricorsi. In gioco ci sarebbe nientemeno che il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione, visto che i contribuenti in possesso di tv o radio, ma che al contempo non sono intestatari di una bolletta elettrica, risulterebbero esentati.
D'altra parte, al di là dello sconto di 13 euro e 50 centesimi l'anno, gli stessi contribuenti hanno poco di cui rallegrarsi. Le nuove norme in arrivo, infatti, non risolvono nemmeno uno dei problemi strutturali legati al canone, che è sempre stato e continuerà a essere uno tributi più odiati dagli italiani. Almeno per due ragioni. Primo: è slegato dal reddito, perciò contraddice il principio della progressività delle imposte, anch'esso stabilito dalla Costituzione. Secondo: ora che il monopolio è un lontano ricordo e il mercato radiotelevisivo è più che aperto, quello offerto dalla Rai non è più un servizio essenziale e andrebbe pagato solo da chi vuole usufruirne. In altri termini, dovremmo essere liberi di scegliere se versare il canone e guardare la Rai, oppure risparmiare il denaro e ritrovarci con la Rai oscurata.  Si può obiettare che il servizio pubblico deve essere sostenuto da tutti perché è concepito nell'interesse della collettività e non delle famiglie Berlusconi (Mediaset Premium) e Murdoch (Sky). In teoria il ragionamento è più che giusto, ma nella pratica conviene far pace con la realtà. Davvero qualcuno crede ancora alla favola del pluralismo garantito dal servizio pubblico?
Si può obiettare che il servizio pubblico deve essere sostenuto da tutti perché è concepito nell'interesse della collettività e non delle famiglie Berlusconi (Mediaset Premium) e Murdoch (Sky). In teoria il ragionamento è più che giusto, ma nella pratica conviene far pace con la realtà. Davvero qualcuno crede ancora alla favola del pluralismo garantito dal servizio pubblico?
La Rai è sempre stata il regno della lottizzazione fra i partiti e la riforma della governance varata da questo governo non favorisce affatto l'indipendenza dell'azienda. Al contrario: non solo conferma il dominio della politica sulla Rai, ma accentra addirittura il potere, visto che il nuovo super-amministratore delegato sarà nominato dal Cda su proposta del Tesoro, quindi dell'Esecutivo. Quanti italiani pagherebbero 100 euro l'anno per consentire tutto questo, se potessero scegliere?
