- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Michele Paris
di Michele Paris
Un nuovo rapporto pubblicato recentemente dalla banca Credit Suisse ha delineato l’aggravarsi delle disparità di reddito e di ricchezza nel pianeta, registrando un tristissimo primato. L’1% della popolazione mondiale è cioè giunta nel 2015 a possedere oltre la metà delle ricchezze, mentre il resto dell’umanità - ovvero circa 4,8 miliardi di adulti - si spartisce il resto della torta, peraltro in maniera altrettanto ineguale.
Lo studio riassume i dati raccolti in una piramide che mostra immediatamente le disparità che caratterizzano la suddivisione dei beni disponibili a livello globale, stimati attorno ai 250 mila miliardi di dollari. 3,4 miliardi di adulti posseggono beni non superiori ai 10 mila dollari, un altro miliardo tra i 10 mila e i 100 mila dollari, 349 milioni tra i 100 mila e un milione.
Allo strettissimo vertice della piramide si trova la vera ricchezza, con 34 milioni di persone che detengono più di un milione di dollari. Tra di essi, 29,8 milioni vantano beni tra 1 e 5 milioni di dollari, 2,5 milioni tra 5 e 10 milioni, 1,34 milioni tra 10 e 50 milioni, per poi arrivare alla vera aristocrazia planetaria, quella che decide le sorti di praticamente tutte le popolazioni, vale a dire 123.800 individui con più di 50 milioni di dollari ciascuno.
Poco meno della metà di questi super-ricchi vive negli Stati Uniti, circa un quarto in Europa e il resto quasi tutti in Giappone e in Cina. Lo sbilanciamento nella distribuzione delle ricchezze è dovuto principalmente al capitalismo USA, come conferma il fatto che questo paese ha un numero così elevato di multi-milionari a fronte del 5% della popolazione del pianeta.
Esaminando i numeri proposti dall’istituto bancario svizzero, emerge come il 71% degli adulti che popola il pianeta è costretto a vivere con appena il 3% delle ricchezze complessive, laddove un minuscolo 0,7% controlla beni pari al 45,2% del totale. Ancora, il 10% della popolazione può contare sull’87,7% delle ricchezze, lasciando al 90% degli adulti appena il 12,3% dei beni totali. Come già ricordato, l’1% detiene infine il 50,4% dei beni, una soglia altamente simbolica che secondo alcuni studi precedenti sarebbe stata superata solo nei prossimi anni. A dare l’idea della scarsità di beni che possiedono coloro che si trovano alla base della piramide basta citare un dato, cioè che sono sufficienti poco più di 3 mila dollari per essere inclusi nella metà più “ricca” della popolazione mondiale.
A dare l’idea della scarsità di beni che possiedono coloro che si trovano alla base della piramide basta citare un dato, cioè che sono sufficienti poco più di 3 mila dollari per essere inclusi nella metà più “ricca” della popolazione mondiale.
Per rientrare nel 10% più benestante di dollari ne bastano invece quasi 69 mila. La definizione di ricchezza considerata da Credit Suisse comprende, oltre al denaro, proprietà immobiliari e titoli azionari, mentre dal conteggio sono esclusi i debiti.
Come conferma il rapporto, le disuguaglianze sono rapidamente aumentate in tutto il mondo dopo la crisi finanziaria scaturita da Wall Street nel 2008. A generare un ulteriore spostamento verso l’alto della ricchezza sono stati e continuano a essere soprattutto i programmi pubblici di salvataggio delle grandi banche e l’espansione del credito di fatto a costo zero che, invece di stimolare l’economia reale, ha ingigantito le rendite parassitarie.
Significative sono anche le differenze tra i vari continenti o paesi del mondo. Se la ricchezza complessiva degli Stati Uniti è cresciuta finora nel 2015 di 4 mila 600 miliardi di dollari, nonostante un calo a livello globale di 12 mila 700 miliardi, principalmente a causa del rafforzamento del dollaro, i paesi dell’Unione Europea, la Russia e il Giappone hanno fatto segnare flessioni importanti. Quella della Cina è poi salita di 1.500 miliardi di dollari, anche se lo studio prende in considerazione i dati fino al 30 giugno scorso, tralasciando quindi il recente crollo del mercato azionario in questo paese.
Simili differenze hanno ovviamente riflessi rilevanti all’interno del sistema capitalistico globale. Infatti, la crescita e la perdita di ricchezza soprattutto delle potenze mondiali contribuisce a inasprire i conflitti o, quanto meno, a peggiorare le relazioni tra i paesi, come conferma l’aggravamento delle tensioni in molte aree del globo, a cominciare dal Medio Oriente e dall’Asia sud-orientale.
La sempre maggiore concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi è il sintomo anche dello stato di avanzato deterioramento in cui versa lo stesso capitalismo planetario, con tutte le conseguenze distruttive che ne derivano per le popolazioni del pianeta. La disponibilità virtualmente illimitata di beni per un numero ristrettissimo di ultra-ricchi determina infatti automaticamente un degrado delle condizioni di vita di tutti gli altri, principalmente a causa di effetti devastanti in vari ambiti, dall’assistenza sanitaria allo stato delle infrastrutture e all’educazione.
La disponibilità virtualmente illimitata di beni per un numero ristrettissimo di ultra-ricchi determina infatti automaticamente un degrado delle condizioni di vita di tutti gli altri, principalmente a causa di effetti devastanti in vari ambiti, dall’assistenza sanitaria allo stato delle infrastrutture e all’educazione.
Uno scenario, quello che si sta delineando, che non può che alimentare tensioni sociali sempre più esplosive, dirette alla riappropriazione di risorse enormi, dirottate deliberatamente verso l’alto e che sarebbero invece abbondantemente sufficienti a garantire i bisogni fondamentali dell’intera popolazione del pianeta.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
In credibile ma vero, un candidato alla Casa Bianca getta sul piatto della campagna elettorale una delle più gravi malattie di Wall Street. Hillary Clinton, già segretario di Stato nella prima presidenza Obama e oggi in corsa per i democratici, ha promesso di tassare l'Hft in caso di vittoria alle presidenziali del 2016.
L'acronimo sta per High frequency trading, ovvero gli scambi di Borsa ad alta velocità operati in modo automatico sulla base di algoritmi. Si tratta di una pratica che, agendo su volumi immensi, garantisce lauti profitti ai colossi della finanza, che riescono a speculare anche sulle minime variazioni dei prezzi registrate ogni secondo, mobilitando masse spesso in grado di condizionare l'andamento dei titoli trattati. Allo stesso tempo, quindi, l'Hft danneggia gli investitori medio-piccoli, perché rende impossibile la trasparenza sui prezzi e genera altissima volatilità, destabilizzando i mercati.
Ora, Hillary Clinton non è mai stata in cattivi rapporti con le banche d'affari americane, per cui l'ipotesi di stangare i re della Borsa risulta piuttosto sorprendente e si spiega solo con un calcolo politico in vista delle primarie democratiche. Evidentemente, l'ex first lady punta a recuperare i voti dei progressisti, un bacino elettorale che al momento sembra spostarsi verso candidati ben più di sinistra, come il senatore "socialista" Bernie Sanders.
"La crescita dell'high-frequency trading ha avuto un peso sui nostri mercati consentendo strategie di scambio scorrette e speculative", ha detto uno dei consiglieri della Clinton. L'idea per combattere questa pratica, spiegano dallo staff della candidata dem, consiste nel tassare le transazioni con un numero eccessivo di cancellazioni.
Ma l'Hft non è un problema solo americano. "Nei principali paesi europei - si legge in un documento Consob del dicembre 2012 - la quota di scambi riconducibili ad operatori identificati come high frequency traders è cresciuta costantemente negli ultimi anni e attualmente oscilla tra circa il 10 e il 40% a seconda dei paesi".
Quanto ai possibili effetti di questa pratica, "il dibattito accademico - prosegue la Commissione - ha evidenziato, senza tuttavia giungere a risultati univoci, la possibilità che la crescente diffusione dell'high frequency trading amplifichi l'impatto sistemico di shock e influisca negativamente sull'integrità e sulla qualità del mercato (efficienza informativa dei prezzi, volatilità e liquidità)".  L'Hft è perciò una delle armi più potenti in mano ai pescecani della speculazione, che investono alla ricerca di guadagni immediati, distorcendo il mercato a danno di chi non ha la loro potenza di fuoco. La divaricazione fra la terraferma dell'economia reale e la nube della finanza speculativa ha raggiunto così il suo apice.
L'Hft è perciò una delle armi più potenti in mano ai pescecani della speculazione, che investono alla ricerca di guadagni immediati, distorcendo il mercato a danno di chi non ha la loro potenza di fuoco. La divaricazione fra la terraferma dell'economia reale e la nube della finanza speculativa ha raggiunto così il suo apice.
Investire con raziocinio e competenza, puntando sulle società quotate che producono risultati giorno dopo giorno, è ormai un'attività marginale per chi ha in mano le sorti dei mercati. Di fronte alle possibilità messe a disposizione dalle piattaforme informatiche combinate a sofisticati algoritmi, i rendimenti di lungo periodo sono davvero poco attraenti.
In uno scenario simile, che la tassa proposta dalla Clinton sia in grado di correggere anche solo in parte questi squilibri è tutto da dimostrare, anche perché al momento siamo ancora nel campo degli slogan. Eppure, il semplice fatto che l'high frequency trading sia entrato nel dibattito pubblico americano in modo così esplicito è un avvenimento che merita di essere segnato sul calendario.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
La nuova legge di Stabilità ancora non c'è - arriverà entro il 15 ottobre - ma nel suo tessuto già s'intravede il contorno dei buchi. Le preoccupazioni nascono dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza approvata venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, un testo che dovrebbe costituire la base di lavoro per la prossima manovra.
In sostanza, il governo fa affidamento su un ipotetico tesoretto da quasi 18 miliardi che l'Ue dovrebbe concedere al nostro Paese per il 2016 in termini di maggiore flessibilità. "L’indebitamento netto - si legge nella relazione al Parlamento allegata alla Nota - potrà aumentare rispetto al profilo tendenziale fino ad un importo massimo di 17,9 miliardi nel 2016 (che include, ove riconosciuti in sede europea, i margini di flessibilità correlati all’emergenza immigrazione fino a un importo di 3,3 miliardi), 19,2 miliardi nel 2017, 16,2 miliardi nel 2018 e 13,9 miliardi nel 2019".
In altre parole, l'Italia chiede all'Europa il permesso di avere un deficit maggiore del previsto non solo nel 2016, ma anche nel 2017 (+1,1 punti di Pil), nel 2018 (+0,9 punti) e nel 2019 (+0,7). Il governo ritiene infatti che "una riduzione ancora più corposa del deficit strutturale nel 2017 sarebbe controproducente e che un calo complessivo di 0,7 punti nel biennio 2017-2018 (e di due punti di Pil in termini di disavanzo nominale) costituisca già uno sforzo fiscale straordinario". Di conseguenza, il pareggio di bilancio subirà un ulteriore slittamento dal 2017 al 2018 (inizialmente era previsto per il 2014).
Ora, il Patto di stabilità e crescita europeo elenca tre possibili "clausole di flessibilità", ovvero ragioni per le quali a un Paese può essere concesso di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio a medio termine: 1) l'avversità del ciclo economico; 2) l'approvazione di importanti riforme strutturali; 3) la cosiddetta "golden rule", vale a dire la possibilità di scorporare dal deficit le spese per investimenti cofinanziati con l'Europa.
Della prima clausola non possiamo più avvalerci, perché quest'anno il Pil italiano è tornato in positivo (il governo ha perfino rivisto al rialzo le stime, portandole da +0,7 a +0,9%). Così, per riempire il vuoto, abbiamo tirato in ballo l'emergenza immigrazione: siccome dobbiamo far fronte a innumerevoli sbarchi, abbiamo bisogno di risorse aggiuntive (quei 3,3 miliardi di cui sopra, pari a 0,2 punti di Pil).
In teoria il ragionamento fila, sennonché quei soldi non sarebbero davvero impiegati per i migranti, ma per finanziare la nostra prossima manovra di bilancio, e in particolare i tagli delle tasse promessi da Renzi. E' difficile che a Bruxelles sfugga un dettaglio del genere, tanto più che il nostro stesso ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, ha ammesso di "non conoscere esattamente" questa presunta regola che legherebbe flessibilità e migranti.
Per quanto riguarda gli altri margini di manovra chiesti dall'Italia, circa 5,4-5,5 miliardi sono legati alla clausola sugli investimenti e i rimanenti 9,1-9,2 miliardi alle concessioni per le riforme. Di quest’ultima quota, il governo aveva già ottenuto flessibilità per 0,4 punti di Pil (7,3 miliardi) e ora chiede di poter contare su altri 1,7/1,8 miliardi in più. A tal proposito, l'Ufficio parlamentare di bilancio ricorda che "sarà la Commissione europea a verificare sia l’esistenza delle condizioni per usufruire della flessibilità sia quanta flessibilità concedere" e che "ciò dipenderà dal tipo di riforme e dalla loro effettiva realizzabilità". Dall'Ue, per ora, non arrivano indicazioni: "Valuteremo la posizione fiscale dell’Italia in rapporto al Patto di stabilità e crescita in autunno, nella nostra opinione sulla bozza della Legge di bilancio, una volta che l’avremo ricevuta", ha detto all'Ansa la portavoce del commissario europeo agli Affari economici.
Dall'Ue, per ora, non arrivano indicazioni: "Valuteremo la posizione fiscale dell’Italia in rapporto al Patto di stabilità e crescita in autunno, nella nostra opinione sulla bozza della Legge di bilancio, una volta che l’avremo ricevuta", ha detto all'Ansa la portavoce del commissario europeo agli Affari economici.
Insomma, se alla fine l'Europa sbloccherà tutti i 17,9 miliardi previsti, il governo avrà trovato senza difficoltà le coperture per buona parte di quella manovra da 27 miliardi annunciata la settimana scorsa dal Premier. Se invece Bruxelles dovesse impuntarsi anche soltanto su una delle richieste dell'Italia, nella legge di Stabilità si apriranno delle falle da sigillare con le solite invenzioni contabili d'autunno.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Dopo una delle settimane peggiori degli ultimi anni, chiusa con un ribasso del 6,5%, lunedì Piazza Affari ha registrato un crollo memorabile: -5,96% in una sola seduta. Per ritrovare un tonfo simile dobbiamo risalire al novembre 2011, quando in Europa scoppiava la crisi del debito sovrano, lo spread volava a 575 punti base e i rendimenti sui Btp decennali schizzavano all'8 percento.
Eppure, il crollo di ieri non riguarda solo l'Italia o i Pigs, ma coinvolge tutte le principali Borse mondiali (Francoforte -4,7%, Parigi -5,3%, Londra -4,6%, Tokyo -4,6%, Dow Jones, Nasdaq e S&P500 rispettivamente -3,5%, -3,8% e -3,9%), trainate al ribasso dai crolli in sequenza del listino di Shanghai (-8,45% lunedì, dopo il -11% della settimana scorsa).
Ma come si è arrivati a tanto? Andiamo con ordine. A metà agosto, la tripla svalutazione dello yuan decisa da Pechino ha determinato prima una crisi borsistica locale, poi una crisi della moneta cinese e di buona parte delle valute emergenti, infine un contagio su scala mondiale. Inizialmente si pensava che il problema cinese fosse circoscritto agli interessi del gigante asiatico, tant'è vero che in un primo momento - mentre le Borse cinesi crollavano - i listini europei tenevano botta. Ciò si spiega con le limitazioni imposte dalla Cina stessa: gli operatori stranieri possono investire poco sui listini di Shanghai e Shenzhen, perciò l'esposizione diretta degli operatori occidentali ai mercati cinesi è estremamente ridotta.
In seguito, però, fra gli investitori globali si è diffuso il timore che il governo cinese - dopo essersi dimostrato incapace di gestire efficacemente la crisi della Borsa - fallisca anche nel tentativo di dare nuovo slancio alla crescita del Pil, che sta rallentando (anche se le stime parlano comunque di un +6,8% per quest'anno, di un +6,5% per il 2016 e di un +6% per la fine del decennio).
Pechino, dal canto suo, non ha fatto molto per allontanare queste parure, dal momento che fin qui non sono state prese misure efficaci per rilanciare gli investimenti fissi, l'export e soprattutto i consumi interni, che dovrebbero essere stimolati (alzando i salari) per compensare il rallentamento della domanda in altre aree del mondo.
Il cuore del problema, dunque, non è economico, ma politico. A spaventare i mercati non sono (ancora) i numeri, ma le scarse capacità dimostrate dalla dirigenza del Partito nella gestione della crisi. Il vero dilemma è nelle riforme promesse e finora rimaste sulla carta perché osteggiate dai gruppi di dirigenti del Partito che preferiscono continuare a puntare tutto sulle esportazioni. Anche sul versante azionario il quadro è simile. Pur avendo perso circa il 35% rispetto ai livelli massimi, la Borsa cinese rimane in crescita di quasi il 100% rispetto all'anno scorso. Tuttavia, non è escluso che la correzione continui sui mercati europei, perlomeno finché il governo di Pechino non convincerà gli investitori globali di avere di nuovo la situazione sotto controllo.
Anche sul versante azionario il quadro è simile. Pur avendo perso circa il 35% rispetto ai livelli massimi, la Borsa cinese rimane in crescita di quasi il 100% rispetto all'anno scorso. Tuttavia, non è escluso che la correzione continui sui mercati europei, perlomeno finché il governo di Pechino non convincerà gli investitori globali di avere di nuovo la situazione sotto controllo.
D'altra parte, gli strumenti per agire non mancano: esistono circa 5mila miliardi di riserve bloccate che possono essere liberate per sostenere l'economia cinese. Usa e Europa, inoltre, vorrebbero che la Cina tagliasse con più decisione i tassi d'interesse (quello a un anno è ancora al 4 e mezzo percento, contro i livelli prossimi allo zero delle economie occidentali).
Se questi cambiamenti avverranno, il governo cinese riuscirà a rassicurare definitivamente i mercati occidentali. Eppure, non si tratta di una partita che interessa solamente Washington e Bruxelles. Negli ultimi anni, infatti, la Cina è stata il principale sostegno dell'Occidente durante la crisi finanziaria, ma anche un fattore decisivo per la crescita degli altri Paesi emergenti, soprattutto di quelli africani.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
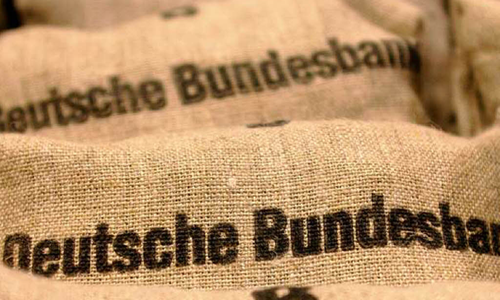 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Anche se la Grecia dichiarasse bancarotta oggi e non restituisse più un euro del proprio debito pubblico, la Germania avrebbe comunque guadagnato dalla crisi di Atene ben 10 miliardi di euro. E' quanto emerge da uno studio dell'istituto tedesco di ricerca economica Iwh, che ha condotto delle simulazioni per stabilire gli effetti sulle casse pubbliche tedesche della vicenda greca.
Secondo l'analisi, negli ultimi cinque anni - ovvero da quando è iniziato il calvario di Atene sui mercati - la Germania ha risparmiato in tutto circa 100 miliardi di euro in termini d'interessi sul debito pubblico, una somma superiore al 3% del Pil della prima economia europea. Iwh ricorda che il 3 gennaio 2010 - prima che divampasse l'incendio finanziario greco - il rendimento del Bund decennale era al 3,2%, mentre ieri si attestava allo 0,66%.
A innescare questo crollo dei tassi sui titoli di Stato tedeschi è stata proprio la crisi ellenica, poiché il clima d'incertezza sul futuro di Atene e quindi dell'Eurozona ha spinto gli investitori a proteggere il proprio denaro puntando sui titoli più sicuri: primi fra tutti i Bund, considerati alla stregua di un bene rifugio e perciò sommersi dagli acquisti quando sui mercati si rischia il collasso.
In altri termini, i tassi d'interesse sui bond tedeschi calano ogni volta che arriva una brutta notizia dalla Grecia e "nel corso della crisi del debito di Eurolandia - scrive Iwh -, la Germania ha beneficiato in modo sproporzionato di questo effetto".
L'istituto di ricerca ha calcolato inoltre che l'esposizione della Germania alla Grecia, comprendendo anche il terzo piano di aiuti ancora da approvare, è di 90 miliardi. Ma Berlino ne ha già risparmiati 100 sui rendimenti, perciò anche in caso di default greco rimarrebbe in attivo di 10 miliardi. In questo modo la Germania esce vincitrice dalla crisi anche sul versante delle finanze pubbliche.
Per quanto riguarda invece la finanza privata, la questione si è chiusa con le grandi manovre messe in atto negli ultimi anni per salvare le banche. Il meccanismo è noto: i soldi dei Fondi salva Stati (provenienti dalle tasche di tutti i contribuenti europei) venivano trasferiti alla Banca centrale greca, la quale a sua volta li girava agli istituti di credito ellenici, che li usavano in massima parte per pagare i propri debiti nei confronti delle altre banche europee.  Così fra il 2009 e il 2014 gli istituti tedeschi hanno ridotto la propria esposizione verso la Grecia da 45 a 13,51 miliardi di euro, scaricando il peso sulle spalle dei contribuenti di tutta l'Unione. Solo che la Germania, grazie al contemporaneo crollo dei tassi d'interesse sul proprio debito, è riuscita a fare in modo che la crisi producesse un guadagno anche per le casse pubbliche, al contrario di quanto è avvenuto in tutti gli altri Paesi coinvolti nel salvataggio di Atene.
Così fra il 2009 e il 2014 gli istituti tedeschi hanno ridotto la propria esposizione verso la Grecia da 45 a 13,51 miliardi di euro, scaricando il peso sulle spalle dei contribuenti di tutta l'Unione. Solo che la Germania, grazie al contemporaneo crollo dei tassi d'interesse sul proprio debito, è riuscita a fare in modo che la crisi producesse un guadagno anche per le casse pubbliche, al contrario di quanto è avvenuto in tutti gli altri Paesi coinvolti nel salvataggio di Atene.
Alla luce di tutto questo, non sorprende che la Germania continui ad opporsi alla ristrutturazione del debito greco, un intervento che invece Fmi e Usa chiedono a gran voce, poiché rappresenta l'unica strada praticabile per rimettere l'economia ellenica su una traiettoria di sostenibilità, sottraendola al perverso e potenzialmente infinito schema Ponzi degli aiuti internazionali (debiti nuovi per ripagare i debiti vecchi). Eppure, dal loro punto di vista, i tedeschi hanno ragione. Perché mai risolvere in modo definitivo una crisi così redditizia?
