- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Da quando nell'autunno del 2006 Mauro Moretti ha preso in mano il timone di Trenitalia le cose sono indubbiamente cambiate, ma di certo non in meglio: se sulla carta sono ancora le Ferrovie dello Stato, nella realtà dei fatti e nella visione morettiana le nostre sono ormai diventate le Ferrovie dell'élite. La rivoluzione di Moretti non ha infatti nulla a che vedere col background da sindacalista che l'ad si porta dietro – Moretti è stato a lungo un dirigente della Filt, la branca della Cgil che si occupa dei ferrovieri – e nella pratica si è concentrata molto più sulla forma che sulla sostanza, riuscendo in quello che la Lega non ha potuto in 24 anni di sproloqui: dividere fisicamente l'Italia.
Certo un Frecciarossa sarà sicuramente più piacevole alla vista rispetto ad un regionale dell'anteguerra ma il drastico ridimensionamento delle tratte e soprattutto dei prezzi, ha fatto sì che per spostarsi da un capo all'altro dell'Italia, l'aereo risulti molto più conveniente del treno. Uno sconvolgimento non da poco nelle abitudini degli italiani che, anche quando sui vagoni e nelle stazioni si mettevano le bombe, lo hanno sempre preferito per i loro viaggi (soprattutto a lunga percorrenza) facendo del treno il mezzo di trasporto nazionalpopolare per eccellenza.
Dacchè si è insediato, Moretti ha fatto di tutto per far dimenticare i propositi e la proprietà pubblica delle ferrovie - che ormai di statale hanno solo i finanziamenti - e ha ripensato l'intera rete in funzione di una sola e risibile parte dell'utenza, quella coi soldi. Puntando tutto sull'Alta Velocità e lasciando a se stessi i più di 9000 convogli che non hanno lo status di “Freccia”, l'ad di Trenitalia ha volutamente escluso dalle sue preoccupazioni (che ricordiamolo in realtà sono preoccupazioni dello Stato), tutti quei pendolari, quei viaggiatori notturni e di lunghe percorrenze che per un motivo o per l'altro tentano di muoversi su e giù per la penisola.
 Usando uno slogan, forma particolarmente amata dai press agents di Trenitalia, peggiora il servizio e aumentano i costi: in uno dei suoi ultimi report Legambiente denuncia infatti come, a fronte di un sensibile aumento degli utenti - +7,8%, arrivando così a 2.830.000 di passeggeri - si sia registrato un drastico taglio dei treni per i pendolari (si va dal 10% della Campania al 20% del Veneto) e, parallelamente, un aumento del costo del trasporto che, nel 2012, è destinato a crescere ulteriormente. Come a dire: “Non avete i soldi per pagare il biglietto di un Frecciarossa o un Frecciargento? Beh, arrangiatevi!”
Usando uno slogan, forma particolarmente amata dai press agents di Trenitalia, peggiora il servizio e aumentano i costi: in uno dei suoi ultimi report Legambiente denuncia infatti come, a fronte di un sensibile aumento degli utenti - +7,8%, arrivando così a 2.830.000 di passeggeri - si sia registrato un drastico taglio dei treni per i pendolari (si va dal 10% della Campania al 20% del Veneto) e, parallelamente, un aumento del costo del trasporto che, nel 2012, è destinato a crescere ulteriormente. Come a dire: “Non avete i soldi per pagare il biglietto di un Frecciarossa o un Frecciargento? Beh, arrangiatevi!”
E pensare che se non ci fossero i contributi dei cittadini a mantenerle, le Ferrovie dello Stato sarebbero peggio di un colabrodo: stando ai conti de Il Sole 24 Ore l'anno scorso il bilancio economico delle FS ha beneficiato di risorse pubbliche per la bellezza di 3.531 milioni di euro. Le risorse pubbliche che affluiscono nelle casse delle Ferrovie sono infatti composte da due grandi voci: la prima, per un totale di 2.493 milioni nel 2010, consiste nei corrispettivi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per contratti di servizio - di cui 1.947 milioni sono i ricavi elargiti Regioni, obbligate ad affidare kilometri di chemin de fer senza gara e alle condizioni di Trenitalia - mentre la seconda voce, pari a 1.038 milioni nel 2010, deriva da corrispettivi dello Stato per contratti di programma.
Inoltre le FS hanno ricevuto altri fondi dal Governo: 1.814 milioni di contributi in conto capitale per gli investimenti, che sono pari a 4.074 milioni. Una beneficenza da quasi 6 miliardi di euro che dunque viene del tutto disattesa in termini di servizi al cittadino/contribuente.
Eppure per far quadrare i conti c'è ancora bisogno di tagliare, di eliminare tratte e ridimensionare l'organico. L'ultima mossa in ordine di tempo è stata quella di sopprimere i treni notte e di lasciare a casa gli 800 ferrovieri che li scortavano e li accudivano nei loro tragitti. Tra questi anche la versione nostrana del mitico Orient Express - il treno protagonista dei racconti di Agatha Christie, Ian Fleming e Graham Greene - che da Venezia arrivava a Budapest passando per Belgrado; a dimostrazione che per Moretti la storia, vuoi quella personale dei suoi sottoposti, vuoi quella culturale e a volte mitica di determinate tratte, non conta nulla di fronte ai numeri.
 Così come non valgono nulla le proteste dei tantissimi cittadini che dalla Val Susa a Firenze della Tav non ne vogliono proprio sapere. Che, come i parenti delle vittime della strage di Viareggio, vogliono delle risposte. Che come i 10000 ferrovieri licenziati rivogliono il loro posto di lavoro. O che, semplicemente, chiedono di essere trattati in modo dignitoso a fronte del pagamento (a carissimo prezzo) di un sedicente servizio pubblico. Dei “fessi” secondo Moretti, che non avendo una laurea in ingegneria ferroviaria come lui, non hanno diritto di metterci bocca in merito.
Così come non valgono nulla le proteste dei tantissimi cittadini che dalla Val Susa a Firenze della Tav non ne vogliono proprio sapere. Che, come i parenti delle vittime della strage di Viareggio, vogliono delle risposte. Che come i 10000 ferrovieri licenziati rivogliono il loro posto di lavoro. O che, semplicemente, chiedono di essere trattati in modo dignitoso a fronte del pagamento (a carissimo prezzo) di un sedicente servizio pubblico. Dei “fessi” secondo Moretti, che non avendo una laurea in ingegneria ferroviaria come lui, non hanno diritto di metterci bocca in merito.
Quella dell'ingegnere può quindi essere considerata una gestione cilena dell'apparato ferroviario, a maggior ragione se si tiene conto che lo Stato - inteso come proprietario e come rappresentanza politica - ha avallato ogni sua decisione, dandogli carta bianca in nome del pareggio di bilancio. In quest'ottica Moretti non può non rappresentare il prototipo del “tecnico” che ora, nostro malgrado, ci ritroviamo al Governo: un personaggio che, dimentico della sua funzione di servitore dello Stato, impone sacrifici e malversazioni ai cittadini col solo scopo di fare cassa. Ma d'altronde il suo stipendio da 886.478 euro l'anno qualcuno lo dovrà pur pagare.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
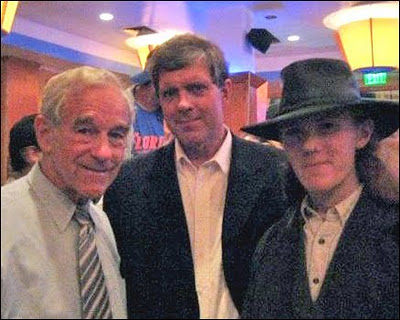 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Uno spaccato agghiacciante è quello che viene fuori dalla pubblicazione di una lista di italiani “sgraditi” sul forum neonazista “Stormfront”. Il sito italiano s’ispira alle “idee” (si fa per dire) di tale Don Black, che, a dispetto del suo nome tutt’altro che bianco, è un ex “grande drago” del Ku Klux Klan, nonché accalorato sostenitore della “causa” della supremazia bianca negli Stati Uniti. Ironia della sorte, la sua ex moglie, che l’ha mantenuto per il periodo in cui era disoccupato, si batte per i diritti dei neri e degli ispanici americani (quando si dice il contrappasso!) Un utente del sito italiano, nickname “Costantino”, lancia la sua sfida online sostenendo di essere arrabbiato più con coloro che “aiutano gli “allogeni” [letteralmente, “nati altrove”] e ne traggono un tornaconto economico”, che con gli stranieri stessi.
In effetti, il ragionamento, dal punto di vista dell’infermità mentale che lo ha fatto proprio, è coerente: gli stranieri sono Untermensch, subumani, che pertanto non meritano nemmeno l’odio. Oggetto invece di un odio acre, virulento, sono indistintamente tutti coloro che, in un paese mediocre e confuso, si ostinano a considerare gli stranieri per quello che sono, ovvero esseri umani, per inciso titolari di un complesso di diritti e doveri al pari degli “ariani”: ovvero giornalisti, giudici, politici di ogni colore politico, sociologi, preti e volontari, tutti accomunati dal fatto di essere dei “coccolanegri”.
Agli occhi dei suprematisti bianchi “de noantri”, che usano il logo americano - una croce celtica bianca su fondo nero decorata con le parole White Pride World Wide (Orgoglio Bianco nel Mondo) - ad esempio, l’assessore della Regione Toscana Stella Targetti, che si è messa nei guai per il suo eccesso di idealismo: non è piaciuto agli amanti delle svastiche le sue dichiarazioni in cui sosteneva di volere una scuola “dove nessuno sia ‘straniero’”. Tanto è bastato per essere insignita dell’oscena minaccia in rima “bastarda immigrazionista, sei nella lista”.
Non parliamo di Gad Lerner (che già parte svantaggiato per la sua origine ebraica): “Costantino” e i suoi sodali non hanno gradito lo stile di conduzione della sua trasmissione sui crimini razzisti di cui si è macchiato il “camerata” Casseri. Laura Longo, il pm di Torino incaricato delle indagini sul rogo Campo Rom di Continassa a Torino, ha avuto l’ardire di contestare ai criminali che hanno dato fuoco al campo Rom di Cascina Continassa l’aggravante dell’odio razziale, che dovrebbe valere ai due un sostanzioso aggravio di pena.
A proposito di ebrei, Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma, è stato messo sulla lista dei cosiddetti “italiani delinquenti” per aver “dato non pochi guai ai fratelli di Militia”, l’associazione neofascista che annovera tra i suoi iscritti due persone, arrestate il 14 dicembre a Roma per aver progettato attentati con ordigni esplosivi che avrebbero dovuto colpire, oltre a Pacifici, un certo numero di politici (Alemanno, Schifani, Fini e George Bush).
 I suprematisti bianchi non sopportano poi l’insistenza con cui Pacifici lamenta la circostanza (effettivamente incresciosa) che in Italia ancora non esista una legge “contro i negazionisti dell'Olominchiata”. Il gup Carlo Fontanazza di Lamezia Terme è stato schedato per aver “chiesto e ottenuto la riduzione all'assassino marocchino che sotto gli effetti della droga ha travolto e ucciso 8 persone”. Anche Luca Gibillini, Mirko Mazzali e Anita Sonego, esponenti di SEL di Milano e il sindaco di Reggio Emilia Graziano Del Rio sono nella lista nera. Del Rio, in particolare c’è finito per aver espresso il suo favore ad una legge che riconosca la cittadinanza ai figli degli immigrati.
I suprematisti bianchi non sopportano poi l’insistenza con cui Pacifici lamenta la circostanza (effettivamente incresciosa) che in Italia ancora non esista una legge “contro i negazionisti dell'Olominchiata”. Il gup Carlo Fontanazza di Lamezia Terme è stato schedato per aver “chiesto e ottenuto la riduzione all'assassino marocchino che sotto gli effetti della droga ha travolto e ucciso 8 persone”. Anche Luca Gibillini, Mirko Mazzali e Anita Sonego, esponenti di SEL di Milano e il sindaco di Reggio Emilia Graziano Del Rio sono nella lista nera. Del Rio, in particolare c’è finito per aver espresso il suo favore ad una legge che riconosca la cittadinanza ai figli degli immigrati.
“Costantino” ha un modo tutto suo, forse non particolarmente articolato ma di certo orripilante, di esprimere la sua netta contrarietà a questo civilissimo principio fatto proprio da Del Rio e recentemente ventilato anche dal noto “estremista” Napolitano, Presidente della Repubblica (che dovrebbe essere) antifascista: gli immigrati e Del Rio, par di capire, sarebbero “gente di merda, meritebbero una pallottola in quelle loro teste di merda”, altro che cittadinanza! “Protesilao”, un compagno di deliri di “Costantino”, ci mette del suo: “Segnamoci il nome, Graziano Delrio, un nostro nemico”.
Qui non si tratta di lotta di idee, per quanto folli ed esecrabili, ma di reati veri e propri: da quello, scontato e molto tollerato di apologia di fascismo, alle minacce vere e proprie. Pur essendo fortemente scettici nei confronti di ogni forma di censura di stato, anticamera della fine della libertà di espressione e di pensiero, il caso Stormfront è talmente grave che occorre riconoscere che non è inappropriata la richiesta di oscuramento del sito proposta da tre delle vittime della schedatura neonazista, tutti volontari della ONG antirazzista EveryOne.
Forse il contributo più brillante è quello di Aurelio Mancuso, capo di Equality, “rete trasversale per i diritti civili”, il quale crede che “non sia sufficiente chiedere la chiusura del sito di questi neonazisti nostrani. C'è bisogno di una potente rieducazione culturale: una volta individuati gli autori e processati per crimini d'odio, la pena preveda l'affidamento alle persone menzionate nella black list, così che possano far provare a questi spavaldi giovanotti ciò che vuol dire impegnarsi nei confronti dei diritti delle persone migranti”. Sogno di un visionario? Forse. Ma, è bello essere dei sognatori; e ancora meglio rendersi conto che, come avrebbe detto Lennon, non siamo i soli ad esserlo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
E’ anche grazie alla pubblicazione dell’articolo uscito sul Corriere della Sera che la storia di Luca, dopo molti anni, torna a fare il giro del web. Assurda nel suo epilogo e carica di domande senza risposte. Prima di tutto quelle delle indagini giudiziarie, trasformatesi in un giallo e ora prossime alla prescrizione. E’ il 7 febbraio del 2002 quando a soli 7 anni Luca, nel piccolo paese della Svizzera francese dove vive con la sua famiglia, Veysonnaz,viene ritrovato privo di sensi sulla neve gelida, nudo e malmenato.
Evidenti segni sulle natiche fanno pensare a delle frustate. Luca picchiato e seviziato da altri ragazzi più grandi, come un disegno del piccolo fratellino lascia intuire. Le fonti ufficiali parleranno invece di un cane assassino cui una giustizia evidentemente deviata e incredibile ha attribuito la capacità di denudare un bambino senza ridurre in brandelli gli indumenti.
Oggi Luca vive su una sedia a rotelle, ha conquistato dei miglioramenti nell’attività deambulatoria, ma non vede e la sua vita è diventata quella di un ragazzo con forti disabilità. A tutto questo l’ha portato un coma profondo durato tre mesi, dovuto alle botte e all’ipotermia che lo ha lasciato a un passo dalla morte. La famiglia però, e questo non è un dato meno importante del percorso di terapie e di sperimentazioni che affronta per il futuro di Luca, ha la certezza che non sia stato fatto il possibile per coprire i responsabili, pur non avendo in mano i nomi degli assassini,.
Un caso che assomiglia alla saga di Elisa Claps, con l’unica differenza grande che qui il sopravvissuto scampato all’assassinio parla di “ladri”, di “ragazzi che l’hanno spinto giù”, che lo obbligavano a “mangiare formiche”. Luca ricorda i nomi e i volti dei suoi aggressori: un ragazzino di 16 anni, uno di 14, uno di 9: tutti figli di famiglie perbene e facoltose. La difesa dimostrò che i ragazzi si trovavano a scuola, ma pare che neppure i registri di classe furono risparmiati alla contraffazione.
 Tutto per coprire le sevizie ludiche e spietate che Luca ha pagato in nome del razzismo o di un banale gioco al massacro di ricchi annoiati, senza ragioni particolari. Nonostante le indagini siano state riaperte, nulla nella scacchiera delle responsabilità è cambiato, perché un bambino come Luca non è nei fatti considerato un testimone attendibile. E’ così che Luca è stato lasciato due volte a terra, due volte è stato battuto dal freddo e dalla violenza, nel più composto silenzio della più ordinata Svizzera.
Tutto per coprire le sevizie ludiche e spietate che Luca ha pagato in nome del razzismo o di un banale gioco al massacro di ricchi annoiati, senza ragioni particolari. Nonostante le indagini siano state riaperte, nulla nella scacchiera delle responsabilità è cambiato, perché un bambino come Luca non è nei fatti considerato un testimone attendibile. E’ così che Luca è stato lasciato due volte a terra, due volte è stato battuto dal freddo e dalla violenza, nel più composto silenzio della più ordinata Svizzera.
Già al tempo dei fatti poco arrivò sulla stampa italiana, colpevole forse il fatto che Luca fosse un italiano oltre i confini nazionali e che la verità non dovesse essere al centro delle parole. La quasi certezza che il bambino non sarebbe sopravvissuto a quei traumi e ai 28° con cui era arrivato in ospedale - appoggiato sul ventre della madre - dovevano chiudere il cerchio delle alleanze omertose e della rassegnazione. Come le ossa di Elisa Claps nel sottotetto della Chiesa.
Eppure persino qui la verità è comunque arrivata. E nel caso di Luca che può parlare, ricordare, testimoniare, forse potrebbe e dovrebbe arrivare anche prima. Se solo la storia tornasse a infastidire i protagonisti, a ribaltare il tavolo delle carte lasciate a muffire, se solo la stampa accendesse la luce ai piedi di quel gruppetto di violenti o, meglio ancora, delle loro famiglie, potremmo capire a che razza appartengono dei cani che sbranano gratis un innocente e quella, non meno peggiore, di chi li protegge. Perché tanto Luca è rimasto al buio.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Un po' di sano romanticismo per cacciar via i brutti pensieri. Ale e Fede hanno passato così il pomeriggio, discorrendo amabilmente su Ponte Milvio, cullati dal frusciare del biondo Tevere. E alla fine ce l'hanno fatta: hanno risolto i loro problemi. Non parliamo della crisi di coppia fra due pariolini di quindici anni, ma dell'ultima spinosa questione che il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha brillantemente risolto. I temibili lucchetti dell'amore. Roba da affrontare con il piglio e la risolutezza che si confanno a un ex dell'Msi.
Tutto cominciò qualche anno fa, quando l'autore di bestseller puberali Federico Moccia scrisse l'opera che lo rese immortale, "Tre metri sopra il cielo". Dal volume fu tratto un film di culto e l'eco che ne derivò spinse migliaia di coppiette alla melensa emulazione dei graziosi protagonisti: agganciare un lucchetto al parapetto del ponte romano in segno d'amore perpetuo. Solo che, lucchetta tu che lucchetto anch'io, i pegni sentimentali si sono trasformati in un'orrida selva ferrosa, deturpando oscenamente un monumento del secondo secolo dopo cristo. Insomma, una bella grana amministrativa per Gianni. Ma soprattutto elettorale.
Preoccupatissimo di non turbare la sensibilità delle anime gemelle, il sindaco ha pensato bene di chiamare in causa Moccia in persona. In fondo detiene lui il copyright. A chi gli faceva notare che non dovrebbe essere necessario interpellare Fede per rimuovere i lucchetti, Ale ha risposto in tono rassicurante: "Gli chiederò se ha qualche idea, una delle sue suggestive, per un'alternativa".
Non si sa bene chi l'abbia avuta, ma alla fine l'idea suggestiva è arrivata: i lucchetti saranno spostati sull'argine del Tevere. Ora, chiunque conosca un po' il fiume romano sa che le sue sponde non sono proprio il massimo del romanticismo: muraglioni di cemento, sporcizia, qualche topo mutante. E allora un'altra lampadina s'è accesa nella testa di Gianni: "Il municipio preparerà un progetto... Metteremo un parapetto e transenneremo l'area, dei lampioni...". Insomma, "sarà una cosa bella". Possiamo stare tranquilli.
Tanto più che il piano ha ricevuto perfino il placet più importante, quello letterario: "Bisogna trovare un compromesso tra decoro del ponte - ha concesso un illuminato Moccia - e questo romanticismo che, da cinque anni a questa parte, ha reso ponte Milvio il ponte degli innamorati".
 Certo, a prescindere dalla soluzione scelta, l'imposizione burocratica rischia di spoetizzare un tantino il significato del gesto amoroso, che di norma dovrebbe sgorgare impetuoso dal cuore, piuttosto che dalla segreteria del Campidoglio.
Certo, a prescindere dalla soluzione scelta, l'imposizione burocratica rischia di spoetizzare un tantino il significato del gesto amoroso, che di norma dovrebbe sgorgare impetuoso dal cuore, piuttosto che dalla segreteria del Campidoglio.
Per questo è verosimile ipotizzare che qualche allegro figlio di Cupido, pur di non sottostare al diktat che impone di scendere le scalette del fiume, sceglierà di sfidare la Polizia Municipale e allacciare con tracotanza il suo lucchetto nel posto che gli compete.
Ma questo è un problema che il sindaco si porrà a tempo debito, magari facendo ricorso ancora una volta ai preziosi consigli di Fede. Per il momento si torna alla grigia quotidianità. Appena ieri Gianni è stato ascoltato come persona informata sui fatti dal pm di Milano Ilda Boccassini. Il colloquio è avvenuto nell'ambito dell'indagine che nei giorni scorsi ha portato all'arresto del presunto boss della 'ndrangheta Giulio Lampada e del consigliere regionale calabrese Franco Morelli (Pdl). Rimane poi da chiarire la vicenda dei due proiettili calibro 40 inviati per posta alla segreteria del primo cittadino.
Intanto Roma sta per chiudere una delle annate più sanguinose della sua storia recente, con oltre trenta omicidi in appena undici mesi. Ma non ci pensiamo, richiamo di intristirci, di lasciarci sfuggire la magia del momento. Come diceva il poeta? Ah, sì: "L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio".
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Scempiaggini di estrema destra condite con le solite teorie cospirazioniste antisemite, magia, occultismo: questo è il brodo di coltura in cui nel quale è maturato il demenziale click che ha trasformato il ragioniere cinquantenne Gianluca Casseri in un serial killer. Armato di una Smith & Wesson calibro 357, in pieno giorno, nel centro di Firenze, ha sparato a distanza ravvicinata a tre venditori ambulanti senegalesi uccidendone sul colpo due e ferendone gravemente un terzo.
Non contento - e a dispetto di una segnalazione alla polizia comprendente, pare, perfino una foto dell’assassino e della sua automobile - nel primo pomeriggio si è recato in un altro mercato cittadino, dove ha nuovamente fatto fuoco su altri venditori senegalesi ferendone altri quattro. Ormai accerchiato da agenti della forza pubblica, che hanno esploso un paio di colpi contro la sua automobile senza colpirlo, Casseri termina la sua agghiacciante “giornata di ordinaria follia” rivolgendo l’arma contro di sé e uccidendosi.
Casseri era certamente un simpatizzante di estrema destra, a dispetto della presa di distanza da parte del responsabile del circolo Casapound Circolo Agogè di Pistoia, il quale ammette con Nadia Francalacci di Panorama: “Frequentava il nostro circolo, ma raramente”. Il fatto che prima di quel maledetto 13 dicembre del 2011 non avesse manifestato una condotta violenta non deve trarre in inganno: purtroppo il veleno che scorreva nelle sue vene era di un tipo più tossico, anche se meno evidente.
 Più eloquente di tante altre fonti, forse, è l’autoritratto che Casseri ha stilato anni fa, in terza persona: “Nasce a Ciriegio (PT) nel 1961, mentre l’uomo va nello spazio e il cielo si eclissa per la massima eclissi del XX secolo. All’età di dodici anni, folgorato dall’incontro con H.P. Lovecraft, si aliena definitivamente dal cosmo ordinato che ci circonda”. Pur dietro il paludamento dell’autoironia, con queste parole il killer di Firenze dischiude una passione millenaristica ed un netto, quanto fiero, distacco dalla realtà. Tra le frequentazioni culturali di Casseri non a caso figura, accanto a fumetti e fantascienza, un personaggio assai inquietante come Julius Evola.
Più eloquente di tante altre fonti, forse, è l’autoritratto che Casseri ha stilato anni fa, in terza persona: “Nasce a Ciriegio (PT) nel 1961, mentre l’uomo va nello spazio e il cielo si eclissa per la massima eclissi del XX secolo. All’età di dodici anni, folgorato dall’incontro con H.P. Lovecraft, si aliena definitivamente dal cosmo ordinato che ci circonda”. Pur dietro il paludamento dell’autoironia, con queste parole il killer di Firenze dischiude una passione millenaristica ed un netto, quanto fiero, distacco dalla realtà. Tra le frequentazioni culturali di Casseri non a caso figura, accanto a fumetti e fantascienza, un personaggio assai inquietante come Julius Evola.
Il nome di Evola ricorre infatti tra le fonti citate da Casseri in un suo scritto facilmente reperibile in Rete: “I documenti del saggio di Alessandria”. Lo si può leggere in un oscuro sito negazionista cui per ovvie ragioni si preferisce omettere il nome e che, una volta frequentato, fa venir una voglia compulsiva di lavarsi le mani. Il saggio di Casseri è stato prudentemente rimosso anche dal sito del "Centro Studi La Runa". Il suddetto centro studi, per inciso, ha un oggetto sociale che è tutto un programma, dato che “si occupa di studi tradizionali, storia delle religioni, mitologia, simbolismo, folklore, indoeuropeistica, storia, filosofia, letteratura”.
Sul sito web di "La Runa" sono reperibili anche numerosi articoli di Gianfranco de Turris, che oltre giornalista radiofonico RAI di lungo corso ed esperto di letteratura fantascientifica è stato per molti anni presidente, e successivamente segretario, della Fondazione Julius Evola; de Turris, tra l’altro, ha curato la prefazione del libro di fiction scritto a quattro mani da Casseri con Enrico Rulli, dal titolo che oggi appare beffardo: “La chiave del caos”.
Tema principale del pamphlet di Casseri sui Protocolli dei Savi di Sion è la polemica contro “Il Cimitero di Praga” di Umberto Eco (di qui il titolo dello scritto, dedicato al “saggio” di Alessandria, città natale del semiologo). Lasciando da parte un paio di allusioni ad episodi comuni tra il libro di Eco e quello di Casseri, che sembrano garbatamente alludere ad un possibile plagio, la conclusione dello scritto può essere riassunta, usando le parole stesse dell’autore: “Vorrei osservare come fin dagli anni '30 un attento lettore dei Protocolli dei Saggi di Sion riscontrasse che “il problema della loro ‘autenticità’ è secondario e da sostituirsi con quello, ben più serio ed essenziale, della loro ‘veridicità’.” Ora, a prescindere dalla assai discutibile razionalità dell’assunto, anche solo dal punto di vista logico, vogliamo provare ad indovinare chi è l’ “attento lettore” citato da Casseri? Proprio lui, sì, Julius Evola!
 Alla condotta di Casseri solo la psichiatria può tentare di dare una spiegazione “coerente”: ci prova su La Nazione di Firenze lo psichiatra Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, dando una dimensione scientifica ad un fatto purtroppo comprovato dall’esperienza diretta (si veda ad esempio il caso del serial killer norvegese Breivik): “Spesso i soggetti che “esplodono” in episodi di violenza cieca come quella vista ieri a Firenze “sono persone che vivono al limite, magari con condotte un po’ bizzarre, [inclini a] misticismo, magia, esoterismo, destra neofascista, [dotate insomma di] una componente irrazionale che però nascondono nella loro vita quotidiana, apparentemente normale e banale.”
Alla condotta di Casseri solo la psichiatria può tentare di dare una spiegazione “coerente”: ci prova su La Nazione di Firenze lo psichiatra Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, dando una dimensione scientifica ad un fatto purtroppo comprovato dall’esperienza diretta (si veda ad esempio il caso del serial killer norvegese Breivik): “Spesso i soggetti che “esplodono” in episodi di violenza cieca come quella vista ieri a Firenze “sono persone che vivono al limite, magari con condotte un po’ bizzarre, [inclini a] misticismo, magia, esoterismo, destra neofascista, [dotate insomma di] una componente irrazionale che però nascondono nella loro vita quotidiana, apparentemente normale e banale.”
Secondo Pallanti, è “normale per questi soggetti appoggiarsi a tesi politiche di estrema destra, ma non la destra normale, intendo quella neonazista, pagana, celtica, ariana, quella che compensa una ridotta volontà di ragionare e una tendenza a essere soggetto alla autorità proprie di queste personalità patologiche”. Il tipo di “idee” propugnate per esempio da Julius Evola, la cui biografia, come ricorda Mauro Baudino su La Stampa, è stato un coacervo di contraddizioni: “Prima dadaista poi antisemita, nazista, neopagano, antimoderno e ispiratore dei giovani di estrema destra”; un cattivo maestro, ma talmente cattivo che appaiono appropriate le parole con cui lo dipinse lo storico Furio Jesi, un filosofo “così sporco che ripugna toccarlo con le dita”. E che dalla tomba continua a fare danni.
