- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Il predicatore radicale islamico Omar Bakri è di nuovo libero; condannato in primo grado all'ergastolo, è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di cinque milioni di lire libanesi, circa 3.300 dollari. L’ordinanza di scarcerazione è stata firmata dallo stesso tribunale militare di Beirut che il 12 novembre scorso, dopo un processo durato tre anni, lo aveva condannato insieme ad una quarantina di radicali islamici, per possesso illegale di armi ed esplosivi, furto e “appartenenza ad un gruppo armato che avrebbe avuto come obiettivo l’esecuzione di atti terroristici e l’assassinio di soldati libanesi”.
La Corte ha accettato l’istanza presentata dall’avvocato Nawwar al-Sahili, rappresentante di Hezbollah in Parlamento e incaricato dallo stesso Sheikh Hassan Nasrallah di difendere Bakri nel processo di appello. Dopo il verdetto di condanna il predicatore sunnita aveva invocato il leader sciita libanese chiedendo un intervento in suo favore: «Esorto Seyyed Hassan Nasrallah affinché guardi all’ingiustizia che sta subendo Omar Bakri che sostiene tutta la resistenza contro Israele». Solo pochi giorni prima Bakri aveva dichiarato ai media che non avrebbe fatto «un solo giorno di prigione».
Nato nel 1956 in Siria, Omar Bakri Fostock ha vissuto per oltre vent’anni in Gran Bretagna dove, grazie ai suoi sermoni antioccidentali, è diventato una delle figure di punta dell’islamismo radicale europeo. Sono “famosi” i suoi elogi agli attacchi dell’11 settembre 2001 e al gruppo di kamikaze che portò a termine quelle stragi e che lui stesso ha definito i “magnifici 19”. Oltre ad aver militato nelle fila dei Fratelli musulmani, ha fatto parte del movimento islamico Takfir wal-Hijra, nato in Egitto intorno agli anni Sessanta ed oggi presente in numero Paesi, compresa la Spagna dove è conosciuto con il nome di Martiri per il Marocco, e dell’organizzazione politica Hizb ut Tahrir, formazione pan-islamica fondata nel 1953 a Gerusalemme. L’organizzazione è famosa anche per aver annoverato tra le sue fila personaggi del terrorismo internazionale quali Khalid Sheik Mohammad, reo confesso d’essere stato la mente organizzatrice negli attentati dell’11 settembre e Abu Musab Al-Zarqawi, capo di al-Qaeda in Iraq ucciso nel 2006.
Originario di Aleppo, Bakri lascia la Siria nel 1977, quando a Damasco sta scoppiando l’insurrezione armata dei Fratelli musulmani contro il regime di Hafez al-Assad. Ricercato dalla polizia per aver aderito dai Fratelli musulmani, si trasferisce in Libano, dove inizia gli studi sulla Sharia e diventa membro del movimento semiclandestino Hizb ut Tahrir; nel 1979 approda al Cairo, dove rimane circa sei mesi prima di spostarsi in Arabia Saudita. A Riyadh affianca allo studio religioso la militanza politica e nonostante il divieto delle autorità, nel 1983, con altri 38 militanti, fonda la formazione radicale Al-Muhajiroun.
 L’anno successivo, a Jeddah, finisce nel mirino della giustizia e viene arrestato, ma ottiene subito la libertà provvisoria; nel dicembre 1985 viene nuovamente fermato e di nuovo rilasciato. Il 14 gennaio 1986 parte per l’Europa e si stabilisce in Gran Bretagna, dove diventa uno dei referenti di Hizb al-Tahrir; dieci anni dopo, per disaccordi con la dirigenza del movimento, chiude ogni rapporto con la formazione islamica e riprende il percorso iniziato in Arabia Saudita fondando una propria scuola chiamata Al-Muhajiroun, un “centro culturale” situato in un sobborgo di Londra.
L’anno successivo, a Jeddah, finisce nel mirino della giustizia e viene arrestato, ma ottiene subito la libertà provvisoria; nel dicembre 1985 viene nuovamente fermato e di nuovo rilasciato. Il 14 gennaio 1986 parte per l’Europa e si stabilisce in Gran Bretagna, dove diventa uno dei referenti di Hizb al-Tahrir; dieci anni dopo, per disaccordi con la dirigenza del movimento, chiude ogni rapporto con la formazione islamica e riprende il percorso iniziato in Arabia Saudita fondando una propria scuola chiamata Al-Muhajiroun, un “centro culturale” situato in un sobborgo di Londra.
Da molti indicato come uno dei “portavoce” di al Qaeda in Europa, il suo nome assurge agli onori della cronaca solo dopo l’11 settembre, quando elogia pubblicamente gli attentati. Nel 2004 inizia la parabola discendente: Al-Muhajiroun viene dichiarato sciolto e l’anno successivo, all’indomani degli attentati del 7 luglio 2005 contro il sistema di trasporti pubblici della capitale inglese, quando il suo nome viene associato agli autori degli attacchi, Londra gli revoca la cittadinanza britannica. Dopo aver ricevuto dalle autorità l’annuncio del divieto di far ritorno in Gran Bretagna, si trasferisce a Tripoli, dove vive una nutrita comunità sunnita e dove ormai l’influenza siriana è al tramonto.
La liberazione di Omar Bakri desta sicuramente interesse, non tanto per il fattore macroconfessionale, che vede il massimo esponente sciita del Libano venire in soccorso di un radicale sunnita, o per l’ipotesi di legami tra il terrorismo qaedista e il fronte filo-iraniano, quanto per la questione politica e per gli equilibri interni di un Paese nel quale le alleanze possono rivelarsi cruciali, siano esse temporanee che di lunga durata. Il caso Bakri arriva proprio nel momento in cui nel Paese del Cedri si sta consumando una battaglia durissima: la questione sulla legittimità del Tribunale speciale per il Libano, incaricato dalle Nazioni Unite di giudicare i colpevoli dell’attacco terroristico del 14 febbraio 2005 nel quale morì Rafiq Hariri, padre dell’attuale premier.
In attesa che la giustizia renda pubblici i risultati delle indagine anticipati dal report del network canadese Cbc, il Paese vive con il fiato sospeso; diviso tra la necessità di chiudere i conti con il proprio passato e la paura di una nuova guerra civile. Nel luglio scorso il leader del Partito di Dio era stato chiaro: se l’indagine avesse coinvolto qualche membro Hezbollah le conseguenze non si sarebbero fatte attendere.
Una parte degli analisti politici è comunque convinta che se il tribunale dovesse formalizzare delle accuse contro un membro di alto rango del movimento sciita - le incriminazioni dovrebbero essere formalizzate intorno alla metà di dicembre dopodiché si aprirebbe il processo di valutazione giudiziale e dopo circa due mesi potrebbe essere emesso il primo d'arresto - questo non scatenerebbe alcuna reazione. Intanto, in attesa che questo avvenga, Hassan Nasrallah potrebbe aver deciso di giocare il primo tempo di questa partita intorno al destino l’infaticabile Omar Bakri, un “martire” del fronte anti-israeliano per capire con chi sta realmente il Paese.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
BERLINO. Giovedì scorso è stata lanciata una bomba incendiaria rudimentale contro il Centro culturale islamico iraniano di Berlino e Brandeburgo, nel quartiere berlinese di Tempelhof. L’attentato non ha prodotto vittime né feriti, ma la tensione rimane alta, perché negli ultimi sei mesi Berlino è stata testimone di sei azioni criminose nei confronti di luoghi di culto islamici; azioni che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegate fra loro, e quindi organizzate. Non mancano le reazioni dal mondo politico, dove già qualcuno associa gli attentati al dibattito sull’integrazione e sull’immigrazione, tema che sta assorbendo l’attenzione dei tedeschi già da qualche tempo.
La bottiglia contenente il liquido infiammabile è stata lanciata nelle prime ore della mattinata di giovedì. Testimoni, per il momento, non ce ne sono: il luogo di culto islamico si trova alle spalle dell’ex- aeroporto di Tempelhof, in una zona residenziale ormai lontana dal non-stop turistico delle zone centrali della metropoli berlinese. La facciata ha preso subito fuoco, ma l’incendio non ha ferito nessuno: all’interno dell’edificio erano presenti due fedeli che hanno avvisato tempestivamente le forze dell’ordine. La polizia ha spiegato che l’incendio si è spento da sé, lasciandosi dietro soltanto una facciata annerita. Un atto criminoso di bassa entità, in sostanza.
Eppure, Berlino non sembra pronta a lasciar correre, né si dimostra interessata a ridimensionare in alcun modo la faccenda. Perché, a quanto pare, la bomba lanciata contro il Centro culturale di Tempelhof non è un’azione isolata: come si diceva gli inquirenti l’hanno appunto associata ad altri attentati dello stesso tipo avvenuti negli ultimi sei mesi nella capitale tedesca e temono si tratti di una serie di attentati che va oltre il semplice atto vandalico.
Alcuni degli atti criminosi di cui parla la polizia berlinese sono stati compiuti ai danni della moschea Sehitlik, nel quartiere di Neukoelln. Da giugno a novembre la moschea ha subìto ben quattro visite indesiderate, sempre con lo stesso risultato: nessun ferito e fastidiosi danni all’edificio. A fine novembre, inoltre, qualcuno ha cercato di appiccare fuoco alla moschea di Al-Nur, sempre nel quartiere di Neukoelln.
 Un quartiere, tra l’altro, che vanta la percentuale più alta di immigrazione a Berlino e che, proprio grazie all’atmosfera “multikulti” (insieme agli affitti bassi) sta diventando una delle zone preferite dai giovani. Molti scommettono che sarà la nuova Kreuzberg, riferendosi all’aura cool del quartiere più in voga della capitale tedescau
Un quartiere, tra l’altro, che vanta la percentuale più alta di immigrazione a Berlino e che, proprio grazie all’atmosfera “multikulti” (insieme agli affitti bassi) sta diventando una delle zone preferite dai giovani. Molti scommettono che sarà la nuova Kreuzberg, riferendosi all’aura cool del quartiere più in voga della capitale tedescau
Per tutta risposta, ora, le forze dell’ordine berlinesi hanno costituito un gruppo di lavoro speciale che porta avanti le indagini sugli attentati di Tempelhof e Neukoelln. Per il momento non ci sono prove, ha sottolineato la polizia, ma potrebbe trattarsi di una stessa banda criminale: che si tratti di attentatori di estrema destra non è escluso, ma gli inquirenti non hanno voluto commentare. L’ha fatto senza esitazione, invece, l’associazione tedesca “Fermiamo il populismo di destra”, che in serata ha organizzato una manifestazione spontanea in loco per dimostrare la propria solidarietà alla comunità islamica.
Non si sono fatti attendere nemmeno i primi commenti del mondo politico. Klaus Wowereit, il sindaco socialdemocratico di Berlino, si è detto tanto vergognato per l’azione quanto fiducioso nell’azione investigativa delle forze dell’ordine. “La polizia prenderà presto i colpevoli e interromperà questa serie di attentati“, ha commentato Wowereit. Più decisa la reazione di Volker Beck, il rappresentate dei Verdi in Parlamento, che ha inserito la serie criminale contro i luoghi di culto islamici in un contesto molto più ampio e, politicamente parlando, più pericoloso.
Secondo Beck, infatti, alla base degli attentati ci sarebbe il dibattito sull’integrazione esploso la scorsa estate con la pubblicazione del trattato di Thilo Sarrazin contro l’immigrazione, e continuato poi a causa delle reazioni controverse di alcuni politici teutonici. Oltre a Thilo Sarrazin, Beck ha accusato indirettamente la Cancelliera Angela Merkel (CDU) e il bavarese Horst Seehofer (CSU), perché in alcuni loro discorsi avrebbero “messo forfettariamente gli immigrati in relazione con chi rifiuta l’integrazione e con gli islamici anticostituzionali”.
Nessuno mette in dubbio che la prospettiva indicata da Beck sia forse eccessiva, ma la Germania presta comunque un orecchio anche a lui: la propaganda grossolana può fare parecchi danni e non tutti, sembra, sono disposti a sottovalutarli.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
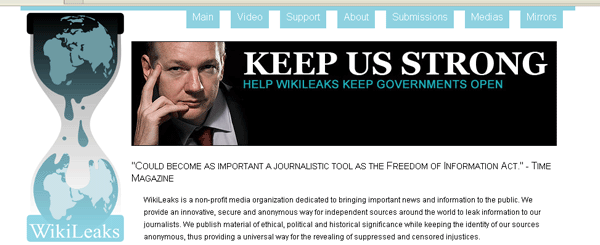 di Mario Braconi
di Mario Braconi
“Posso usare la mia carta di credito per spedire denaro al Ku Klux Klan, ai fanatici antiabortisti, o agli esaltati anti-omosessuali, ma non per finanziare Wikileaks”, così Jeff Jarvis, blogger e professore di giornalismo interattivo presso la City University di New York, sul suo blog. Effettivamente, il delirio scatenato dal “caso Wikileaks” nel mondo politico e degli affari è un’eccellente occasione per un “reality check” sul valore corrente dei diritti negli Stati Uniti (e nel resto del mondo).
E’ certamente discutibile sostenere che il torrente d’informazioni riservate con cui Assange e soci hanno inondato il mondo sia il balsamo salvifico agognato dalle democrazie occidentali per aiutarle ad uscire dalla loro impasse; si tratta infatti di informazioni in gran parte note ed in più sparpagliate senza criterio, né metodo, né apporto critico. Ne è troppo difficile detronizzare Julian Assange dal piedestallo sul quale si è autoinstallato (complice anche la generalizzata sfiducia di ogni popolo nei confronti delle istituzioni che lo dovrebbero rappresentare) e riportarlo ad una dimensione più conforme alla sua vera natura: quella di un uomo simpatico, ma spregiudicato, superficiale nonché vagamente esibizionista.
 Questo non toglie nulla allo spettacolo deplorevole che i politici hanno dato di sé una volta che lo spettro di una possibile “nudità del re” ha cominciato a diventare pericolosamente concreto davanti ai loro occhi (si pensi al patetico Frattini che gioisce a mezzo stampa dell’arresto da operetta di Julian Assange). A proposito del quale, qualcuno dovrebbe ricordare al nostro ministro che il pretesto con cui Assange è stato incastrato nulla ha a che vedere con i presunti reati di violazione di segretezza che tanto lo fanno imbufalire.
Questo non toglie nulla allo spettacolo deplorevole che i politici hanno dato di sé una volta che lo spettro di una possibile “nudità del re” ha cominciato a diventare pericolosamente concreto davanti ai loro occhi (si pensi al patetico Frattini che gioisce a mezzo stampa dell’arresto da operetta di Julian Assange). A proposito del quale, qualcuno dovrebbe ricordare al nostro ministro che il pretesto con cui Assange è stato incastrato nulla ha a che vedere con i presunti reati di violazione di segretezza che tanto lo fanno imbufalire.
Non si sa perché, poi, dato che è noto a tutti, tanto per dirne una, che egli antepone gli interessi commerciali del nostro Paese in Iran al destino di migliaia di dissidenti, mica serve Wikileaks. Si noti, a margine, che é tipico delle dittature far passare un personaggio “scomodo” per pazzo o maniaco e che forse solo il nostro eccellente ministro sembra non ricordarsene, e per questo, irresponsabilmente, gode.
Il tutto senza voler entrare nel merito delle accuse mosse all’attivista australiano: a differenza di quanto si legge in genere, infatti, il capo di accusa per accertare il quale un tribunale svedese lo sta cercando non sarebbe “stupro” ma un generico ed alquanto vago “reato connesso alla condotta sessuale”. Si tratterebbe di comportamenti che perfino nella severissima Svezia sono sanzionati con una multa: a che scopo mettere in mezzo l’Interpol, quindi?
Secondo la ricostruzione del tribunale svedese, infatti, Assange avrebbe avuto rapporti sessuali con due donne in pochi giorni nello scorso agosto e, in entrambi i casi, si sarebbe rifiutato di usare il preservativo e, successivamente, di fornire alle due partner-groupie formale certificazione di non essere affetto da AIDS. Una condotta non commendevole, la sua, forse addirittura irresponsabile, se fosse provato che le sue partner lo avessero invitato specificamente ad adottare misure precauzionali, ma certo ben diversa dallo “stupro” come s’intende comunemente nei paesi diversi dalla Svezia.
Mentre in Italia Frattini squittisce, negli USA ed in Francia ci si dà da fare (anche se in maniera irresponsabile, ma tant’è): basta una telefonata dallo staff del senatore democratico Liebermann (quello del ticket con Al Gore) ed il braccio di Amazon che si occupa di hosting scarica Wikileaks. Improvvisamente si rende conto che non può “pubblicare” materiale di cui non ha proprietà e, sempre improvvisamente, teme che i documenti di Wikileaks possano costituire un pericolo potenziale per le persone coinvolte nei fatti di cui si parla.
Con gran dispetto del censore, la creatura di Assange e soci risorge dopo poche ore con domini molto simili anche se radicati in Germania ed Olanda, mentre i suoi contenuti sono “mirrorati” da centinaia di siti amici: risultato pratico della censura statale, zero e danno di immagine massimo (ammesso che vi sia ancora qualcosa da danneggiare). La Francia filoamericana di Sarkozy non vuol essere da meno e minaccia ritorsioni contro OVH, una delle società su cui si appoggia Wikileaks, con un memo “riservato” a firma del ministro dell’Industria Besson, fatto poi recapitare sulle scrivanie di tutti i caporedattori dei quotidiani francesi.
Dopo aver minato l’onore di Assange (pare che nelle ricerche su Google ormai al suo nome sia regolarmente associata la parola “stupro”), tentato in modo patetico di eliminare i puntelli digitali su cui si regge Wikileaks, non restava altro che tentare di strozzarla finanziariamente, asciugando gli affluenti che ne rendono possibile la vita e le attività: il denaro, che all’organizzazione perviene da contributi volontari veicolati tramite carte di credito o PayPal.
 Entrambe le società (che, come giustamente dice Jarvis, intrattengono proficui rapporti commerciali anche con la feccia umana che spaccia violenza e con ogni specie digital-pappone senza particolari remore moralistiche) realizzano che, facendo pervenire ad Assange e soci i soldi che i suoi amici e simpatizzanti volontariamente decidono di fargli avere, potrebbero in qualche modo trovarsi invischiati in una spiacevole discussione con il Governo USA, che potrebbe mettere in discussione il fervore del loro patriottismo. E così rompono i rapporti con Wikileaks, che d’ora in poi probabilmente dovrà forse tirare avanti con le banconote inviate per posta.
Entrambe le società (che, come giustamente dice Jarvis, intrattengono proficui rapporti commerciali anche con la feccia umana che spaccia violenza e con ogni specie digital-pappone senza particolari remore moralistiche) realizzano che, facendo pervenire ad Assange e soci i soldi che i suoi amici e simpatizzanti volontariamente decidono di fargli avere, potrebbero in qualche modo trovarsi invischiati in una spiacevole discussione con il Governo USA, che potrebbe mettere in discussione il fervore del loro patriottismo. E così rompono i rapporti con Wikileaks, che d’ora in poi probabilmente dovrà forse tirare avanti con le banconote inviate per posta.
Ma questa volta gli amici e i simpatizzanti di Assange non sono rimasti con le mani in mano: mercoledì 8 dicembre il collettivo Anonymous (noto per aver attaccato con successo Scientology e Gene Simmons della rock band Kiss) ha avvitato una massiccia campagna di attacchi informatici ai danni di target percepiti come “nemici” di Wikileaks (o semplicemente ignavi pronti ad allinearsi alla prima bacchettata delle autorità), tra cui Mastercard, PayPal e le Poste Svizzere, che hanno chiuso il conto di Assange con il pretesto che egli ha dichiarato il falso quando ha aperto il conto sostenendo di essere residente nella Confederazione Elvetica.
Secondo il Washington Post, il sito di Mastercard è andato giù, anche se le transazioni con la carta non sono state interrotte. Un membro di Anonymous, sentito dal Post, racconta al quotidiano che nell’organizzazione non sono cambiati i metodi, ma solo il livello di sostegno dei cittadini: tanto che, “con questi numeri, attaccare una blue chip come Mastercard è un obiettivo a portata di mano”.
Del resto, poiché si parla qui di azioni dimostrative che mirano a rallentare un servizio e non a “distruggere una proprietà privata”, di boicottaggio si tratta e non di attacchi informatici portati avanti da criminali o addirittura da governi, come dice Marc Rotenberg, direttore della ONG Electronic Privacy Information Center di Washington in un’intervista allo stesso Washington Post.
In definitiva, finora gli attacchi degli amici di Assange hanno avuto molto più successo di quelli tentati da tutti i governi nei confronti della creatura del trentanovenne australiano: segno che, per nostra fortuna, quando l’arroganza e l’imperizia convivono in modo così perfetto nelle stanze dei bottoni, esiste un limite alla repressione del dissenso.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il patto appena siglato tra la Casa Bianca e il Partito Repubblicano per il prolungamento di altri due anni dei tagli alle tasse introdotti da George W. Bush nel 2001 per tutti i contribuenti americani, sembra aver inferto un colpo mortale ai rapporti tra Barack Obama e la sinistra del Partito Democratico. Lo spostamento sempre più a destra del presidente in questi primi due anni del suo mandato sta sollevando, più in generale, un coro di critiche tra la base del partito e i commentatori liberal. Alcuni di questi ultimi recentemente hanno così prospettato per la prima volta la possibilità concreta, nelle primarie democratiche del 2012, di opporre ad Obama un candidato “di sinistra”, nell’illusione di convincere il partito ad adottare una vera agenda progressista.
L’ennesimo compromesso cui è sceso Obama è stato dettato, a suo dire, dal ricatto messo in atto da un Partito Repubblicano fresco di vittoria nelle elezioni di medio termine dello scorso novembre. Grazie al lavoro del vice-presidente Joe Biden, la Casa Bianca avrebbe ottenuto quanto meno il prolungamento dei sussidi di disoccupazione per tredici mesi e altre modeste misure fiscali a beneficio dei lavoratori a basso reddito. In cambio, i repubblicani si sono assicurati un’estensione dei tagli alle tasse in scadenza a fine anno per tutti i redditi, forzando la mano ad un presidente che intendeva invece confermarli solo per quanti dichiarano entrate non superiori ai 200 mila e ai 250 mila dollari, rispettivamente per single e famiglie.
L’accordo bipartisan aggiungerà qualcosa come 900 miliardi di dollari ad un deficit già colossale e che gli stessi repubblicani continuano ad indicare come l’emergenza principale del paese. Il passaggio al Congresso non è in ogni caso assicurato, dal momento che soprattutto alla Camera dei Rappresentanti numerosi esponenti democratici devono ancora essere convinti della bontà del provvedimento. Anche perché, in un periodo di crisi appare difficile spiegare a milioni di americani in crisi un’iniziativa che destinerà un quarto dei tagli fiscali complessivi all’uno per cento della popolazione in cima alla scala dei redditi. Come se non bastasse, alcune fasce di reddito più basse vedranno addirittura aumentare il loro carico fiscale, mentre l’esenzione dalla tassa di successione (abbassata dal 55 al 35 per cento) è stata alzata da uno a cinque milioni di dollari e il tetto sul carico dei “capital gains” fissato ad un misero quindici per cento.
Proprio la trattativa sui tagli alle tasse pare avere segnato una rottura definitiva tra Obama e la costellazione liberal fatta di editorialisti, società civile e associazioni sindacali più o meno allineati al Partito Democratico. Il disagio sentito da costoro riflette una speranza perennemente frustrata di vedere i democratici adottare prima o poi un programma progressista, o quanto meno battersi per esso. Questa delusione palpabile, ormai ampiamente diffusa negli editoriali dei media cosiddetti di sinistra, nasce in realtà da una vana illusione e dall’incapacità di valutare il Partito Democratico per quello che è: cioè un partito, come quello repubblicano, interamente asservito agli interessi delle élite economico-finanziarie che rappresentano i veri centri del potere negli Stati Uniti come altrove.
 L’auspicio di un’irrealizzabile svolta a sinistra con un candidato dalle credenziali autenticamente progressiste, da proporre per la nomination democratica del 2012, non differisce di molto dall’inutile attesa di molti liberal americani per un Obama finalmente in grado di mantenere la promessa di cambiamento che lo proiettò verso il successo nel 2008. A conferma della natura illusoria delle aspettative che si nutrono a sinistra del Partito Democratico, c’è d’altra parte l’impietosa realtà di questi ultimi anni. Se infatti i democratici non sono stati in grado di lavorare per una società più giusta nonostante la conquista della presidenza e le ampie maggioranze nei due rami del Congresso dopo le elezioni del 2006 e del 2008, è necessario forse cominciare a farsi qualche domanda sulla vera natura del partito.
L’auspicio di un’irrealizzabile svolta a sinistra con un candidato dalle credenziali autenticamente progressiste, da proporre per la nomination democratica del 2012, non differisce di molto dall’inutile attesa di molti liberal americani per un Obama finalmente in grado di mantenere la promessa di cambiamento che lo proiettò verso il successo nel 2008. A conferma della natura illusoria delle aspettative che si nutrono a sinistra del Partito Democratico, c’è d’altra parte l’impietosa realtà di questi ultimi anni. Se infatti i democratici non sono stati in grado di lavorare per una società più giusta nonostante la conquista della presidenza e le ampie maggioranze nei due rami del Congresso dopo le elezioni del 2006 e del 2008, è necessario forse cominciare a farsi qualche domanda sulla vera natura del partito.
Un dubbio questo invece che non inquieta mai una classe di intellettuali liberal che, come lo stesso Partito Democratico, non mette ormai più in discussione un modello sociale ed economico, come quello capitalistico, che negli ultimi tre decenni non ha fatto altro che creare disuguaglianze, precarietà, miseria e guerre, per non parlare della distruzione dell’ambiente e della continua compressione dei diritti civili. A guidare i democratici seduti al Congresso e alla Casa Bianca sono esclusivamente gli interessi di quei poteri forti che finanziano le loro campagne elettorali milionarie e che, allo stesso modo, pagano ricchi stipendi a editorialisti e intellettuali incapaci di far intravedere una visione di società alternativa ad una working-class e ad una classe media sempre più prive di vera rappresentanza politica.
Una dimostrazione esemplare di quest’attitudine della stampa liberal d’oltreoceano si è potuta leggere in alcuni interventi dello scorso fine settimana, a seguito dell’annunciato compromesso sui tagli fiscali. La popolare pubblicazione on-line The Huffington Post ha ospitato, ad esempio, due editoriali di autorevoli commentatori progressisti. Il primo, Robert Kuttner, fondatore e co-direttore della rivista liberal The American Prospect, critica Obama per aver spostato a destra il baricentro della sua amministrazione dopo la batosta di medio termine. La deriva centrista della Casa Bianca appare agli occhi di Kuttner la conseguenza dell’incapacità di Obama di “agire da leader progressista”. Il fallimento che viene attribuito al presidente sembra essere un mero deficit personale e la sua ipotetica sostituzione nelle presidenziali del 2012 dovrebbe perciò bastare a implementare un’agenda progressista.
È poi preoccupazione di Kuttner che Obama possa diventare l’Herbert Hoover democratico, il presidente repubblicano che precedette Roosevelt e la cui eredità principale sarebbe a suo dire l’aver dato vita ad una generazione di egemonia democratica a Washington. Un timore singolare, visto che solo due anni fa l’avvento di Obama veniva salutato dai media liberal come l’alba di un dominio democratico che sarebbe durato per molti anni. Da queste premesse fuorvianti derivano inevitabilmente due proposte illusorie: il rilancio di un movimento di attivisti dal basso che possa galvanizzare un elettorato del tutto sfiduciato e la promozione di un candidato progressista nelle primarie del 2012.
Sullo stesso Huffington Post ha scritto poi Clarence B. Jones, docente a Stanford e già amico e confidente del reverendo Martin Luther King. Anche per Jones il problema è la gestione del potere di Obama e la sua inclinazione personale al compromesso con i repubblicani, dimenticando le aspettative degli elettori. Da qui perciò un altro appello ad una sfida da sinistra nelle primarie democratiche, come accadde nel 1968, quando il senatore del Minnesota Eugene McCarthy si oppose a un Lyndon Johnson che appariva intoccabile e che finì invece per abbandonare la corsa alla presidenza.
La prospettiva di un nuovo trionfo repubblicano di qui a un paio d’anni è infine la premessa per una simile proposta avanzata dal rabbino progressista Michael Lerner, attivista politico e direttore del magazine Tikkun. Dalle colonne del Washington Post, Lerner prevede gli effetti devastanti di un successo repubblicano nel 2012 per l’economia, l’ambiente, la giustizia sociale e il prolungamento del conflitto in Afghanistan, senza rendersi conto che in tutti questi ambiti la situazione è già peggiorata in questi anni, nonostante le affermazioni democratiche del 2006 e del 2008. Per Lerner un candidato democratico alternativo tra due anni non avrebbe alcuna chance di ottenere la nomination ma servirebbe a spostare a sinistra il baricentro di un secondo mandato Obama. Quest’ultimo, infatti, sarebbe pressato da un movimento popolare, la cui mobilitazione appare tuttavia alquanto improbabile, viste le cocenti delusioni seguite alle presidenziali del 2008.
 Abbozzare una lista di possibili candidati da opporre a Obama appare al momento impossibile. Per Matt Bai del New York Times, l’unica personalità in grado di sostenere un tale ruolo sarebbe l’ex segretario del Partito Democratico, Howard Dean. Già governatore del Vermont, Dean non sembra però intenzionato a correre nuovamente per una nomination, soprattutto dopo che il suo tentativo nel 2004 fallì miseramente dopo solo due successi ottenuti nel suo Stato e nel District of Columbia.
Abbozzare una lista di possibili candidati da opporre a Obama appare al momento impossibile. Per Matt Bai del New York Times, l’unica personalità in grado di sostenere un tale ruolo sarebbe l’ex segretario del Partito Democratico, Howard Dean. Già governatore del Vermont, Dean non sembra però intenzionato a correre nuovamente per una nomination, soprattutto dopo che il suo tentativo nel 2004 fallì miseramente dopo solo due successi ottenuti nel suo Stato e nel District of Columbia.
Se Obama dovrà sostenere una battaglia interna al partito in vista delle presidenziali del 2012 è in ogni caso troppo presto da prevedere. Quel che è certo è che un tale scenario non contribuirà a cambiare un sistema paralizzato da un bipartitismo che non permette lo sviluppo di una politica di contrasto ai grandi interessi economici e finanziari. A comprenderlo perfettamente sono quei cittadini americani che hanno rinunciato da tempo a partecipare ad elezioni che servono unicamente a legittimare la linea pro-business di un Partito Democratico che si dichiara paladino di lavoratori e classe media solo in campagna elettorale.
A non volerlo capire ancora è invece un’intellighenzia pseudo-progressista, che non vede alternative di sinistra oltre il Partito Democratico e che appare completamente integrata in un sistema che le assicura posizioni di prestigio e profumati compensi. Non a caso, in tutte le analisi dei commentatori sopra citati non vi è nemmeno l’ombra di un riferimento ad un progetto di riorganizzazione delle forze liberal al di fuori del Partito Democratico, l’unica strada percorribile per rompere una struttura di spartizione del potere che continua ad escludere la grande maggioranza dei cittadini americani.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di mazzetta
di mazzetta
A una settimana dall'esplosione del Cablegate si possono già trarre alcune conclusioni sicure. Prima fra tutte che chi dice che trattarsi di gossip mente sapendo di mentire o avrebbe fatto meglio a leggerne qualcuno prima di scrivere un'enormità del genere. Allo stesso livello di certezza c'è la veridicità del materiale, certificata dagli Stati Uniti che ne piangono la sottrazione.
Altrettanto certo è che Wikileaks non ha commesso alcun reato divulgandoli, come non l'avrebbe commesso un qualsiasi altro media più tradizionale. Altro dato certo è che sul piano penale gli Stati Uniti possono aggredire solo la persona che ha fatto uscire le informazioni e non chi le pubblica, ancora meno se le pubblica all'estero.
Lo dimostra il fatto che nessuna azione è stata intrapresa per fermare le pubblicazioni del The New York Times o degli altri giornali che accompagnano le pubblicazioni con titoli capaci di scuotere i governi di mezzo mondo. Nessun paese ha preso iniziative legali contro Wikileaks, solo il nostro ministro Frattini ha gioito per l'arresto di Assange e solo lui ha invocato la sua incriminazione per reati che non ha commesso o da inventare allo scopo, un'autorevole conferma del fatto che non esista terreno legale per dire che Wikileaks ha commesso un crimine.
L'ostilità verso Wikileaks e il suo portavoce Assange ha quindi il sapore di una vendetta, nulla di legale o democratico, tanto che il governo degli Stati Uniti ha chiaramente aperto una guerra sporca al sito cercando di fargli terra bruciata intorno. Le pressioni sulle aziende che poi hanno negato i loro servizi a Wikileaks sono state testimoniate da chi le ha subite e non hanno nulla di rituale o di democratico. Il fatto che ora queste aziende siano ora sotto attacco da parte di gruppi libertari che abbattono i loro siti come birilli é invece la dimostrazione di una refrattarietà della rete, intesa come ambiente sociale dotato di proprie peculiarità, ai soprusi. Sulla stessa trincea si situa l'apparire di oltre un migliaio di siti che offrono il re-indirizzamento a Wikileaks o una sua copia virtuale e quest’operazione da sola dimostra l'impossibilità di oscurare tecnicamente la diffusione dei documenti.
Un'azione solidale che costituisce un importante contrappeso alle illegalità governative e agli abusi commessi dalle corporation divenute strumento di questa guerra sporca, ma non c'è da gioire se governi e conglomerati finanziari decidono di fare carne di porco dei diritti dei cittadini, nemmeno se poi raccolgono figuracce. Sono azioni di una gravità enorme e testimoniano un grado di complicità che travolge le previsioni normative creando una zona grigia nella quale complicità, illegalità e impunità diventano una sola cosa.
 Nessuna istanza giurisdizionale perseguirà questi comportamenti (e questo è grave) ma sarà difficile trovare qualcuno disposto a perseguire anche gli eventulai crimini svelati in quei messaggi. Basti per tutti la reazione di Luis Moreno Ocampo, il Procuratore capo dell'ICC, il Tribunale Penale Internazionale, che ha già messo le mani avanti dicendo che i cablo non potranno essere usati per accusare gli Stati Uniti, perché si tratta di materiale sottratto illegalmente.
Nessuna istanza giurisdizionale perseguirà questi comportamenti (e questo è grave) ma sarà difficile trovare qualcuno disposto a perseguire anche gli eventulai crimini svelati in quei messaggi. Basti per tutti la reazione di Luis Moreno Ocampo, il Procuratore capo dell'ICC, il Tribunale Penale Internazionale, che ha già messo le mani avanti dicendo che i cablo non potranno essere usati per accusare gli Stati Uniti, perché si tratta di materiale sottratto illegalmente.
Un'aggressione tanto scomposta e sopra le righe, se non altro ha avuto il pregio di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio quale delle due parti in causa sia animata dalle peggiori intenzioni e disposta a giocare sporco per soddisfarle. Se Assange è finito in prigione per un'accusa assurda, lisergica se si scende nel dettaglio, non è servito mentire e indicarlo al mondo come imputato per uno stupro anche se non c'è stato nessuno stupro e non c'è nemmeno alcuna imputazione formale, solo un ordine di comparizione per essere sentito su quel caso.
Al momento appare un'altra mossa controproducente e la detenzione di Assange sembra deporre a suo favore presso le opinioni pubbliche che la percepiscono come ingiusta. Già questo esito dovrebbe sconsigliare un'escalation a colpi di leggi speciali o la sua eliminazione fisica, già auspicata da più di un politico nordamericano, ma ancora non ci sono all'orizzonte segnali che indichino un cambio di rotta.
Gli Stati Uniti stanno sbagliando tutto. Servirebbe una piccola considerazione, che per ora sembra sfuggire solo a loro e ad alcuni rappresentanti delle destre più rozze, come quella italiana: non c'è un solo partito di destra - al di fuori degli Stati Uniti - che possa giustificarne l'ossessivo ingerire negli affari degli altri paesi, fatto che emerge con chiarezza dalla somma dei cablo, quando si arriva al proprio. Il nazional-patriottismo è carne e sangue delle destre (e non solo) e ancora oggi è ovunque un potente ingrediente della formazione del sé politico.
Tanto più che proprio il giudizio delle ambasciate della prima potenza al mondo, sia il semplice riportare quello che appare sulla stampa locale o questioni più delicate, rappresentano ovunque un'opportunità per le lotte politiche locali che ben pochi sono disposti a lasciarsi sfuggire per compiacere Washington.
Il bullismo con il quale Washington sta rispondendo a Wikileaks riecheggia inoltre la stessa protervia con la quale l'amministrazione Bush ha piegato la realtà e le leggi internazionali ai suoi voleri e l'azione di Obama risulta indistinguibile nello stile da quella di Cheney, minando così l'eccezionale successo d'immagine conseguito proprio con l'elezione di Obama e confermando la delusione dell'elettorato progressista americano che del famoso change non ne ha visto l'ombra.
 Se gli Stati Uniti sono ancora quelli tragici di Bush, quelli che hanno portato mezzo mondo alla guerra mentendo e tutto il mondo alla recessione con il fallimento delle truffe finanziarie delle loro banche non regolate, non é pensabile che a destra come a sinistra, al Nord come al Sud, le opinioni pubbliche possano apprezzare l'attivismo di Washington e le attenzioni dedicate ai rispettivi paesi e che sono descritte dai file di Wikileaks.
Se gli Stati Uniti sono ancora quelli tragici di Bush, quelli che hanno portato mezzo mondo alla guerra mentendo e tutto il mondo alla recessione con il fallimento delle truffe finanziarie delle loro banche non regolate, non é pensabile che a destra come a sinistra, al Nord come al Sud, le opinioni pubbliche possano apprezzare l'attivismo di Washington e le attenzioni dedicate ai rispettivi paesi e che sono descritte dai file di Wikileaks.
Il gradimento sarà per di più inversamente proporzionale al crescere del nazional-patriottismo nei diversi soggetti, che tenderanno per questo a identificare gli Stati Uniti non solo nella categoria dei cattivi, ma in alcuni casi li piazzeranno direttamente in quella dei nemici della patria, con l'ovvia conseguenza di minare il genuino entusiasmo con il quale le destre hanno sempre accolto l'attivismo americano in giro per il mondo.
Sarà l'immaturità delle opinioni pubbliche o sarà che i comuni cittadini non ci guadagnano nulla a reggere la parte agli Stati Uniti, la battaglia mediatica contro Wikileaks sembra già persa e bene farebbero gli americani a concentrarsi sul come rimediare al danno, perché a tutti appare chiaro che i primi responsabili di questa ecatombe sono proprio a Washington, dove hanno messo in piede un sistema per la circolazione delle informazioni segrete che si è rivelato un vero e proprio colabrodo.
I prossimi mesi dovranno poi essere impegnati ad ammortizzare l'effetto delle scomode rivelazioni e a lenire gli alleati offesi, paese per paese quando non persona per persona, e ancora non sarà finita, perché non è detto che il danno si possa riparare solo decidendo di rimescolare il personale diplomatico per evitare imbarazzi e mandare la povera Clinton a dire a tutti che sono “il migliore amico degli Stati Uniti”, che è pure un'investitura dal valore in ribasso ultimamente.
Siamo ad appena un migliaio di cablo pubblicati, ma il Golgota del Dipartimento di Stato é lungo duecentocinquanta volte tanto e la battaglia contro Wikileaks è già persa. Meglio impegnarsi per riconquistare rispetto e credibilità internazionale. Eleggere Obama non è stato sufficiente.
