- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Vincenzo Maddaloni
di Vincenzo Maddaloni
Non c’è dubbio che piazza Tahrir, al centro della sommossa del Cairo, sia diventata l’osservatorio privilegiato dei comandanti dei reparti antisommossa delle polizie di tutto il mondo. Esso serve a maturare nuove idee per affinare le tecniche di repressione del dissenso che oggi è pilotato con Twitter, Facebook e con i Bloggers. Naturalmente anche nell’Egitto millenario da un gruppo di giovani borsisti sostenuti e finanziati da Washington. Infatti, come confermava qualche giorno fa Voice of America, (Egypt Rocked by Deadly Anti-Government Protests): «Attivisti del movimento Kifaya (Basta), una coalizione di oppositori del governo, e il Movimento giovanile del “Sei aprile” hanno organizzato le proteste su Facebook, Twitter e sul web».
E’ accertato che Washington da una parte sostiene la dittatura di Mubarak, comprese le sue atrocità, dall’altra parte finanzia i suoi oppositori. Movimenti come Kifaya militano dal 2004 e sono i protagonisti di primo piano delle contestazioni di piazza contro il regime di Mubarak. Kifaya è sostenuto da un fantomatico Centro internazionale che studia “i conflitti non-violenti” con sede negli Stati Uniti. Sempre a un sodalizio statunitense, il “Freedom House” è stato affidato il compito di preparare un gruppo di giovani borsisti egiziani all’uso di Facebook, Twitter e dei blog.
Pare che i risultati siano stati ottimi, almeno secondo “Freedom House” medesimo che spiega: «I borsisti di Freedom House hanno acquisito competenze nella mobilitazione civica, leadership e pianificazione strategica e beneficiano delle opportunità del networking, attraverso l’interazione con diversi sostenitori privati, le organizzazioni internazionali e i media con uffici a Washington. Dopo il ritorno in Egitto, essi hanno ricevuto altre sovvenzioni con l’impegno di destinarle a nuove iniziative di propaganda politica impiegando Facebook e gli Sms».
Naturalmente gli effetti della presenza dei giovani borsisti istruiti da Freedom House si sono visti nelle piazze d’Egitto, prima tra tutte in piazza Tahrir, che è diventata il simbolo della rivolta, ma pure una sorta di tragico laboratorio della violenza e della repressione sul quale si appuntano gli occhi degli addetti ai lavori. Anche perché c’è una curiosità diffusa per le invenzioni strategiche repressive dell’“uomo nuovo” del regime di Hosni Moubarak. Il vice-presidente Omar Suleiman (detto Sliman), tenente-generale delle Forze Armate e dal 1993 responsabile del tristemente noto, Gihaz al-Mukhabarat al-Amma, il temutissimo ed onnipresente servizio segreto militare egiziano che controlla nella pratica pure il GID, (The General Intelligence Directorate) la Direzione Generale dell’Intelligence.
Siccome - è storia nota - Omar Suleiman è tenuto in gran considerazione da Israele, Washington e Londra, fonti bene informate rivelano che costui abbia chiesto agli israeliani di fornirgli mezzi e cecchini per individuare e uccidere tutti coloro che in piazza aizzano la folla. Vero o falso che sia i cecchini comunque ci sono e i morti pure. Più di trecento in due settimane di scontri, quasi come in una battaglia del Novecento. Ma non sono i troppi morti che angustiano gli osservatori, piuttosto le nuove metodologie con le quali i dimostranti si muovono. C’è il timore, che è quasi una certezza, di una globalizzazione degli aggiornamenti su come si possono scansare le manganellate o preparare le folle a rispondere con altrettanta efficacia alle cariche della polizia.
 Infatti, sir Hugh Orde Stephen da più di qualche giorno è entrato in fibrillazione temendo un possibile contagio “maghrebino” delle piazze inglesi. Egli ha partecipato al quotidiano inglese The Guardian tutta la sua preoccupazione guadagnandosi un titolo a tutta pagina. Il suo è un affanno che conta, essendo sir Hugh Orde Stephen, dal settembre del 2009, il presidente dell'Associazione dei capi di polizia dell’Inghilterra, del Galles e dell’Irlanda del Nord. E’, insomma, una sorta di super prefetto, il capo dei capi, uno che conta per il grado che ricopre e per l’intenso curriculum.
Infatti, sir Hugh Orde Stephen da più di qualche giorno è entrato in fibrillazione temendo un possibile contagio “maghrebino” delle piazze inglesi. Egli ha partecipato al quotidiano inglese The Guardian tutta la sua preoccupazione guadagnandosi un titolo a tutta pagina. Il suo è un affanno che conta, essendo sir Hugh Orde Stephen, dal settembre del 2009, il presidente dell'Associazione dei capi di polizia dell’Inghilterra, del Galles e dell’Irlanda del Nord. E’, insomma, una sorta di super prefetto, il capo dei capi, uno che conta per il grado che ricopre e per l’intenso curriculum.
Infatti, dalle pagine del Guardian egli non formula dei suggerimenti, lancia degli avvertimenti che hanno il sapore antico dell’ ukaze. L’obiettivo da raggiungere è una lotta spietata contro gli "hacktivists" che eccitano i dissidenti. “Police could use more extreme tactics on protesters, Sir Hugh Orde warns “, titola il Guardian. Naturalmente sir Orde argomenta delle sue piazze, dei suoi dimostranti inglesi, ma la minaccia che lancia, pesante come un macigno, ha una dimensione universale.
In buona sostanza egli spiega che se i dimostranti affinano le loro tecniche di sovversione, la polizia dovrà per forze di cose reagire ancora più pesantemente. Precisa che l'utilizzo di messaggi su Twitter e Facebook per organizzare campagne di protesta in tempo di record, impone «una nuova revisione totale delle regole per mantenere l'ordine pubblico». Sicché, conclude, l’impiego del kettling diventa ineludibile, benché possa interferire sui «diritti dei cittadini».
In Inghilterra si era ricorsi al kettling, parola che deriva da kettle (letteralmente bollitore per il tè) per sedare, nel dicembre scorso, le dimostrazioni a Trafalgar Square degli studenti universitari. Sperimentata già nella Germania Ovest degli anni Ottanta, e poi rispolverata da qualche anno dalla polizia del Nord Europa - inclusa quella italiana, a Napoli nel 2001 - l’intervento kettle è un modo perverso di reprimere senza lasciare segni sulla pelle dei dimostranti.
In pratica, un intero angolo di piazza o un tratto di strada dove si trovano i manifestanti, viene trasformato in una sorta di recinto blindato da una fitta schiera di uomini delle forze dell’ordine armati di scudi. Essi avanzano e stringono la folla in uno spazio che nella migliore delle soluzioni non è più grande di un campo di calcio. Siccome la tattica non si basa sulla sorpresa, bensì sulla limitazione dello spazio, l’obiettivo è impedire il formarsi di spazi vuoti tra le persone, o vie di fuga. Infatti, coloro i quali tentano di forzare subito il blocco sono colpiti dai manganelli e respinti dentro con gli scudi.
Il 24 novembre scorso, a Londra, seimila tra studenti e persone della società civile che protestavano contro i tagli all’istruzione e all’innalzamento delle tasse universitarie, si ritrovarono nel “bollitore” della polizia, sigillati per ore, senza più la possibilità di sedersi, riposarsi, riscaldarsi. In piedi e pressati. Non soltanto studenti, ma anche donne e bambini. Il Guardian riporta i dialoghi degli assediati estrapolati da un filmato che è diventato una pagina di cronaca agghiacciante di quella giornata (http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/22/kettling-video-appalling-police-watchdog?INTCMP=SRCH).
 Due mesi più tardi, il 27 gennaio, ecco che appare, sempre sul Guardian, il super poliziotto sir Orde. Egli replica sostenendo che l'uso dei cavalli per caricare i manifestanti non è stato «eccessivo», bensì «proporzionato», «molto utile», e la tattica impiegata «efficace». Questo è potuto accadere, denuncia Orde, sebbene l’ordine pubblico in tutto il Regno Unito sia stato messo a rischio dal rifiuto del governo, «di ristrutturare e modernizzare le forze di polizia, costringendoci a confrontarci con la realtà del ventunesimo secolo con una polizia strutturata per il ventesimo. Una disinteresse che s’è rivelato micidiale», ha concluso Orde.
Due mesi più tardi, il 27 gennaio, ecco che appare, sempre sul Guardian, il super poliziotto sir Orde. Egli replica sostenendo che l'uso dei cavalli per caricare i manifestanti non è stato «eccessivo», bensì «proporzionato», «molto utile», e la tattica impiegata «efficace». Questo è potuto accadere, denuncia Orde, sebbene l’ordine pubblico in tutto il Regno Unito sia stato messo a rischio dal rifiuto del governo, «di ristrutturare e modernizzare le forze di polizia, costringendoci a confrontarci con la realtà del ventunesimo secolo con una polizia strutturata per il ventesimo. Una disinteresse che s’è rivelato micidiale», ha concluso Orde.
Non è poi difficile immaginare che sir Hugh Orde sia tra i più attenti osservatori di quanto sta accadendo sulle piazze dell’Egitto che pur sempre rimane per ogni inglese l’ex colonia che consolidò il sogno imperiale della regina Vittoria. E quindi la storia del Paese è seguita con particolare interesse, anche quando le sue forze di polizia anziché adottare la tattica disorganica e imprevedibile della dispersione della folla, ricorrono al kettle, anzi all’iper-kettling, una forma ancora più estrema di contenimento.
Si tenga a mente che sola minaccia di metterla in pratica a Londra ha scatenato in tutto il Regno Unito uno tsunami di polemiche. Nel Maghreb e dintorni, dove si sta giocando la partita geo-strategica globale, gli Stati Uniti stanno cercando di ridisegnare una nuova mappa politica e i diritti civili più elementari o sono del tutto negati o sono calpestati dai regimi corrotti l’iper-kettling è applicato e basta, senza talk show al riguardo.
Dopo tutto la nuova violenza negli scontri che contagia ormai tutte le piazze, rafforza nei paesi ricchi la convinzione sulla necessità di continuare ad investire in difesa e sicurezza pur con la crisi economica che incombe. Anzi, è emerso che alla voce spesa gli aumenti sono sostanziali, grazie soprattutto agli Stati Uniti, il cui cambio d’amministrazione non ha comunque modificato la tendenza. Lo ha scritto il SIPRI che sta per "Stockholm International Peace Research Institute" (Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma), dal 1966 un’autorità in materia.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
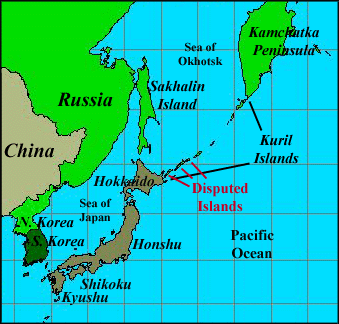 di Carlo Benedetti
di Carlo Benedetti
MOSCA. Le notizie da Tokyo destano preoccupazione nella dirigenza del Cremlino. Annunciano venti di guerra fredda con gli attivisti del movimento giapponese di ultradestra che si mobilitano per chiedere a Mosca la “riconsegna” di quattro isole del Pacifico settentrionale nell’arcipelago delle Curili: Iturun, Sikotan, Hamobaj e Kunasir. Il contenzioso con la Russia data da tempo.
Precisamente dal 1945, quando le truppe sovietiche occuparono l’intero arcipelago tra l'estremità nordorientale della giapponese Hokkaido e la penisola russa della Kamciatka. Si tratta di 60 isole che separano il mare di Ochotsk dal Pacifico settentrionale e sono considerate un avamposto strategico nella regione di Sakhalin.
Ci sono però altri precedenti. Perché la disputa sulle Kurili nasce dalle diverse interpretazioni dei trattati che ne hanno segnato la storia: un Trattato di amicizia del 1875, in cui Mosca riconosce la sovranità del Giappone sull'arcipelago in cambio dell'isola di Sakhalin; poi l'invasione al termine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, con il Trattato di San Francisco che invita il Giappone a rinunciare alle rivendicazioni sulle isole senza però riconoscere la sovranità dell'Urss; quindi le relazioni diplomatiche tra Russia e Giappone si sviluppano nel 1956 con la famosa promessa di Kruscev relativa ad eventuali restituzioni…
Tornando all’attualità va rilevato che si parla di un territorio “multietnico” con la maggioranza schiacciante dei suoi abitanti giunta sin qui, ai confini del mondo, dalle regioni più disparate dell'ex Urss. Secondo l'ultimo censimento (1990), la popolazione è di 710mila persone, distribuite su una superfìcie di 87mila e cento kmq. (all’incirca equivalente a quella dell’Austria). Ovviamente la maggioranza di loro vive a Sakhalin, la cui superficie è di 76mila quattrocento kmq. mentre nelle isole Kurili gli abitanti sono assai pochi: 14 mila a Kunasir, 11 mila a Etorofu (Iturun) e 5 mila e cinquecento a Sikotan.
Tra le 36 etnie che compaiono nel censimento della regione troviamo anche gli estoni (142), gli uzbechi (763), gli armeni (804), gli jakuti (66) e popoli che qui sembrano assolutamente esotici, come gli avari (98), i balkari (43) e gli aguli (14) del Caucaso. E c’è da chiedersi: come saranno finiti qui? Forse alcune risposte vanno trovate in quell’immenso crogiuolo di razze tipico della vecchia Russia alimentato, poi, dalle deportazioni del periodo di Stalin…
I russi, ovviamente, sono la maggioranza - 580 mila, ovvero l’81,6 per cento - seguono gli ucraini 46mila (6,5), i coreani 35 mila (5), i bielorussi 11milaquattrocento (1,6) e i tartari 10milasettecento (1,5). Le popolazioni autoctone, vale a dire soprattutto i nivchi - duemila persone - e gli oroki (ulta) - secondo dati precisi 340 persone - costituiscono oggi meno dello 0,4 per cento della popolazione. Nel 1926, quando iniziò la sovietizzazione, erano il 15,7 per cento dei residenti complessivi (137).
 Nasce in questo contesto la forte e continua richiesta giapponese di annullare l’occupazione e rendere a Tokyo quel che è di Tokyo. E in tutta la vicenda di questo contenzioso geopolitico ci si mise anche l’imprevedibile Krusciov, che nel 1956 promise ai giapponesi che l’Unione Sovietica avrebbe restituito alla loro sovranità due isole. Promessa mai mantenuta, e in ogni caso non sufficiente per il governo di quel paese che ha sempre sostenuto che le isole da restituire sono quattro: Kunasirt, Iturun, Sikotan, Habomaj.
Nasce in questo contesto la forte e continua richiesta giapponese di annullare l’occupazione e rendere a Tokyo quel che è di Tokyo. E in tutta la vicenda di questo contenzioso geopolitico ci si mise anche l’imprevedibile Krusciov, che nel 1956 promise ai giapponesi che l’Unione Sovietica avrebbe restituito alla loro sovranità due isole. Promessa mai mantenuta, e in ogni caso non sufficiente per il governo di quel paese che ha sempre sostenuto che le isole da restituire sono quattro: Kunasirt, Iturun, Sikotan, Habomaj.
Ora Mosca - rispondendo direttamente alla campagna che i giapponesi hanno lanciato per la riconquista di territori, che considerano parte integrante della loro nazione - lancia una nuova campagna per lo sviluppo economico e sociale di tutto l’arcipelago, creando una zona franca, un polo di sviluppo che dovrebbe portare a trovare un delicato equilibrio fra l’indispensabile valorizzazione delle risorse naturali e la diversificazione dell’economia.
Ed ecco che in una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, il presidente Medvedev annuncia che le visite dei funzionari del Cremlino alle isole Kurili dovrebbero aprire questa remota regione della Russia al flusso di investimenti. E ricordando la sua recente missione nell’arcipelago, Medvedev torna a sottolineare i vari aspetti dello sviluppo della regione. Un’area contesa che ancora ostacola la firma di un trattato di pace formale tra i due paesi. Le Kurili controllate dai russi sono infatti, per i giapponesi, "territori settentrionali", occupati dall'Unione Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale.
Medvedev, nel suo viaggio nelle isole contese, ha trascorso tre ore a Kunasir. Ha visitato un asilo, una centrale geotermica, ha promesso investimenti agli abitanti e un'attenzione non inferiore a quella verso le altre regioni più centrali della Russia. Non è stata una visita improvvisa, il presidente russo l'aveva già messa in programma a settembre e già Tokyo aveva avvertito che non l’avrebbe gradita. Così la reazione del governo giapponese è stata immediata, e dura.
Una missione “estremamente deplorevole”, l'ha definita il primo ministro Naoto Kan, mentre in Parlamento il ministro degli Esteri, Seiji Maehara, ha parlato di “totale incompatibilità” con la posizione del Giappone al riguardo: un gesto “che ferisce il nostro sentimento nazionale”. Il ministro degli Esteri ha poi convocato l'ambasciatore russo a Tokyo, Mikhail Belyj, per presentargli formalmente le proteste del suo governo. L'ambasciatore non si è scomposto: la visita di Medvedev a Kunasir è una questione interna, ha commentato.
 Mosca controbatte e una fonte del ministero degli Esteri fa ora sapere che “non comprende la reazione dei giapponesi”, dal momento che la posizione russa sulla questione “non è cambiata”. La sovranità della Russia sulle isole Kurili è, quindi, fuori discussione. Con queste parole Serghej Prikhodko, assistente della presidenza, ha commentato gli ultimi avvenimenti. Il Capo dello Stato nei suoi spostamenti per il Paese - ha detto - non ha bisogno di nessuna approvazione e tanto meno dall’estero.
Mosca controbatte e una fonte del ministero degli Esteri fa ora sapere che “non comprende la reazione dei giapponesi”, dal momento che la posizione russa sulla questione “non è cambiata”. La sovranità della Russia sulle isole Kurili è, quindi, fuori discussione. Con queste parole Serghej Prikhodko, assistente della presidenza, ha commentato gli ultimi avvenimenti. Il Capo dello Stato nei suoi spostamenti per il Paese - ha detto - non ha bisogno di nessuna approvazione e tanto meno dall’estero.
E’ chiaro che sul piano geo-economico si avranno ulteriori ripercussioni a Yokohama, al forum dei paesi Asia-Pacifico. Tanto più che per il governo giapponese la gestione della crisi è estremamente delicata, in quanto segue il confronto con la Cina sulle isole Senkaku, nelle acque del Mar Cinese Orientale.
Una disputa, questa, riesplosa dopo la collisione tra un peschereccio cinese e due unità della Guardia costiera giapponese. Una vicenda in cui il primo ministro Naoto Kan è stato accusato di debolezza nei confronti di Pechino. La crisi non è superata, tanto che nel week-end del vertice Asean ad Hanoi, il primo ministro cinese Wen Jiabao si è rifiutato di incontrare formalmente Kan.
Ora il premier giapponese deve gestire la sfida lanciata da Mosca. Intanto a Sakhalin e nelle Kurili si ritrovano problemi analoghi a quelli che oggi affliggono tutta fa Russia. Ma qui nell’arcipelago va rilevato che l’economia è malata e la produzione industriale, sia per ciò che riguarda l'estrazione del petrolio e del gas che per la pesca, si avvia sempre più alla recessione. Gli esempi sono tanti.
Nell’isola di Sikotan, ad esempio, ci sono periodi in cui, causa insufficienza del carburante destinato alla centrale elettrica del posto, nelle case l'elettricità viene erogata solo dalle 6 alle 19. Ritrovandosi nelle case fredde e buie gli abitanti ricordano bene che alcuni uomini d’affari dell'isola giapponese di Hokkaido proposero di assumersi l’onere delle forniture di prodotti petroliferi ai vicini russi. Mosca rifiutò l’offerta perché presero il sopravvento motivi di orgoglio nazionalistico. Al contrario, nell’isola di Kunasir, sono arrivati aiuti umanitari inviati dai vicini giapponesi.
Il Cremlino si dichiara pronto - come ha detto Medvedev - a risolvere il problema socio-ecomico dell’arcipelago che deve essere considerato un “vero tesoro per il futuro”. E così si allontana quel tempo in cui lo scrittore Cechov, a proposito dell’area di Sakhalin, diceva che “se qui vivessero solo coloro ai quali l’isola piace, questa sarebbe disabitata”.
 Oggi è necessario sicuramente correggere questo pensiero dello scrittore russo: se a Sakhalin vivessero solo coloro cui piace, l’isola sarebbe popolata quasi esclusivamente dalle popolazioni autoctone. Il fatto è che gli avvenimenti della storia russo-sovietica hanno ignorato la volontà dei locali che sono stati messi in minoranza: hanno perso le loro terre, i loro secolari diritti, le tradizioni, il senso della vita. Finiti nella morsa della storia, tra i belligeranti giapponesi e russi, gli ajni, antichissimi abitanti di queste terre, sono scomparsi.
Oggi è necessario sicuramente correggere questo pensiero dello scrittore russo: se a Sakhalin vivessero solo coloro cui piace, l’isola sarebbe popolata quasi esclusivamente dalle popolazioni autoctone. Il fatto è che gli avvenimenti della storia russo-sovietica hanno ignorato la volontà dei locali che sono stati messi in minoranza: hanno perso le loro terre, i loro secolari diritti, le tradizioni, il senso della vita. Finiti nella morsa della storia, tra i belligeranti giapponesi e russi, gli ajni, antichissimi abitanti di queste terre, sono scomparsi.
I cacciatori nivchi e gli allevatori di cervi ulta, cacciati dai loro paeselli e dai loro accampamenti, vivono in città e borgate sporche, indecenti. Le loro terre sono state deturpate dagli incendi e inzeppate di metalli arrugginiti - regato dei geologi. L'acqua dei fiumi e delle coste è stata inquinata dal petrolio.
La tragedia degli ex padroni di Sakhalin è riassunta in alcuni nuovissimi dati statistici: nelle circoscrizioni abitate dalle popolazioni sono nate 531 persone e ne sono morte 629, in questo stesso periodo sono stati celebrati 346 matrimoni e conclusi 339 divorzi…
Ma nonostante questa realtà sociale, il Cremlino di oggi parla di “Isole del tesoro”. Bisognerà vedere chi utilizzerà i tesori locali che si chiamano petrolio, gas e pesca…
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Alessio Marchetti
di Alessio Marchetti
PRAGA. Lavoro, casa, famiglia, salute e ordine: sono queste le parole d'ordine con le quali Viktor Orban, nel maggio dello scorso anno, ha stravinto le elezioni ungheresi a capo del suo partito Fidesz, con quasi il 53%, raggiungendo quindi oltre i due terzi dei consensi. Una vittoria che lui chiama rivoluzione dei due terzi. Attraverso la grande maggioranza parlamentare di cui dispone, Orban sta conducendo uno stile politico di stampo chiaramente nazionalista e populista. Questo stile sta preoccupando in maniera particolare l'Unione Europea, soprattutto in coincidenza col fatto che dal primo Gennaio 2011, l'Ungheria é diventata presidente di turno dell'Unione.
Una delle leggi che ha destato più preoccupazione nelle cancellerie continentali, e in particolare in Germania e Francia, é stata la legge sulla stampa, votata alle camere lo scorso autunno. La legge prevede, infatti, un organo che vigili sulla stampa presieduto da due membri eletti direttamente dalla stessa maggioranza parlamentare del presidente Orban. Quest’organo di vigilanza ha la facoltà di emettere multe fino a 200 milioni di fiorini (quasi 750 mila euro) qualora ravvisasse delle violazioni; può sospendere trasmissioni radio-televisive, chiedere ai giornalisti la rivelazione delle loro fonti, togliere le licenze agli editori “colpevoli” e chiedere inoltre di garantire un “bilanciamento” delle notizie con l'obbligatorietà di un contradditorio (una sorta di par condicio all'ungherese), dando sempre la possibilità di replica a un membro del Governo.
Il ministro delle Comunicazioni ungherese, Zoltan Kovacs, ha cercato goffamente di giustificare la legge, adducendo la scusa che gli “elementi tecnici” presenti nella legge si possono trovare tranquillamente anche in molte leggi sulla stampa di altri paesi europei, facendo l'esempio della Germania, paese nel quale é vietato per legge scrivere articoli di natura anti-semita nei giornali. Dal canto suo, Orban ha poi aggiunto che, in caso l'Unione Europea trovasse che la legge non sia conforme alle legislazioni in vigore in Europa, allora farebbe emendare la legge; allo stesso tempo ha però anche affermato che l'Unione Europea non si dovrebbe comunque intromettere negli affari ungheresi, accusando apertamente Francia e Germania: “Nessuno Stato o Nazione ha il diritto di criticare” ha detto: “Se Bruxelles dovesse continuare a immischiarsi negli affari ungheresi allora sono pronto a combattere... E ciò non sarebbe dannoso solo per l'Ungheria, ma per tutta l'Unione Europea”.
 In realtà, la legge sui media non é che solo una delle tante iniziative autoritarie intraprese dal nuovo governo. Orban ha recentemente abolito la Commissione del Fisco, organo indipendente che controlla i budget di spesa statali; ha confiscato i fondi di un sistema pensionistico privato creato per i dipendenti pubblici, usandoli per finanziare il suo piano di tagli; ha letteralmente spogliato la Corte Costituzionale in materia di legislazione economica dopo che la Corte stessa gli aveva respinto una norma che avrebbe introdotto una tassa retroattiva sulle liquidazioni dei lavoratori.
In realtà, la legge sui media non é che solo una delle tante iniziative autoritarie intraprese dal nuovo governo. Orban ha recentemente abolito la Commissione del Fisco, organo indipendente che controlla i budget di spesa statali; ha confiscato i fondi di un sistema pensionistico privato creato per i dipendenti pubblici, usandoli per finanziare il suo piano di tagli; ha letteralmente spogliato la Corte Costituzionale in materia di legislazione economica dopo che la Corte stessa gli aveva respinto una norma che avrebbe introdotto una tassa retroattiva sulle liquidazioni dei lavoratori.
Un altro aspetto che preoccupa non poco la UE, sono gli spettri del passato che Orban richiama continuamente alla memoria. Nel luglio 2010, ad esempio, é passata una legge che stabilisce la festa di Unità Nazionale per il 4 Giugno, giorno che commemora il Trattato di Trianon firmato nel 1920 con il quale si estingueva definitivamente il glorioso impero austro-ungarico. A questo proposito, Orban parla spesso di “tragedia nazionale”, ricordando i trattati di pace che hanno sancito la fine della prima guerra mondiale. Con una nuova legge, ha garantito poi la cittadinanza magiara ad ogni individuo di etnia ungherese che viva nei paesi vicini, scatenando tra l'altro forti proteste in Slovacchia, paese confinante che ha al suo interno una minoranze ungherese (10% sul totale della popolazione slovacca) molto forte e nostalgica.
L'impatto del comportamento del primo ministro ungherese sull'Unione Europea, preoccupa molto la cancelleria tedesca. La Merkel ha più volte richiamato l'attenzione degli altri Stati dell'Unione sull'attività del governo ungherese e la legge sui media non é stata che l'ultima goccia di un vaso da mesi traboccante. La Cancelliera tedesca ha più volte affermato la necessità di non sottovalutare certi comportamenti autoritari di Stati membri, onde prevenire che certi virus possano attaccare anche altri paesi UE.
Quello del primo ministro ungherese, é un approccio autoritario, sciovinista e nazionalista, anche se possiamo comunque affermare che Orban non é un fascista o un razzista della destra ultraconservatrice. Gli analisti politici ungheresi sono infatti d'accordo nell'affermare che la politica di Orban ha avuto, se non altro, l'effetto benefico di limitare notevolmente l'influenza del partito di estrema destra Jobbik, che raccoglieva molti voti tra gli skin-heads, fino quasi a farlo sparire dalla scena politica.
 Il governo Orban negli ultimi mesi ha portato a termine la ri-nazionalizzazione di diverse aziende che erano di proprietà statale sotto il regime comunista; ha imposto tasse corporative piuttosto elevate alle molte multinazionali straniere presenti in Ungheria, le quali, sfruttando il basso costo della manodopera locale, danno comunque lavoro a centinaia di migliaia di persone, soprattutto a Budapest nel settore terziario. Ha infine messo a punto delle rischiose strategie fiscali per la ripresa economica del paese, che molto sta soffrendo la crisi degli ultimi due anni, in modo da “tenere lontano il Fondo Monetario Internazionale dagli interessi ungheresi”.
Il governo Orban negli ultimi mesi ha portato a termine la ri-nazionalizzazione di diverse aziende che erano di proprietà statale sotto il regime comunista; ha imposto tasse corporative piuttosto elevate alle molte multinazionali straniere presenti in Ungheria, le quali, sfruttando il basso costo della manodopera locale, danno comunque lavoro a centinaia di migliaia di persone, soprattutto a Budapest nel settore terziario. Ha infine messo a punto delle rischiose strategie fiscali per la ripresa economica del paese, che molto sta soffrendo la crisi degli ultimi due anni, in modo da “tenere lontano il Fondo Monetario Internazionale dagli interessi ungheresi”.
Alla luce di tutti gli aspetti descritti sopra, alcuni analisti politici americani ed europei hanno parlato di Putinizzazione del'Ungheria. In effetti, le politiche di nazionalizzazione, l'attività censoria sulla stampa e il forte stampo nazionalista, possono anche disegnare un parallelo tra l'attuale governo ungherese e l'odiato ex impero coloniale russo.
In realtà Orban sembra ispirarsi più al nostro presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di cui tra l'altro é molto amico, tanto da vantarsi di avere colloqui settimanali con Palazzo Chigi. L'unica sostanziale differenza tra i due primi ministri é data forse dalla vita privata: quella del più giovane quarantasettenne Orban, sembra essere molto più morigerata.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Braconi
di Mario Braconi
La nostra storia inizia a marzo del 2009, quando a Luton, centro di 240.000 abitanti a cinquanta chilometri da Londra, un gruppo di musulmani ha “accolto” con gli slogan “assassini di bambini” e “macellai” il Royal Anglian Regiment, che sfilava per le vie della città subito dopo il rientro dall’Afghanistan. I bravi cittadini di Luton, già irritati dalle esternazioni della minoranza rumorosa di islamici, hanno perso la pazienza quando sui media ha cominciato a circolare il demenziale video propagandistico che ritrae Anjem Choudary, Imam estremista e “mente” della manifestazione contro le forze armate, mentre, proprio nel bel mezzo della dimostrazione anti-esercito, si dà alla conversione di un undicenne britannico “Sean”: un “documento” pateticamente propagandistico che, in un clima più sereno, avrebbe al più fatto sorridere dell’ingenuità di chi lo aveva concepito.
E invece le scomposte quanto puerili provocazioni messe in atto da alcuni membri del clero islamico dalle posizioni estreme e belligeranti sono state la causa scatenante della nascita della English Defence League (EDL), un’organizzazione di estrema destra che ufficialmente si propone di difendere, appunto, l’Inghilterra, contrastando in modo “determinato” la diffusione dell’Islam militante, della Sharia e del terrorismo islamico in Inghilterra.
Il brodo di coltura di questo nuovo e preoccupante fenomeno politico-sociale è quello delle tifoserie calcistiche, in particolare quel sottogruppo noto in Gran Bretagna come “casual football”, cosiddetto per lo stile elegante dei capi indossati dai suoi adepti, il cui scopo è rendere assai difficile per la polizia distinguere dall’aspetto esterno un pericoloso hooligan da un figlio di papà.
Anche se alcuni dei leader della neonata formazione politica non si sono mai conosciuti di persona, a garantire la coesione del movimento è stato, manco a dirlo, il tam-tam informatico sui vari social network. Il successo del movimento è stato esplosivo: si contano già almeno sei raggruppamenti territoriali nella sola Inghilterra, mentre si sono di recente formati movimenti gemelli in Svezia, Norvegia e Olanda; la EDL, infine, può contare sul supporto di organizzazioni neofasciste più antiche e radicate in Francia, Germania e Danimarca.
 Benché la EDL si sbracci ad edulcorare il potenziale infettivo delle sua idee e nonostante lo stesso British National Party (BNP) sostenga di non aver niente a che fare con la neonata organizzazione nazionalista e anti-islamica, gli attivisti antirazzisti sostengono, prove alla mano, che tra le fila di EDL militano anche diversi (ex?) operativi del BNP e che molti di loro hanno precedenti per violenza allo stadio.
Benché la EDL si sbracci ad edulcorare il potenziale infettivo delle sua idee e nonostante lo stesso British National Party (BNP) sostenga di non aver niente a che fare con la neonata organizzazione nazionalista e anti-islamica, gli attivisti antirazzisti sostengono, prove alla mano, che tra le fila di EDL militano anche diversi (ex?) operativi del BNP e che molti di loro hanno precedenti per violenza allo stadio.
Per queste ragioni, ogni volta che la EDL organizza un corteo, si registrano scontri fisici tanto con la polizia e che con gli oppositori e un numero variabile (ma sempre rilevante) di arresti da entrambi i lati. Si stima che il costo per la sicurezza pubblica di ognuna di queste manifestazioni possa arrivare a sfiorare il milione di sterline.
Quella organizzata dalla EDL il 5 febbraio a Luton, centro che per la EDL ha ovviamente un particolare significato, era da giorni un mal di testa per la polizia: anche in questo caso i circa 7.000 simpatizzanti hanno dovuto vedersela con le numerose organizzazioni anti-fasciste ed anti-razziste, ovviamente non disposte a lasciare campo libero a quelli che, con molte ragioni, considerano dei razzisti e dei violenti.
Nel corso di una recente intervista televisiva per la BBC, il giornalista e conduttore Jeremy Paxman ha grigliato per diversi minuti il “coattissimo” Stephen Yaxley-Lennon, (noto anche con il nome di Tommy Robinson), leader della EDL. La comprensibile irritazione del conduttore per gli eccessi verbali del suo ospite è però suonata ad alcuni commentatori progressisti intrisa di paternalismo e di una indimostrata e vagamente superficiale certezza: che quello dei nuovi “difensori dell’ identità britannica” sia un fuoco fatuo. Benché ciò sia auspicabile, non è detto che le cose stiano veramente così: infatti, come nota Jon Cuddas, deputato laburista che ha sfidato con successo il BNP, l’EDL è concepito per operare magnificamente nel milieu culturale della classe popolare maschile inglese, dove a farla da padrone sono i capi firmati e le discussioni di sport condite da decine di “pinte”.
 La cosa buffa è che, come nota provocatoriamente Suzanne Moore sul Guardian, i nuovi adepti della EDL potrebbero benissimo provenire dalle file del New Labour, che a suo tempo si è dato ad un lavaggio del cervello del popolo a base di confusi concetti, il cui vero obiettivo era convincere gli elettori dell’ineluttabilità storica e culturale della guerra in Iraq. E in effetti, nota polemicamente la giornalista, c’è qualcosa di perversamente ironico nel vedere l’estrema destra utilizzare la causa dei diritti delle donne come pretesto per scatenare una rissa al pub, se non fosse che il tutto suona più pericoloso che divertente.
La cosa buffa è che, come nota provocatoriamente Suzanne Moore sul Guardian, i nuovi adepti della EDL potrebbero benissimo provenire dalle file del New Labour, che a suo tempo si è dato ad un lavaggio del cervello del popolo a base di confusi concetti, il cui vero obiettivo era convincere gli elettori dell’ineluttabilità storica e culturale della guerra in Iraq. E in effetti, nota polemicamente la giornalista, c’è qualcosa di perversamente ironico nel vedere l’estrema destra utilizzare la causa dei diritti delle donne come pretesto per scatenare una rissa al pub, se non fosse che il tutto suona più pericoloso che divertente.
Sottovalutare la EDL è un grave errore politico, come del resto conferma la testimonianza di Nick Lowles, redattore di Searchlight, il periodico del movimento antirazzista internazionale: innanzitutto, scrive Lowles, si rischia che l’organizzazione evolva verso la forma di un esercito di strada; inoltre, la EDL ha una innegabile sagacia organizzativa e di comunicazione che la rende temibile. Infatti, essa programma i suoi “interventi” in vere e proprie polveriere che attendono solo l’innesco di una miccia. Inoltre, la EDL ci tiene molto a non essere definito un movimento razzista, e anzi può vantare tra le sue fila numerosi gruppi di minoranze (sikh, omosessuali, ebrei): un atteggiamento di inclusione sociale, caro ai liberal e (un tempo) loro esclusivo appannaggio culturale.
Senza contare che, come nota il professor Matthew Goodwin dell’Università di Manchester, la ragione per la quale l’islamofobia della EDL ai giorni nostri è particolarmente efficiente politicamente è che, a differenza di quanto accadeva negli anni settanta, quando il Fronte Nazionale si fece terra bruciata attorno manifestando aperto antisemitismo, oggi interi settori dei media e dell’establishment britannico sono relativamente inclini all’islamofobia. In questa temperie culturale, può ben accadere che giovani ben sbarbati nei loro impeccabili Aquascutum diano fuoco a qualche misera botteguccia gestita da asiatici. Il tutto, beninteso, per preservare la purezza della nostra “società aperta”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Il Sudan ha accettato la secessione del Sud: il 99% dei votanti delle regioni meridionali ha scelto l'indipendenza. E' stato questo il termine di un processo iniziato con l'accordo di pace siglato a Nairobi nel 2005, che pose fine, almeno formalmente, a una guerra civile durata 22 anni. Il conflitto, costato la vita a oltre due milioni di persone, ha messo a confronto i musulmani arabi del nord e la regione autonoma del sud, abitata da circa 6 milioni di africani cristiani. I risultati definitivi del referendum arriveranno solo il 14 febbraio. Se, come pare ovvio, saranno confermati, il nuovo Paese sarà libero di dichiarare ufficialmente la propria indipendenza il prossimo 9 luglio.
Può sembrare una storia a lieto fine, ma non lo è. Semplicemente perché ancora siamo ben lontani dalla fine. Il governo del Sudan ha scelto la strada del pragmatismo, l'unica possibile. Il sanguinario presidente al Bashir, infatti, è messo da più parti sotto pressione. Giudicato due anni fa colpevole dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel Darfur, oggi il dittatore si ritrova anche parecchi problemi in casa. E non solo al sud: le rivolte popolari in Tunisia e in Egitto sembrano aver incoraggiato alcuni gruppi a protestare contro il governo anche nel nord del Paese. A sua volta, lo strappo che si è consumato con successo in Sudan potrebbe rinvigorire altri movimenti indipendentisti africani: il Mthwakazi Liberation, che vuole dividere il Matabeleland dallo Zimbabwe, e il gruppo etnico dei Lozi, che punta all'autonomia nella parte occidentale dello Zambia.
Nonostante tutto, al Bashir sa benissimo che la strada per la secessione è ancora lunga e piena di ostacoli. Partiamo dal piano politico. Non è ancora chiaro quale percorso seguirà il confine fra i due stati ed è verosimile che in diversi casi si possa arrivare allo scontro. La regione centrale di Abyei, ad esempio (10 mila chilometri quadrati fertili e ricchi di petrolio) è contesa fra le due parti. C'è poi la questione del diritto di cittadinanza nel nuovo stato: a quali sudanesi sarà riconosciuto? In che modo?
 Sul piano economico, come prevedibile, il discorso assume toni drammatici. Il Sudan ha un debito pubblico da 36 miliardi di dollari che i nuovi cittadini del sud non hanno nessuna intenzione di tenersi sulle spalle. Ma oltre ai soldi da pagare, c'è anche la ricchezza da produrre. I negoziati più difficili saranno proprio quelli relativi alle risorse economiche. I due stati dovranno trovare un accordo per spartirsi i terreni più produttivi, alcuni dei quali bagnati dal Nilo, le miniere d'oro, il gas naturale e, soprattutto, il petrolio.
Sul piano economico, come prevedibile, il discorso assume toni drammatici. Il Sudan ha un debito pubblico da 36 miliardi di dollari che i nuovi cittadini del sud non hanno nessuna intenzione di tenersi sulle spalle. Ma oltre ai soldi da pagare, c'è anche la ricchezza da produrre. I negoziati più difficili saranno proprio quelli relativi alle risorse economiche. I due stati dovranno trovare un accordo per spartirsi i terreni più produttivi, alcuni dei quali bagnati dal Nilo, le miniere d'oro, il gas naturale e, soprattutto, il petrolio.
Sarà proprio questo il punto più delicato della trattativa. Sia il nord che il sud del Paese fondano la stragrande maggioranza della propria economia sull'oro nero. Ma, purtroppo per loro, anche a secessione avvenuta, nessuno dei due territori potrà fare a meno dell'altro. Se nel sud, prevalentemente rurale, si trovano i tre quarti dei giacimenti, l'unico oleodotto del paese arriva a Port Sudan, nel nord. Qui sorgono anche tutte le infrastrutture per la lavorazione.
Non è certo facile immaginare che gli abitanti delle regioni meridionali scelgano di privarsi, seppure in parte, della loro unica ricchezza. Si fa strada così il progetto per un nuovo oleodotto tra Juba (Sudan meridionale) e Lamu (Kenya), che costringerebbe il nord a sperare in una produzione autonoma da sviluppare attraverso giacimenti nel mar Rosso.
E' inoltre probabile che nel nuovo stato meridionale si formino diversi gruppi in contrasto fra loro per il controllo delle risorse. Conflitti che potenzialmente si aggiungeranno a quelli lungo il nuovo confine, in corrispondenza dei territori più contesi. Tutto questo in una delle regioni più sottosviluppate del mondo.
