- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
In un colpo solo l’Ocse smentisce il governo Monti e scrive un gigantesco punto interrogativo sul destino del governo Letta. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ieri ha presentato a Roma il suo ultimo rapporto sull’Italia, nei prossimi mesi il nostro Paese navigherà in acque peggiori del previsto: il Pil subirà quest’anno una contrazione dell’1,5%, (solo a novembre le stime parlavano di un -1%), mentre l’anno prossimo dovrebbe tornare positivo di circa mezzo punto.
Il dato più preoccupante è però quello relativo al deficit, che stando ai calcoli dell'Ocse si attesterà al 3,3% del Pil nel 2013 e al 3,8% nel 2014. Altro che pareggio di bilancio. Se queste cifre fossero confermate, Bruxelles non potrebbe chiudere a breve la procedura d’infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia, poiché il trattato di Maastricht prescrive che il dato non superi il 3%. Il governo Letta dovrebbe quindi varare una nuova manovra finanziaria, come ha confermato ieri il capo economista dell’Ocse, Pier Carlo Padoan. Eppure a Roma sembrano tutti convinti che la questione si risolverà entro la fine del mese.
Secondo il nuovo ministro del Tesoro, Fabrizio Saccomanni, la procedura dell’Unione europea “può essere chiusa nelle prossime settimane, entro fine maggio, al massimo entro i primi di giugno” e questo aprirebbe perfino la strada “a un allentamento di vincoli, come il patto di stabilità interno, liberando fondi per 12 miliardi che darebbero stimolo a investimenti produttivi”.
Insomma, sembra che l’Ocse e Saccomanni parlino di due Paesi diversi. Com’è possibile? Confrontiamo innanzitutto i numeri diffusi ieri dall’organizzazione internazionale con le previsioni pubblicate il mese scorso dall’uscente governo Monti. Secondo l’ultimo Documento di economia e finanza (Def), il deficit italiano peggiorerà quest’anno soltanto fino al 2,9% e nel 2014 scenderà addirittura all’1,8%. Quanto al Pil, i professori ritengono che quest’anno calerà dell’1,3%, per poi salire della stessa percentuale nei successivi 12 mesi. La differenza è notevole, ma Saccomanni fa notare che le stime Ocse "non tengono conto dell'impatto del decreto per il pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione" sui conti del 2013 e del 2014. Parrebbe di capire che il decreto pagamenti sia quindi in grado di stimolare il Pil al punto da ridurne il rapporto con il deficit. La questione però non è chiara, dal momento che, nella revisione del Def effettuata dopo il varo di quello stesso decreto da 40 miliardi in due anni, le stime del governo Monti sul deficit 2013 non erano state limate al ribasso, ma al rialzo, passando dal 2,4 al 2,9%. Appena un decimo in meno della famigerata soglia invalicabile.
La differenza è notevole, ma Saccomanni fa notare che le stime Ocse "non tengono conto dell'impatto del decreto per il pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione" sui conti del 2013 e del 2014. Parrebbe di capire che il decreto pagamenti sia quindi in grado di stimolare il Pil al punto da ridurne il rapporto con il deficit. La questione però non è chiara, dal momento che, nella revisione del Def effettuata dopo il varo di quello stesso decreto da 40 miliardi in due anni, le stime del governo Monti sul deficit 2013 non erano state limate al ribasso, ma al rialzo, passando dal 2,4 al 2,9%. Appena un decimo in meno della famigerata soglia invalicabile.
Su questa corda sottilissima e traballante dovrà camminare nei prossimi mesi Enrico Letta. Nel discorso tenuto alla Camera il giorno della fiducia, il neopremier ha espresso l’intenzione di varare una serie di misure, molte delle quali sembrano necessariamente implicare un aumento della spesa pubblica: dal controverso intervento sull’Imu alla soluzione della questione esodati, passando per il rilancio dell’occupazione e il sostegno alle imprese.
Un programma così ambizioso dovrebbe esigere la rinegoziazione dei vincoli di bilancio concordati con l’Europa, operazione auspicata dallo stesso Presidente del Consiglio. Tuttavia, di ritorno dal viaggio europeo che in meno di tre giorni lo ha portato a incontrare i big del continente (la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Françoise Hollande, il numero uno del Consiglio Ue Herman Van Romuy e il leader della Commissione europea José Barroso), il Premier italiano ha confermato l’intenzione di rispettare tutti gli impegni sottoscritti dai governi precedenti.
Anche ammettendo che i conti italiani del 2013 rispondano ai criteri europei senza bisogno di ulteriori interventi correttivi, dunque, non si vede in quale modo l’Esecutivo possa evitare nuove manovre e al contempo avviare il suo grandioso programma di riforme economiche. Da dove prenderemo le risorse senza scatenare l’ira funesta di Bruxelles?
L’interrogativo al momento rimane senza risposta. Ieri Letta ammesso che sta ancora “cercando di capire quali siano i margini di manovra e le possibilità per lavorare”. Speriamo che non arrivi alle stesse conclusioni dell’Ocse.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Da Bruxelles continuano a ripetere che la Slovenia non è Cipro, ma a Lubiana sanno benissimo di non avere tempo da perdere. "Prepareremo il nostro programma di riforme per stabilizzare l'economia entro il 9 maggio e lo spediremo immediatamente alla Commissione europea - ha spiegato venerdì il premier Alenka Bratusek -. Siamo consapevoli che non abbiamo settimane o mesi, ma soltanto giorni".
Entro fine aprile il governo sloveno presenterà al Parlamento proposte per privatizzare "una o due grandi aziende di stato", fra le quali probabilmente una banca: "Sarebbe un buon messaggio per i mercati internazionali", ha spiegato ancora il Premier. Se il piano fallirà, entro il 2013 la Slovenia diventerà il sesto Paese dell'Eurozona a chiedere aiuti internazionali, finendo sotto il controllo della Troika (Ue, Bce e Fmi).
Mercoledì scorso la Commissione europea ha ammesso che la crisi economica e finanziaria slovena, insieme a quella spagnola, rappresenta il rischio più grave per l'area della moneta unica: "Finora i livelli di indebitamento pubblico e privato sono al di sotto della soglia di allerta - si legge nel rapporto di Bruxelles sugli squilibri macroeconomici -. Anche il debito esterno netto è relativamente contenuto", ma "molte aziende sono ancora eccessivamente indebitate e questo conduce a un ulteriore aumento dei prestiti di cattiva qualità".
E' proprio questo il problema numero uno: le banche slovene (quasi tutte a maggioranza pubblica) hanno erogato negli ultimi anni una quantità esagerata di prestiti e mutui, molti dei quali con il tempo si sono deteriorati, il che significa che i debitori non riescono a restituire le somme dovute. In questo modo sono aumentate le sofferenze degli istituti (ovvero i crediti inesigibili, che hanno raggiunto i 7 miliardi, pari al 14,4% degli impieghi e al 20% del Pil), mentre le riserve di capitale continuano ad assottigliarsi.
Ma come si è arrivati a questo punto? Il settore finanziario sloveno è cresciuto in modo esponenziale dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia (raggiunta nel 1991). I nuovi gruppi si sono finanziati con risorse delle banche pubbliche, che così hanno accumulato in portafoglio moltissime azioni di queste mega-società a titolo di garanzia. Con l'esplodere della crisi internazionale, i grandi gruppi si sono ritrovati insolventi e le azioni in mano alle banche hanno perso rapidamente valore, aprendo un buco nei bilanci degli istituti. La situazione rischia di creare il panico sui mercati nonostante le dimensioni del sistema bancario sloveno siano relativamente piccole (meno della metà rispetto alla media dell'Eurozona).
Oltre a Bruxelles, anche l'Ocse ha avvertito Lubiana di mettere rapidamente in sicurezza i suoi istituti di credito: "La Slovenia deve fare fronte al rischio di una prolungata recessione della sua economia e di un accesso ridotto ai mercati finanziari - si legge nello studio dell'Organizzazione -. Sono necessarie nuove e radicali misure appena possibile per evitare tale scenario". Secondo l'Ocse, le iniziative varate fin qui sono positive ma insufficienti: è necessario risanare i bilanci delle banche e assicurare la patrimonializzazione delle più "vitali" attraverso aumenti di capitale. Oltre alle privatizzazioni, lo strumento fondamentale per riequilibrare la situazione dovrebbe essere una bad bank, ossia un'unica cassa in cui far confluire tutti i crediti inesigibili. La legge per la sua creazione è stata approvata dal precedente governo conservatore - caduto alcune settimane fa in seguito ad alcuni scandali e a diffuse proteste popolari -, ma Bratusek ha avvertito che "non è stata preparata come avrebbe dovuto essere". In effetti, sempre secondo l'Ocse, il funzionamento della bad bank non è sufficientemente trasparente e rischia di essere viziato da ingerenze politiche.
Secondo l'Ocse, le iniziative varate fin qui sono positive ma insufficienti: è necessario risanare i bilanci delle banche e assicurare la patrimonializzazione delle più "vitali" attraverso aumenti di capitale. Oltre alle privatizzazioni, lo strumento fondamentale per riequilibrare la situazione dovrebbe essere una bad bank, ossia un'unica cassa in cui far confluire tutti i crediti inesigibili. La legge per la sua creazione è stata approvata dal precedente governo conservatore - caduto alcune settimane fa in seguito ad alcuni scandali e a diffuse proteste popolari -, ma Bratusek ha avvertito che "non è stata preparata come avrebbe dovuto essere". In effetti, sempre secondo l'Ocse, il funzionamento della bad bank non è sufficientemente trasparente e rischia di essere viziato da ingerenze politiche.
Intanto, la settimana scorsa Lubiana ha deluso i mercati con una pessima asta di bond pubblici. Il Tesoro sloveno ha venduto titoli di Stato a varia scadenza per un ammontare complessivo di 56 milioni di euro, mancando clamorosamente l'obiettivo prefissato, che era quasi il doppio. I tassi d'interesse, ovviamente, sono saliti. Non un buon viatico in vista dell'appuntamento decisivo per le casse del Paese, ovvero l'asta da circa un miliardo in calendario a giugno.
Stando ai calcoli dell'Institute for International Finance (Iif), l'associazione delle principali banche mondiali che ha fatto da regista alla ristrutturazione del debito greco, "la Slovenia ha bisogno di un intervento immediato della Ue per mettere in sicurezza le sue finanze. Più si rinviano le decisioni, più salirà la pressione sul credito e più alto sarà il rischio di dover scendere in campo più avanti con un piano di salvataggio". Anche perché il Paese ha bisogno di raccogliere sul mercato 3,5 miliardi nel 2013 e se la situazione precipitasse si ritroverebbe tra il 2014 e il 2015 con scadenze per 5,8 miliardi. Un peso troppo grande per le spalle di Lubiana.
Venerdì scorso il rendimento sui titoli di Stato sloveni a 10 anni era al 6,65%, pari a uno spread con il Bund tedesco di 539 punti base. Bratusek si è detta sorpresa dal fatto che il precedente governo non abbia cercato di raccogliere capitali sui mercati a gennaio, quando i rendimenti erano molto più bassi di oggi. Sono bastati tre mesi per finire sull'orlo del baratro. Ora rimangono 20 giorni per fare un passo indietro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
E' un record di cui avremmo volentieri fatto a meno. Ma tant'è, siamo primi. Nella classifica mondiale, l'Italia è il Paese con il debito pubblico su cui sono stati sottoscritti più Cds in assoluto: 388 miliardi di dollari a fine 2012, contro i 158 del 2008. Il dato emerge dal "Global Financial Stability Report" del Fondo Monetario Internazionale, che in verità registra un incremento dei Cds su tutti i Paesi europei. Nella graduatoria complessiva, comunque, noi italiani non temiamo alcun confronto: al secondo posto si piazza la Spagna, lontanissima con i suoi 212 miliardi, mentre la medaglia di bronzo va alla Francia, a quota 117. Appena fuori dal podio troviamo il Brasile (156 miliardi) e la Germania (154).
Ma cosa sono i Cds? Il simpatico acronimo sta per "Credit-default swaps", ovvero titoli derivati che funzionano come una polizza assicurativa sulla vita di altre obbligazioni (i titoli di Stato, in questo caso). Il pagamento dei Cds scatta quando chi ha emesso le obbligazioni si dichiara insolvente: tu fai bancarotta, io incasso. Nati come strumenti per tutelarsi dai rischi, questi derivati sono cresciuti in un mercato deregolamentato che li ha trasformati ben presto in micidiali strumenti speculativi. E' infatti possibile acquistare Cds anche su obbligazioni che non si hanno in portafoglio, e questo non significa proteggersi da un rischio, bensì scommettere sul fallimento altrui. Trarre nutrimento dalle carcasse, come fanno gli avvoltoi.
Il record italiano non vuol dire però che secondo gli investitori il nostro Paese sia il più vicino al fallimento. Sanno tutti benissimo che non è così. L'arcano si può spiegare con una mera questione aritmetica: l'ammontare dei Cds è infatti tendenzialmente proporzionale alle dimensioni del debito pubblico. Il nostro non è il più alto al mondo, ma fra i Paesi con indebitamenti mostruosi siamo certamente quello con l'economia più debole.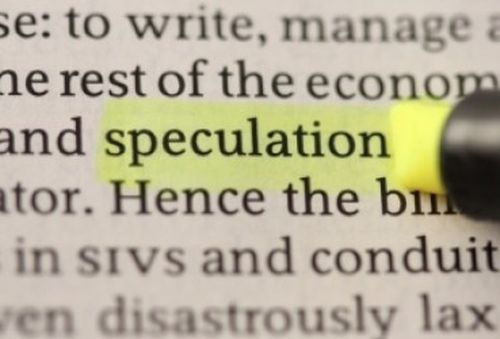 Ora però è bene chiarire che acquistare un Cds in ottica speculativa (ossia senza avere le obbligazioni corrispondenti) vuol dire sì scommettere contro qualcuno, ma non in senso tradizionale. Se in una corsa automobilistica puntassimo sull'esplosione di una macchina, poi ci limiteremmo a guardare la gara sperando nella sciagura. Con i Cds, invece, è come se rendessimo quell'esplosione più probabile, mettendo mano al motore dell'auto.
Ora però è bene chiarire che acquistare un Cds in ottica speculativa (ossia senza avere le obbligazioni corrispondenti) vuol dire sì scommettere contro qualcuno, ma non in senso tradizionale. Se in una corsa automobilistica puntassimo sull'esplosione di una macchina, poi ci limiteremmo a guardare la gara sperando nella sciagura. Con i Cds, invece, è come se rendessimo quell'esplosione più probabile, mettendo mano al motore dell'auto.
Sempre secondo l'Fmi, infatti, la volatilità dei credit default swap italiani ha l'effetto di incrementare "artificialmente" il costo del finanziamento sovrano del nostro Paese, ovvero i tassi d'interesse sui nostri titoli di Stato. Teoricamente dovrebbe accadere il contrario, ma per l'Italia non è così, perché a pesare è soprattutto la volatilità correlata a fattori di natura "residuale", cioè non legata ai fondamentali dell'economia nazionale, quanto piuttosto a fattori di rischio sistemico e di contagio indotti dalla volatilità di altri Cds sui debiti sovrani.
In particolare, il Fondo monetario stima che la "volatilità residuale" dei Cds sull'Italia dipenda per circa 75% da quella dei Cds sul debito pubblico tedesco e per il 20% da quella sui Cds spagnoli. E' evidente quindi che spesso chi compra questi titoli lo fa in previsione di quel tanto temuto effetto domino nell'Eurozona che dovrebbe portare la moneta unica all'armageddon finale.
Il tipo di strategia è confermata dall'andamento complessivo del mercato dei Cds: a fine giugno 2012, quelli sui debiti sovrani dei vari Paesi ammontavano complessivamente a circa 3 mila miliardi di dollari, mentre il bacino complessivo dei Cds (che comprende anche quelli sulle aziende) era pari a 27 mila miliardi. Il mercato di chi si protegge (o specula) contro l'insolvenza dei titoli di stato valeva quindi poco più del 10% del mercato globale.
Ma dal 2008 - ovvero dall'inizio della crisi - i Cds per coprirsi dal rischio sovrano sono aumentati moltissimo, mentre gli altri segmenti si sono ridimensionati. E, cosa ancor più importante, da allora a oggi nessuno è riuscito a imporre delle regole ferree a chi compra e vende questi titoli. Per dirla con gli economisti, i Cds dovrebbero essere "uno strumento importante nella gestione del rischio". Ma spesso fanno ancora la parte dei derivati-avvoltoi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Non solo Cipro, non solo Pigs. Alla bomba europea è collegata almeno un’altra miccia, la Slovenia. Quella che una volta era considerata la "Svizzera di Jugoslavia" potrebbe diventare presto il sesto Paese dell'Eurozona (dopo Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro) a chiedere aiuti internazionali. Anche se per le agenzie di rating i conti di Lubiana sono ancora da serie A (Standard & Poor's le assegna una A, Fitch A- e Moody's Baa2), in molti a Bruxelles e dintorni prevedono la necessità di un piano di salvataggio entro fine 2013.
Martedì scorso la Banca centrale slovena ha tagliato con il machete le stime sul Pil di quest'anno, passate da -0,7 a -1,9%. Intanto la disoccupazione è schizzata al 13,6%, il deficit 2012 è arrivato oltre il 6% e nel 2013 si manterrà probabilmente oltre il 4%. La ripresa dovrebbe iniziare lentamente nel 2014 (Pil +0,5%), per poi accelerare nel 2015 (+1,4%). Ma non è detto, e forse non sarà sufficiente. Il governatore Mirko Kranjec ha avvertito che "molto dipenderà da quanto farà lo Stato quest'anno e il prossimo ", perché "i rischi sono alti".
Quali rischi? Facile, le banche. In Slovenia gli istituti di credito sono per la maggior parte controllati dallo Stato e pesano per circa il 130% del Pil. L'anno scorso hanno perso per strada in tutto 606 milioni di euro, 67 in più del 2011. Tanto per cambiare, una fetta significativa dell'emorragia finanziaria è legata al mattone. Le banche hanno dispensato mutui e prestiti con eccessiva allegria, poi i prezzi delle case si sono impennati e molti debitori sono risultati insolventi.
Il tutto mentre il Paese deve ancora riprendersi dalla recente crisi di governo. Pochi giorni fa si è insediato il nuovo esecutivo di centrosinistra, guidato Alenka Bratusek, che ha sostituito la squadra del conservatore Janez Jansa, politico di lungo corso ritenuto “affidabile” dalla cancelliera Angela Merkel, ma sconfitto senza appello dalla crisi.
Per far fronte alle difficoltà, Jansa si era attenuto al copione europeo dell'austerity, fatto di tagli alla spesa e fantomatici pareggi di bilancio. Alla solita ricetta, però, gli sloveni hanno aggiunto due ingredienti: una bad bank per assorbire le perdite bancarie e una holding per privatizzare parte del patrimonio pubblico (misure su cui i sindacati avevano chiesto un referendum, poi bocciato dalla Corte costituzionale). Le proteste popolari e un'esplicita accusa di corruzione hanno segnato la fine di Jansa, che nell'abbandonare la nave non è apparso troppo rammaricato. Ora tocca a Bratusek, che però non sembra in grado di modificare nella sostanza la rotta impostata dal suo predecessore: holding e bad bank fanno parte anche del suo programma, insieme alla riforma delle pensioni e del lavoro. Altri interventi possibili sono l’aumento dell’Iva, la riduzione del salario dei dipendenti pubblici e il taglio di circa il 10% del loro organico.
Le proteste popolari e un'esplicita accusa di corruzione hanno segnato la fine di Jansa, che nell'abbandonare la nave non è apparso troppo rammaricato. Ora tocca a Bratusek, che però non sembra in grado di modificare nella sostanza la rotta impostata dal suo predecessore: holding e bad bank fanno parte anche del suo programma, insieme alla riforma delle pensioni e del lavoro. Altri interventi possibili sono l’aumento dell’Iva, la riduzione del salario dei dipendenti pubblici e il taglio di circa il 10% del loro organico.
La matassa è davvero ingarbugliata, eppure fino a qualche anno fa non sembrava affatto. Dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia - raggiunta nel 1991 -, fra il 1992 e il 2008 il Pil della Slovenia è cresciuto all'invidiabile media annua del 5,5%. La sbornia da economia di mercato si è rivelata però difficile da smaltire e l'ondata di privatizzazioni a rotta di collo ha prodotto una crescita troppo violenta per essere sana.
Ma la vera svolta è stata quella europea. Nel 2004 la Slovenia è entrata nell'Ue e all'inizio del 2007 ha adottato ufficialmente la moneta unica. Un tempismo disgraziato, visto che meno di due anni dopo è iniziato il domino delle crisi, dalla Atene fino a Nicosia. La tempesta ha inevitabilmente oscurato anche i cieli sloveni e le aziende privatizzate hanno iniziato ad aumentare il proprio indebitamento con le banche. Ad oggi, gli istituti di credito devono fare i conti con sofferenze (ovvero crediti impossibili da riscuotere) pari al 18% del Pil.
Di qui un dubbio amletico: l'ingresso nella grande famiglia di Bruxelles ha evitato guai peggiori all'economia slovena o le ha dato il colpo di grazia? Mettiamo a confronto qualche dato "prima e dopo", come si fa nelle pubblicità delle diete: il Pil è passato dalla crescita alla contrazione; il tasso di disoccupazione è aumentato di oltre il 3%; il debito pubblico è salito dal 35,7 % al 49,5% del Pil; i tassi d'interesse sui titolo di Stato decennali sono saliti dal 5,5 al 6,9%. E' migliorato invece il commercio, con il saldo tra esportazioni e importazioni salito dai -300 milioni del 2006 ai -200 del 2012.
"Non saremo costretti al bailout - ha detto ancora il governatore Kranjec -, i sistemi bancari della Slovenia e di Cipro non sono comparabili e rappresentano proporzioni totalmente diverse dei rispettivi Pil. Le nostre difficoltà sono state causate da una politica creditizia eccessivamente espansiva nel periodo dal 2004 al 2008, ma non c’è nulla che non siamo in grado di risolvere autonomamente". Intanto, però, "stiamo ancora aspettando che venga presentato il programma del governo e speriamo che aiuti a stabilizzare la situazione". Lo spera anche il nostro Paese, visto che l'esposizione delle banche italiane in terra slovena è di oltre sette miliardi e mezzo. Altro che Cipro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Liliana Adamo
di Liliana Adamo
Tutto ciò che vorreste sapere sul Fiscal Compact e non osate chiedere. A dare le dovute risposte non sono stati i partirti politici (compreso il M5S), tantomeno la tecnocrazia europea. C’è voluto un intero capitolo tratto da un libro, “Cosa salverà l’Europa. Critiche e proposte per un’economia diversa” (curato da B. Coriat, T. Coutrot, D. Lang, H. Sterdyniak), per avere un’esplicativa disamina di cosa, in realtà, ci attende.
Procediamo a ritroso. Il trattato internazionale è stato ratificato il 2 marzo dello scorso anno da tutti gli stati membri dell’Ue (con la sola esclusione di Repubblica Ceca e Regno Unito); impone d’avere un deficit pubblico “strutturale” (vale a dire “proporzionato” all’evoluzione del ciclo economico), che non oltrepassi lo 0,5% del Pil. In altre parole, per quei paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del Pil, la soglia d’ammissibilità nel rapporto fra i due oggetti sarà obbligata a livellarsi sull’1%, con uscite concernenti gli stati membri, che potranno avere uno “scoperto” sulle entrate non superiori allo 0,5% del Pil; finanche, il dato include le spese degli interessi sul debito pubblico. Avete letto bene: perfino le spese sugli interessi…
Primo elemento su cui riflettere: il termine “strutturale” ha in sé complicati procedimenti statistici che “ritoccano” il calcolo secondo il ciclo economico. Ebbene, vista l’attuale recessione, le entrate (ovverossia, le tasse), si abbassano (ma non la pressione fiscale che fornisce, comunque, una minore quantità di denaro), mentre si alzano le uscite, per esempio quelle che coprono gli ammortizzatori sociali. La “correzione” ne terrà conto? In pratica, chi ha un disavanzo pari al 2% del Pil potrà ottenere un dato “strutturale” conciliabile con lo 0,5% stabilito a priori dal trattato.
Nel giro di vent’anni vigerà l’obbligo a rientrare in questo limite minimo al ritmo forsennato di un ventesimo d’eccedente, per ogni benedetto anno. Significa che il debito pubblico italiano, pari a 126%, sarà obbligato a restringersi intorno al 60% del Pil e che l’Italia dovrà registrare avanzi primari fino al 2033. Due le ipotesi perfettamente antitetiche: per gli economisti che si oppongono al Fiscal Compact, questo si tradurrà in vent’anni d’insostenibile inflessibilità, rendendo permanente la recessione economica, mentre per i tecnocrati della Bce (in testa, la cancelliera Merkel e l’intero staff della troika, Fmi e Commissione inclusi), rispettare le condizioni del trattato vorrà dire riconquistare la fiducia dei mercati, agevolare la posizione dei titoli debitori, frenare i tassi d’interesse.
Due le ipotesi perfettamente antitetiche: per gli economisti che si oppongono al Fiscal Compact, questo si tradurrà in vent’anni d’insostenibile inflessibilità, rendendo permanente la recessione economica, mentre per i tecnocrati della Bce (in testa, la cancelliera Merkel e l’intero staff della troika, Fmi e Commissione inclusi), rispettare le condizioni del trattato vorrà dire riconquistare la fiducia dei mercati, agevolare la posizione dei titoli debitori, frenare i tassi d’interesse.
Veniamo ai nostri partiti politici, riprendendone l’orientamento prima e dopo l’ultima campagna elettorale (conclusasi con un nulla di fatto). Il primo degli otto punti (sostanziali), presentati da Pierluigi Bersani alla direzione del PD, chiarisce (finalmente) la questione (pur non affrontandola di petto). "Il governo italiano dovrà apportare una correzione nelle politiche europee di stabilità, conciliando la disciplina del bilancio con investimenti pubblici produttivi, al fine d’ottenere maggiore elasticità con obiettivi a medio termine nella finanza pubblica…L’aggiustamento del debito e deficit è fra gli obiettivi a medio termine. Nell’immediato, l’emergenza sta nell’economia reale e nell’occupazione"…
Molto probabilmente, l’intento è riferito a politiche fiscali anticicliche, al temporaneo aumento del debito con la spesa pubblica non coperta da tassazione, bensì finanziata da emissione di titoli, invertendo, in tal modo, il rullo compressore del Fiscal Compact. E riferendosi anche all’introduzione di deroghe nel famoso tetto dello 0,5%, come pure al rapporto “strutturale” tra deficit e Pil, dilatando, in questo modo l’arco temporale (vent’anni) entro cui conseguire la riduzione del nostro debito. “Stabilizzazione del debito pubblico” è un termine (e un concetto), usato dal segretario del partito democratico, al posto di un rilevante azzeramento voluto dalla troika.
Per ciò che concerne l’interlocutore più irascibile, Beppe Grillo (e il M5S), assolutamente programmatica la totale rinegoziazione dei vincoli fiscali e di bilanci europei; giusto per ripristinare quei fondi tagliati a scuola pubblica, sanità, abolire l’Imu, erogare misure come reddito di cittadinanza e quant’altro. Fermo restando che nel manifesto M5S i capisaldi si concentrano principalmente sui costi dello Stato, sul taglio degli sprechi, sulla casta e i suoi affiliati, auspicando l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici che consentano la democratizzazione al flusso d’informazioni e servizi, senza il bisogno, per il cittadino, di vari intermediari.
C’è d’aggiungere che con il Fiscal Compact cresce la preoccupazione, tutta istituzionale, di un “europeismo da gregge” in forte decadenza, influendo negativamente sulle scelte elettorali, come tra l’altro è già avvenuto, particolarmente per chi (come Monti), si presenta filo - europeista.
 Ricordiamoci, che PD, UDC, perfino i berlusconiani e i leghisti, il Fiscal Compact l’hanno approvato, firmato, reso legge dello Stato, anche se la ratifica formale ci è arrivata, come un verdetto tra capo e collo, soltanto il 2 marzo del 2012. Il pericolo di una deriva economica senza appello, che coinvolga anche i vecchi capisaldi dell’Europa - i diritti acquisiti - è, secondo molti economisti contro, un dato di fatto.
Ricordiamoci, che PD, UDC, perfino i berlusconiani e i leghisti, il Fiscal Compact l’hanno approvato, firmato, reso legge dello Stato, anche se la ratifica formale ci è arrivata, come un verdetto tra capo e collo, soltanto il 2 marzo del 2012. Il pericolo di una deriva economica senza appello, che coinvolga anche i vecchi capisaldi dell’Europa - i diritti acquisiti - è, secondo molti economisti contro, un dato di fatto.
Il trattato è frutto di un liberismo sregolato che agisce come un’arma a doppio taglio legata alla finanza internazionale, che scommette sul fallimento d’intere nazioni, impone profitti a scapito dell’ambiente, del lavoro, del risparmio e di un sistema basato sull’economia reale tutt’altro che obsoleta.
Ed è palese (come scrivono gli autori del pamphlet citato in apertura), il tentativo di “paralizzare completamente le politiche fiscali”, al contempo, “privare le politiche economiche di qualsiasi potere discrezionale…”, mettere in atto, cioè, l’obiettivo basilare: sbarrare la strada alle questioni nazionali che regolano i bilanci statali.
Ciascuna nazione, soprattutto nell’area del sud Europa (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, insieme a Irlanda e i paesi membri dell’Est), dovrà adottare un regime d’austerità a tempo indeterminato con misure violentemente restrittive che ledono diritti e democrazia. Ciò si traduce in diminuzione per pensioni, salari, funzioni (e funzionari) dello Stato, prestazioni sociali, ma si traduce anche, in aumento progressivo delle tasse.
