- Dettagli
- Scritto da Administrator
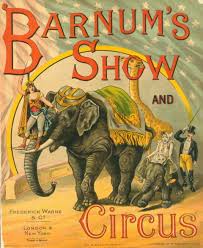 di Tania Careddu
di Tania Careddu
A quarant’otto anni dalla promulgazione della prima legge, la 337 del 1968, che ha progressivamente regolamentato il settore circense, l’Italia rimane ancora uno dei pochissimi paesi europei e nel mondo a essere privo di una normativa che proibisca l’esibizione degli animali nei circhi.
Seppure con segnali di apertura recenti, riconducibili alla Riforma Franceschini, il Belpaese, in materia, si attiene alle Linee Guida internazionali, emanate nel 1973, solo per la corretta sopravvivenza degli animali custoditi, relativamente a questioni di carattere sanitario e amministrativo.
Non esiste un’anagrafe nazionale degli animali utilizzati negli spettacoli né un registro delle unità circensi che, a occhio e croce, dovrebbero essere circa ottantacinque, malamente enumerabili per la consuetudine delle insegne circensi di suddividersi in più unità o di cambiare frequentemente nome.
Di animali se ne stimano circa duemila fra cavalli, asini, zebre, bisonti, cammelli e dromedari, lama, giraffe, rinoceronti e ippopotami, elefanti, tigri di ogni colore, leoni, struzzi, otarie, pinguini, rettili e piranha.
Ma domatori autorevoli e animali in gabbia non riescono più a suscitare l’interesse di grandi e piccini, come negli anni ottanta. Prova ne sia il calo, in termini assoluti, riscontrato nel periodo 2010-2015, in cui il biglietto al botteghino, invece, aumenta da dieci a tredici euro, sia del numero delle rappresentazioni sia del relativo afflusso di pubblico.
Succede nel Centro Italia, in particolare nel Lazio e in Toscana, roccaforti a tradizione circense, mentre riscontra successo nel Nord Ovest, soprattutto in Piemonte e Lombardia, che rappresenta l’ultimo (unico) baluardo del circo italiano.
Sarà forse per l’attuale trasformazione degli spettacoli, da quelli tradizionali a nuovi format artistici molto evoluti e lontani anni luce dai modelli storici obsoleti, realizzati senza l’esibizione degli animali. Il passaggio definitivo a questo tipo di rappresentazioni - il disegno di legge numero 2287-bis del 16 marzo scorso (o Riforma Franceschini, appunto) ne disciplina la dismissione - avrà, però, dirette conseguenze sull’intera filiera e sulla tenuta della produzione circense.
E peserà, certamente, sul potenziale decremento della base occupazionale e sulla futura collocazione degli animali dismessi, da ospitarsi negli zoo, attualmente saturi, o presso i Centri di recupero per animali esotici, a oggi non in grado di assorbire nuovi esemplari.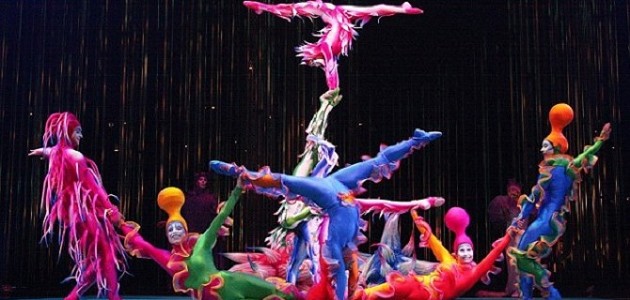 Ma potrebbe anche generare un risparmio sia sui costi in termini di sostentamento alimentare sia su quelli necessari a effettuare le visite sanitarie, oltreché su quelli per la formazione del personale (ex) deputato all’addestramento degli animali.
Ma potrebbe anche generare un risparmio sia sui costi in termini di sostentamento alimentare sia su quelli necessari a effettuare le visite sanitarie, oltreché su quelli per la formazione del personale (ex) deputato all’addestramento degli animali.
Tanto, messo così, sul circo non si investe più: allo stato, infatti, i contributi del Fondo unico per lo spettacolo destinati al complesso delle attività circensi, sono diminuiti, o dimezzati come quelli per i circhi con animali, mentre aumentano quelli per i circhi contemporanei (e senza animali), tipo il Cirque du soleil. E così, dopo centoquarantasei anni, anche Barnum cala il sipario.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Che la parità di genere sia ancora tutta da venire è un dato di fatto. Ma che nella discriminazione delle donne intervenga, pure, l’identità religiosa è un elemento appena accennato e difficile da dimostrare. Succede, come testimonia la ricerca “Donne dimenticate: l’impatto dell’islamofobia sulle donne musulmane”, realizzata dalla rete europea ENAR, alle donne provenienti da paesi a maggioranza musulmana giunte in Italia.
Riconducibile, banalmente, alla presenza del velo, la segregazione è evidente, soprattutto, in ambito lavorativo, con due effetti: alcune accettano di non indossarlo, altre reagiscono autoescludendosi.
Attacchi verbali e fisici ed episodi di intolleranza contro di loro si verificano con una frequenza elevata, in media una o due volte a settimana nei confronti della stessa donna. Nonostante nel Belpaese non ci siano leggi che limitino l’uso di abiti o simboli religiosi nei luoghi di lavoro, a parte due rigurgiti rimasti tali, nel 2009 e nel 2011, che avrebbero voluto vietare l’utilizzo di burqa e niqad negli spazi pubblici, il velo scatena l’odio di chi si basa su pregiudizi antimusulmani: commenti sprezzanti o sguardi biechi in luoghi pubblici abbinati a tentativi di farlo togliere con la forza.
E se, sulla carta, quasi tutti i datori di lavoro negano di avere una qualche ostilità verso l’islam o il velo, di fatto, per le donne musulmane è difficile trovare un lavoro che prevede il contatto con il pubblico, giustificando l’esclusione con la poca apertura dei clienti e le conseguenti potenziali perdite economiche.
Fatto sta che, considerato anche che un insieme di fattori, quali una mancata padronanza della lingua italiana, una scarsa conoscenza delle istituzioni e il mancato riconoscimento di titoli di studio stranieri, spiegano gli svantaggi del caso, le donne musulmane registrano la percentuale più bassa del tasso di disoccupazione e quella più alta di inattività fra tutte le donne straniere presenti nello Stivale. Il brutto però, è che mancano dati certi. Le forze dell’ordine non raccolgono elementi sulla religione o sull’etnia delle vittime (prova ne sia l’inesistenza di alcuna segnalazione, negli ultimi cinque anni, riguardanti le donne musulmane) e così, a oggi, si registra una sola azione legale relativa a un caso di discriminazione sul lavoro.
Il brutto però, è che mancano dati certi. Le forze dell’ordine non raccolgono elementi sulla religione o sull’etnia delle vittime (prova ne sia l’inesistenza di alcuna segnalazione, negli ultimi cinque anni, riguardanti le donne musulmane) e così, a oggi, si registra una sola azione legale relativa a un caso di discriminazione sul lavoro.
Per fortuna, la Corte d’appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Lodi che aveva salvato il datore di lavoro giustificando la sua “preferenza (come) business oriented”, ha dato ragione a Sara Mahmoud. La ragazza col velo che voleva fare l’hostess.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Arrivano alla fatidica prima volta a diciassette anni compiuti e, nella maggior parte dei casi, con un partner al quale sono legati da un rapporto affettivo. Tanto di cappello ai giovani (dai dodici ai ventiquattro anni) italiani, intervistati dal Censis nell’indagine “Millennials e vaccinati?”, che però, quanto al bagaglio di informazioni riguardanti la sessualità con cui si presentano al primo appuntamento, sono gravemente carenti.
Sempre pronti, almeno, a evitare gravidanze indesiderate ma poco (o per nulla) attenti a proteggersi dalle infezioni o malattie sessualmente trasmissibili. Motivando la scelta con giustificazioni troppo inconsapevoli, finanche a sostenere che certe patologie sono contagiose solo se si hanno rapporti con le prostitute o collocando metodi specificamente anticoncezionali fra gli strumenti utili a prevenire le malattie.
Eppure, tutti ammettono di averne sentito parlare, prima nei media soprattutto i giovani del Centro e delle Isole e poi a scuola, principalmente quelli del Nord Est e del Nord Ovest, ma la menzione più ricorrente è all’Aids. Pochi sanno, forse perché solo il 9 per cento circa di loro considera fonte di informazione i professionisti della salute e solo il 41 per cento vi si è recato in visita, della sifilide o del molto diffuso papillomavirus, causa principale di tumori. Troppi (ancora) credono che questo virus colpisca solo le donne o che possa essere trasmesso attraverso trasfusioni di sangue e scambi di siringhe, attraverso l’uso di servizi igienici comuni o di oggetti contaminati. C’è ancora chi pensa possibile, per fortuna una percentuale molto contenuta, il contagio attraverso il contatto ravvicinato con un bacio, una stretta di mano o uno starnuto.
Però c’è una quota consistente di chi ha le informazioni giuste, che conosce l’esistenza del vaccino, soprattutto fra i più piccoli e fra le ragazze, con tutta probabilità perché dal 2008 per quelle del dodicesimo anno d’età è disponibile gratuitamente, grazie al contributo di genitori e medici di famiglia. Responsabili entrambi delle propensioni e dei comportamenti dei giovani che risentono dell’atteggiamento culturale complessivo che, rispetto alla vaccinazione, non è tendenzialmente troppo favorevole, soprattutto al Sud e nelle Isole contrariamente al Nord Est, in cui il vaccino contro l’Hpv è riconosciuto dai giovani come un ottimo antidoto di prevenzione. Gli altri indicano di non fidarsi per paura degli effetti collaterali, perché la protezione dura poco e perché non elimina la necessità di effettuare il pap test.
Tanto per chiarire, “le infezioni sessualmente trasmesse costituiscono un insieme di malattie molto diffuse che interessano milioni di individui, ogni anno, in tutto il mondo. Esse hanno un forte impatto sia a livello individuale che di sanità pubblica e, tra l’altro, favoriscono l’acquisizione e la trasmissione dell’HIV”, dice il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Ranieri Guerra.
 E “l’insufficiente conoscenza di queste infezioni e di come prevenirle è tra i principali problemi”, spiega il professore ordinario di Endocrinologia dell’università La Sapienza di Roma, Andrea Lenzi. Che continua: “La maggior parte delle informazioni che i giovani hanno derivano, infatti, dagli amici, seguiti dai media e dai social network, lasciando spazio a molta spazzatura sul web. Parlando di papillomavirus e di maschi, per esempio, spesso i ragazzi non sospettano minimamente di poter essere portatori di un’infezione che può anche causare un tumore”.
E “l’insufficiente conoscenza di queste infezioni e di come prevenirle è tra i principali problemi”, spiega il professore ordinario di Endocrinologia dell’università La Sapienza di Roma, Andrea Lenzi. Che continua: “La maggior parte delle informazioni che i giovani hanno derivano, infatti, dagli amici, seguiti dai media e dai social network, lasciando spazio a molta spazzatura sul web. Parlando di papillomavirus e di maschi, per esempio, spesso i ragazzi non sospettano minimamente di poter essere portatori di un’infezione che può anche causare un tumore”.
Ovviamente “ciò richiama l’importanza di attivare canali di informazione pensati specificamente per i giovani, per proteggere la loro salute, la loro fertilità, il loro futuro”, conclude il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi.
- Dettagli
- Scritto da Administrator

di Tania Careddu
L’Italia è il paese con la popolazione più vecchia d’Europa – il 21,4 per cento è over sessantacinque – ma non è un paese per vecchi. Perché, per la prima volta nella sua storia, la copertura dei servizi e degli interventi per anziani presenta tutti segni negativi: la spesa di comuni e regioni per i servizi sociosanitari diretti ai meno giovani è diminuita così come le persone della terza età prese in carico.
Le casse vuote delle finanze pubbliche, che costringono le famiglie con un anziano caro (soprattutto non autosufficiente) a dare fondo alle risorse personali private, trascinano il Belpaese in un ritardo grave nel maturare un proprio sistema di assistenza a lungo termine. Sistema in cui domiciliarità e residenzialità, le due vie nostrane per sostenere gli anziani, presentano pesanti limiti ed enormi inadeguatezze, con una fisionomia, a livello nazionale, a macchia di leopardo.
L’assistenza domiciliare, a cui ricorrono due milioni e mezzo di anziani, infatti, scarseggia e diminuisce in tutte le aree geografiche del Paese, eccezion fatta per centro e isole, l’assegnazione di voucher, assegni di cura e buoni sociosanitari è stazionaria e calano, anche, i beneficiari delle indennità di accompagnamento. Per non parlare delle residenze, nelle quali diminuiscono - dal 2009 al 2013, si sono ridotti del 23,6 per cento - i posti letto, occupati da duecentosettantotto mila anziani, concentrati per lo più al Nord, e pure il personale impegnato.
Tempi di attesa lunghi, dai novanta ai centottanta giorni, e rette variabili e disomogenee (i dati al riguardo sono scarsi e poco aggiornati), con un range che va dagli ottanta ai centoquarantatre euro giornalieri, a seconda dell’intensità assistenziale.
“Lo scenario demografico che abbiamo di fronte non lascia spazio ai tentennamenti. L’Italia è già il paese più vecchio d’Europa con il 21,4% degli italiani over 65 e il progredire del livello di longevità, impone a tutti, soprattutto alle istituzioni ma anche a noi attori sociali, una risposta perché sta crescendo in modo esponenziale la domanda di assistenza”, fa sapere il presidente dell’Auser, Enzo Costa, che ha redatto il dossier “Domiciliarità e residenzialità per l’invecchiamento attivo”.
Anche perché, al già insufficiente numero di strutture sparse sul territorio nazionale - poco più di dodici mila - si aggiungono le centosettantasei sottoposte a sequestro o a chiusura e il malfunzionamento per comportamenti illeciti di quelle ancora attive.
 Dal 2014 al 2016, i NAS hanno riscontrato più di mille e ottocento non conformità, circa tremila persone segnalate all’autorità giudiziaria o amministrativa, hanno effettuato sessantotto arresti, e attribuito oltre tremila sanzioni penali e più di duemila amministrative per oltre un milione e duecentomila euro.
Dal 2014 al 2016, i NAS hanno riscontrato più di mille e ottocento non conformità, circa tremila persone segnalate all’autorità giudiziaria o amministrativa, hanno effettuato sessantotto arresti, e attribuito oltre tremila sanzioni penali e più di duemila amministrative per oltre un milione e duecentomila euro.
Eppur qualcosa si muove, prova ne sia il disegno di legge approvato alla Camera ‘Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno ai minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità’. Per porre fine a una violenza senza età.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Eccidi riassunti in numeri ma privi di identità. Questo è il volto dell’invasione - mediatica più che reale - del Paese da parte degli immigrati. Il 2016 è stato l’anno della ‘grande immigrazione’ sui media, occupatasi del tema inventato con circa dieci notizie al giorno e con un aumento di oltre il 10 per cento rispetto al 2015.
Articoli, titoli e servizi televisivi sull’argomento sono sempre più frequenti ma vengono presentati a basso volume. Senza clamore, come un fenomeno ormai ‘normale’: se ne parla con continuità, in modo strutturale e pervasivo. Non più un’emergenza, dunque, ma una ‘questione’ politica, sul piano della comunicazione mediata, tradizionale. Sull’altro, quella immediata, senza filtro, dei social, l’immagine degli immigrati è estremizzata, fino a raggiungere dimensioni e linguaggi profondamente intolleranti.
La normalizzazione del fenomeno, nel sistema dei vecchi mezzi di comunicazione, ha portato a un abbassamento dei toni: il discorso d’odio, che dilaga nei social network e trova alimento nella cattiva comunicazione, è lungi ormai dall’essere pronunciato o scritto da quell’informazione in cui la politica, nell’anno appena trascorso, è stata la protagonista, in un caso su due, del racconto mediatico del fenomeno migratorio. Una mediazione che ha generato una sorta di ‘metabolizzazione’, spesso sfociato in conflitto aperto, a colpi di insulti razzisti e violenti.
I migranti come pedine del futuro dell’Europa, le rotte che percorrono, il terrorismo come serpe in seno, l’accoglienza e i flussi migratori rimangono, secondo quanto si legge nel rapporto “Notizie oltre i muri”, redatto, come ogni anno, dall’Associazione Carta di Roma, i temi al centro dell’agenda mediatica ai quali, nel 2016, si aggiunge un’accresciuta visibilità per la dimensione sociale e culturale dei migranti.
Ma alla loro voce e al racconto diretto delle loro storie non è destinato che il 3 per cento dei servizi giornalistici. Interpellati solo nelle tragedie o in cornici di degrado, i loro interventi sono piuttosto brevi e i migranti interscambiabili fra di loro: trattati come una categoria senza facce, stigmatizzati in gruppi massificanti, sono vittime senza nome e, perciò, senza identità.
Esponendoci tutti, spettatori alla meno peggio dicotomizzati fra accuse di razzismo ed eccesso di buonismo all’insegna della libertà di espressione, al vero rischio dell’indifferenza. A una distanza che si accentua di fronte alla spersonalizzazione che ci rende spettatori passivi di ciò che accade, di altri esseri umani. Diversi eppure uguali a noi.
