Politica
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
Un pareggio che è più pesante di una sconfitta. Questo il risultato del voto bicamerale sul federalismo municipale, cavallo di battaglia della Lega ed effettivo ago della bilancia in questo quarto governo Berlusconi, nato con numeri schiaccianti ora sempre più agonizzante sull’aritmetica. Quindici si contro quindici no (compreso quello del futurista Mario Baldassarri) hanno respinto il testo voluto dal Carroccio e modificato dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ma se inizialmente Bossi tuonava “se non ci sarà una maggioranza politica il rischio delle elezioni è concreto”, ora, dopo appena 24 ore, la cantilena del senatur è cambiata e si fa più cauta sulla prospettiva dl voto anticipato.
Il decreto sul federalismo municipale ha infatti ancora una chance di sopravvivenza nel suo cammino istituzionale e, nonostante la legge dei numeri sembri momentaneamente avversa, sono ancora un paio le vie che l’Esecutivo può percorrere per esaudire i desideri del Carroccio. La prima è quella di portare direttamente il testo al vaglio delle Camere, mentre la seconda suggerirebbe di tornare in Consiglio Dei Ministri per la delibera finale - che però perderebbe le modifiche volute dall’Anci - mentre una terza soluzione, quella che vedrebbe ripartire i lavori da capo, sembra sia già stata scartata per gli ovvi motivi di tempo.
Stando alle indiscrezioni Berlusconi e i suoi hanno già optato per la seconda possibilità, in aperto contrasto con quanto dice il regolamento della Bicamerale all’articolo 7, ovvero che a parità di voti il provvedimento in esame è da considerarsi respinto. Tutto pur di far passare il provvedimento che, nelle balorde intenzioni dei suoi promotori, nacque come antidoto al centralismo romano.
Usare il passato remoto è d’obbligo in quanto, in questi lunghi anni di gestazione “la madre di tutte le riforme” come la definiscono i leghisti, ha subito diverse metamorfosi e, così come si presenta attualmente, non è esattamente quel baluardo di virtù amministrativa che ci è stato presentato. Umberto Bossi e le sue camicie verdi pontificavano sul fatto che la riforma avrebbe rappresentato un risparmio per le tasche degli italiani, con taglio netto alle tasse, mentre gli amministratori locali (sindaci, governatori e quant’altro) sarebbero stati sottoposti ad un più diretto e ravvicinato controllo da parte dei cittadini.
Inutile dire che dai tempi di “Roma ladrona” la musica è cambiata parecchio e che, di conseguenza, anche il piano originario della riforma ha seguito gli eventi: se infatti l’obiettivo primario erano allora le amministrazioni rosse e democristiane, ree di scialacquare immeritatamente le risorse pubbliche, ora moltissimi comuni (anche al di sotto del Po) sventolano il vessillo del sole delle Alpi e la necessità di batter cassa dopo la cura Tremonti diventa una priorità dinanzi al perdurare della crisi economica.
 Se infatti la parola d’ordine era inizialmente “tagliare gli sprechi”, ora, dinanzi alla prospettiva di dover togliere ai cittadini anche i servizi più essenziali, le continue promesse su un’improbabile bengodi fiscale si sono trasformate in versioni rivedute e corrette delle solite imposte locali. Affitti, Irpef, tassa sui rifiuti: tutti balzelli che subiranno un aumento in favore delle entrate municipali, mentre verrà istituita la possibilità di applicare una “imposta di scopo” al fine di provvedere ai bisogni specifici del comune. Abolita poi platealmente l’Ici, questa verrà sostituita dall’Imu, Imposta Municipale Unica, che avrà un'aliquota del 0,76%, ma i comuni potranno ritoccarla in eccesso dello 0,3%, dello 0,2% se l'immobile è stato dato in affitto.
Se infatti la parola d’ordine era inizialmente “tagliare gli sprechi”, ora, dinanzi alla prospettiva di dover togliere ai cittadini anche i servizi più essenziali, le continue promesse su un’improbabile bengodi fiscale si sono trasformate in versioni rivedute e corrette delle solite imposte locali. Affitti, Irpef, tassa sui rifiuti: tutti balzelli che subiranno un aumento in favore delle entrate municipali, mentre verrà istituita la possibilità di applicare una “imposta di scopo” al fine di provvedere ai bisogni specifici del comune. Abolita poi platealmente l’Ici, questa verrà sostituita dall’Imu, Imposta Municipale Unica, che avrà un'aliquota del 0,76%, ma i comuni potranno ritoccarla in eccesso dello 0,3%, dello 0,2% se l'immobile è stato dato in affitto.
Si rassegnino quindi gli irriducibili della secessione: federalismo significa solo più tasse per tutti. Non pensino però di sfangarla quelli amano barare sulla denuncia dei redditi. Se domani il disegno dovesse passare il vaglio della Bicamerale, è previsto un inasprimento dei controlli fiscali incentivato dal fatto che i comuni che promuoveranno iniziative di contrasto all’evasione saranno premiati con il 50% delle somme recuperate, anche se queste non fossero state riscosse a titolo definitivo. A questi soldi si andrebbe poi ad aggiungere il 75% delle sanzioni sugli immobili fantasma non regolarizzati entro il 31 marzo.
Un gigantesco prelievo quindi, che andrà a toccare anche i non residenti: con l’istituzione della tassa di soggiorno voluta dall’evanescente ministro del Turismo Brambilla - 5 euro per ogni notte trascorsa in albergo - le casse comunali potranno finanziare opere pubbliche e preservare beni artistici e gli amministratori potranno incassare liquidità senza incidere sul consenso elettorale. Un provvedimento che si pone in aperta antitesi con lo spirito contenuto nella riforma del Titolo V e con l’iniziale intenzione di rendere il rapporto elettore-amministratore più coercitivo, che mira a ingrassare le casse comunali facendo leva in buona misura su coloro i quali, pur costretti a pagare, non potranno manifestate il loro consenso, o più facilmente dissenso, nel voto amministrativo.
Questo il capolavoro legislativo della Lega: per alcuni solo una nuova ondata di tasse, per altri la tanto attesa emancipazione del centralismo fiscale romano. Un porcellum tributario che, anche se venisse tradotto in decreto legge, rischierebbe il marchio di incostituzionalità cui tutti poi potrebbero appellarsi per non pagare le tasse imposte. Fucili leghisti permettendo, of course.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Eugenio Roscini Vitali
di Eugenio Roscini Vitali
Anche quest’anno in Italia la "Giornata della memoria" in ricordo delle vittime della Shoah è stata carica di eventi: incontri, mostre, musica, proiezioni e dibattiti sulle persecuzioni, sul negazionismo e su quella che può essere considerata come la più grande tragedia dell’umanità. A parlare sono stati i pochi superstiti ancora vivi, i parenti della famiglia segnate dalle deportazioni e i discendenti dei martiri dell’Olocausto, gli ebrei di seconda e terza generazione, quelli nati trenta o quarant’anni dopo il parossismo distruttivo della Shoah e dopo la nascita dello Stato di Israele.
Gli ebrei e non ebrei che hanno scelto di vivere il “dovere della Memoria” come sentinelle che non vogliono lasciare spazio a chi vuole dimenticare o a chi vuole diffondere un’idea distorta di quel progetto distruttivo che tra il 1933 e la primavera del 1945 attraversò l’Europa intera: il piano deciso e concretizzato dal Terzo Reich che la Germania nazista attuò anche grazie alla collaborazione, parziale o totale, di governi e movimenti politici che condividevano gli stessi fini.
Nell’Italia del Novecento la persecuzione antiebraica conobbe due momenti ben distinti: una prima fase che va dal 14 febbraio 1938 al luglio del 1943 e che ha inizio con il censimento sulla religione professata dai dipendenti del ministero degli Interni, censimento ad impostazione razziale ripetuto a livello nazionale il 22 agosto dello stesso anno. La seconda fase fu quella degli arresti e delle deportazioni, che ebbero inizio tra il 15 e il 30 settembre 1943, quando i nazisti arrestarono 22 ebrei di Merano e ne uccisero quasi 54 sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.
 Il mese successivo venne attuata la prima retata, nel Ghetto di Roma: alle 5:30 del 16 ottobre 356 soldati di un reparto specializzato delle truppe tedesche diedero inizio alla “Judenoperation”; circa cento invasero le strade del Portico d’Ottavia, gli altri ispezionarono le 26 zone operative in cui il Comando tedesco di Villa Volkonsky aveva diviso la capitale.
Il mese successivo venne attuata la prima retata, nel Ghetto di Roma: alle 5:30 del 16 ottobre 356 soldati di un reparto specializzato delle truppe tedesche diedero inizio alla “Judenoperation”; circa cento invasero le strade del Portico d’Ottavia, gli altri ispezionarono le 26 zone operative in cui il Comando tedesco di Villa Volkonsky aveva diviso la capitale.
Quando il gigantesco rastrellamento si concluse furono 1.024 gli ebrei romani catturati, 441 nuclei familiari, tra lori quasi 207 bambini. Due giorni dopo, alle 14:05 del 18 ottobre, diciotto carri bestiame piombati con a bordo 824 ebrei partirono dal binario 1della stazione Tiburtina, destinazione Auschwitz-Birkenau, in territorio polacco; di loro torneranno a case quindici uomini, una donna e nessuno degli oltre duecento bambini.
In Italia, tra il 16 ottobre 1943 e 2 maggio 1945, giorno della capitolazione tedesca e fascista, gli ebrei arrestati, deportati e massacrati furono più di ottomila, dei quali 2091 nella sola Roma, liberata il 4 giugno 1944. Le autorità italiane cominciarono ad arrestare e internare gli ebrei dal 1° dicembre 1943; furono i tedeschi a riconoscere alle milizie della Repubblica Sociale Italiana (RSI) l’autorità nella gestione degli arresti e nel trasferimento dei prigionieri dai campi provinciali al campo di concentramento e di transito per ebrei e oppositori politici di Fossoli, a pochi chilometri da Carpi, aperto il 5 dicembre 1943 in ottemperanza a quanto disposto dalla Carta di Verona e dall’Ordinanza di Polizia n. 5 inviata a tutti i Capi delle Province Libere a firma del Ministro degli Interni, Giudo Buffarini.
l primi ebrei e i dissidenti arrestati dagli italiani vennero consegnati alle autorità tedesche di Fossoli il 5 febbraio 1944, su ordine del prefetto di Reggio Emilia e dietro sollecitazione del capo dell’Ordnungspolizei di Bologna; il 19 e il 22 febbraio 1944 partirono i primi due convogli di deportazione per Bergen-Belsen e Auschwitz.
 Prima della chiusura del campo e del trasferimento delle attività di concentramento nella struttura nazionale di Bolzano-Gries, avvenuto il 2 agosto 1944, per Fossoli transiteranno circa cinquemila internati, 2.844 dei quali ebrei, deportati che avranno come tragiche destinazioni i campi Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mauthausen, Ravensbruck; l’ultimo convoglio di deportati ebrei lascerà la Risiera di San Sabba il 24 febbraio 1945, a quasi un mese dalla liberazione del campo di Auschwitz.
Prima della chiusura del campo e del trasferimento delle attività di concentramento nella struttura nazionale di Bolzano-Gries, avvenuto il 2 agosto 1944, per Fossoli transiteranno circa cinquemila internati, 2.844 dei quali ebrei, deportati che avranno come tragiche destinazioni i campi Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mauthausen, Ravensbruck; l’ultimo convoglio di deportati ebrei lascerà la Risiera di San Sabba il 24 febbraio 1945, a quasi un mese dalla liberazione del campo di Auschwitz.
Dal 14 luglio 1938, giorno in cui venne pubblicazione su Il giornale d’Italia “Il fascismo e i problemi della razza”, documento programmatico sottoscritto sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare da gruppo di studiosi e docenti delle Università italiane, in Italia vennero perseguitati circa 40 mila ebrei, 35 mila dei quali riuscirono a sfuggire alla deportazione fuggendo in Svizzera o vivendo in clandestinità, protetti dagli antifascisti e da chi si oppose allo sterminio.
Tra le fila fasciste della prima ora si contarono numerosi italiani di religione ebraica (furono 350 gli ebrei che parteciparono alla marcia su Roma e 746 erano iscritti ai Fasci Italiani di Combattimento) e diversi di loro morirono durante le manifestazioni di piazza a sostegno del movimento (Duilio Sinigaglia, Gino Bolaffi e Bruno Mondolfo furono dichiarati martiri fascisti). Anche grazie al trasformismo dello stesso Mussolini, che scrisse sul Popolo d’Italia che «in Italia non si fa assolutamente nessuna differenza fra ebrei e non ebrei; in tutti i campi, dalla religione, alla politica, alle armi, all'economia», nei primi anni 30’ una considerevole parte dell’elite culturale italiana si lascio affascinare dalle idee antisemite della Germania nazista e dell’Europa orientale.
 Il “Manifesto degli scienziati razzisti”, noto anche come "Manifesto della Razza", pubblicato in forma anonima sul Giornale d'Italia il 15 luglio 1938 con il titolo “Il Fascismo e i problemi della razza” e poi ripubblicato sul numero uno della rivista La difesa della razza il 5 agosto 1938 a firma di dieci scienziati italiani, ebbe un ruolo non indifferente nella Dichiarazione sulla Razza emessa dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1938, documento dal quale prenderanno forma i Regi decreti e le cosiddette leggi razziali sostenute da intellettuali e personalità di spicco della società civile, personaggi illustri, o destinati a diventarlo, che contribuiranno in modo decisivo all’affermazione del razzismo e dell’antisemitismo in Italia.
Il “Manifesto degli scienziati razzisti”, noto anche come "Manifesto della Razza", pubblicato in forma anonima sul Giornale d'Italia il 15 luglio 1938 con il titolo “Il Fascismo e i problemi della razza” e poi ripubblicato sul numero uno della rivista La difesa della razza il 5 agosto 1938 a firma di dieci scienziati italiani, ebbe un ruolo non indifferente nella Dichiarazione sulla Razza emessa dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1938, documento dal quale prenderanno forma i Regi decreti e le cosiddette leggi razziali sostenute da intellettuali e personalità di spicco della società civile, personaggi illustri, o destinati a diventarlo, che contribuiranno in modo decisivo all’affermazione del razzismo e dell’antisemitismo in Italia.
La promulgazione delle leggi razziali fu accompagnata da una campagna di stampa aggressiva e denigratoria, mirata a diffondere un senso di diffidenza e di odio contro quella che il regime definiva la “marmaglia giudaica”; una campagna di stampa che, per ampiezza e capillarità, non poté non essere ignorata da vasti strati della popolazione.
Attraverso le pagine dei quotidiani, il regime riuscì a veicolare un’immagine falsata degli ebrei, che doveva imprimersi nella coscienza collettiva come quella dell'elemento estraneo e inassimilabile; gente considerata diversa dalla cosiddetta “stirpe italica” e dalla quale bisognava guardarsi. Accuse che nel tempo agirono come veleno, che trasformarono il vicino di casa in una persona capace delle più sordide trame, subdola e pronta a tradire la comunità in cui viveva e per questo pericolosa.
 Nell’arco di pochi mesi molte testate nazionali e locali diedero il via ad un attacco di rara violenza, con articoli spesso aggressivi che propagandavano il carattere autenticamente italiano del razzismo fascista e riprendevano le idee espresse da Paolo Orano nel libro “Gli ebrei in Italia”. Spinto dal Ministero della Cultura Popolare, il giornalismo italiano, fino ad allora inerte ed estraneo al sentimento antisemita, fu trascinato dai giornali d’avanguardia: Il Popolo d’Italia; Il Regime fascista; Il Tevere; Cremona nuova; Giornalissimo; Quadrivio; Il telegrafo; Il Mezzogiorno, quotidiano di Napoli.
Nell’arco di pochi mesi molte testate nazionali e locali diedero il via ad un attacco di rara violenza, con articoli spesso aggressivi che propagandavano il carattere autenticamente italiano del razzismo fascista e riprendevano le idee espresse da Paolo Orano nel libro “Gli ebrei in Italia”. Spinto dal Ministero della Cultura Popolare, il giornalismo italiano, fino ad allora inerte ed estraneo al sentimento antisemita, fu trascinato dai giornali d’avanguardia: Il Popolo d’Italia; Il Regime fascista; Il Tevere; Cremona nuova; Giornalissimo; Quadrivio; Il telegrafo; Il Mezzogiorno, quotidiano di Napoli.
In conformità al “nuovo corso” voluto da Benito Mussolini, i quotidiani italiani accentuarono progressivamente i toni e dal 15 luglio 1938 il “problema della razza” venne affrontato direttamente, con la pubblicazione di numerosi articoli di carattere scientifico, rivolti a chiarire il concetto di razza e la necessità di difendere la purezza della “stirpe italiana”.
Questi i titoli più significativi: "Razze e razzismo", "Origini ed omogeneità della razza italiana", "L’unità etnica italiana", "I temi per la difesa della razza fissati dal Segretario di Partito", "Punti fermi sul giudaismo", pubblicati dal Corriere della Sera; "Il razzismo italiano data dall’anno 1919", "Un ebreo contro gli ebrei", sul Popolo d’Italia; "Nostro razzismo", "La difesa della razza è un diritto e un dovere", da Il Regime fascista; "Pietismo fuori posto", su La Stampa di Torino.
La più immane delle tragedie della storia dell’umanità ebbe dunque i suoi teorici, i suoi aguzzini, i suoi doppiogiochisti e i suoi propagatori. E oggi, purtroppo, i suoi tifosi travestiti e i suoi negazionisti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
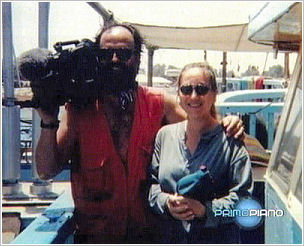 di Alessandro Iacuelli
di Alessandro Iacuelli
La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti riaprirà le indagini sulla morte di Ilaria Alpi, all'interno della più ampia inchiesta sulle cosiddette "navi dei veleni" e sui traffici transfrontalieri di rifiuti tossici. Lo si legge in una nota del presidente della Commissione Gaetano Pecorella, che sottolinea: "L'audizione del maresciallo Scimone, che ha operato in collaborazione con il capitano De Grazia e con i magistrati di Reggio Calabria, ha consentito alla Commissione di acquisire una notizia di estremo interesse: nel corso di una perquisizione nei confronti di Giorgio Comerio è stata ritrovata, in un fascicolo rubricato con il nome Somalia relativo alla smaltimento dei rifiuti, la copia di un dispaccio dell'agenzia Ansa sulla morte di Ilaria Alpi. Poiché in quel momento nulla consentiva di collegare la morte della giornalista e del suo operatore al traffico dei rifiuti con la Somalia, il rinvenimento di questo documento e la sua collocazione richiedono un ulteriore e penetrante approfondimento".
Racconta Pecorella: "La cosa che abbiamo trovato assolutamente importante sul piano dell'inchiesta è che non vi sarebbe stato in quel momento alcun motivo di collegare la Somalia, come questione di cui si occupava Comerio, con la morte di Ilaria Alpi. In quel momento nessuno ha pensato alla questione dei rifiuti. Vorremmo capire perchè si è instaurato questo rapporto nella testa di Comerio".
Una strana osservazione, quella di Pecorella. Che Comerio si occupasse di rifiuti è già noto da anni. Ricordiamo che alcuni suoi documenti furono trovati a bordo del relitto della Jolly Rosso, spiaggiata ad Amantea. Per chi non lo sapesse, Giorgio Comerio è un ingegnere di Busto Arsizio, ma residente in diverse parti del mondo: sull'isola britannica di Guernsey, a Malta, a Lugano e in Italia, in una bella villa di Garlasco in provincia di Pavia.
Balzò agli onori nella prima metà degli anni '80, quando fu espulso dal Principato di Monaco per traffico d'armi, poiché riforniva di missili Exocet i generali argentini durante la guerra delle Falkland. Definisce se stesso un "semplice esperto di navi e di localizzazioni". Negli ultimi anni ha messo in piedi, con un socio austriaco e altri personaggi, la società Oceanic Disposal Management, poi è andato in giro per il mondo ad offrire una soluzione davvero originale per la sistemazione delle scorie radioattive.
 Quelle stesse che i Governi non sanno dove mettere. L'ingegnoso progetto prevede il lancio, da navi appositamente riadattate, di siluri metallici, chiamati "penetratori", caricati di scorie radioattive vetrificate o comunque rese inerti. Secondo il progetto dell'ingegnere, i siluri si andrebbero a conficcare fra i cinquanta e gli ottanta metri al di sotto del fondale marino. I penetratori sono anche dotati di sonar che li rendono rilevabili per un eventuale recupero. Proprio la presenza dei sonar gli ha consentito di aggirare la legge, e far così considerare il suo sistema non come un trasferimento ai fondali marini del concetto di discarica, ma come un metodo di "deposito temporaneo".
Quelle stesse che i Governi non sanno dove mettere. L'ingegnoso progetto prevede il lancio, da navi appositamente riadattate, di siluri metallici, chiamati "penetratori", caricati di scorie radioattive vetrificate o comunque rese inerti. Secondo il progetto dell'ingegnere, i siluri si andrebbero a conficcare fra i cinquanta e gli ottanta metri al di sotto del fondale marino. I penetratori sono anche dotati di sonar che li rendono rilevabili per un eventuale recupero. Proprio la presenza dei sonar gli ha consentito di aggirare la legge, e far così considerare il suo sistema non come un trasferimento ai fondali marini del concetto di discarica, ma come un metodo di "deposito temporaneo".
Certo, esistono sia la Convenzione di Londra sia altre convenzioni internazionali che vietano lo scarico in mare dei rifiuti e dichiarano espressamente illegali questi piani, ma secondo le parole di Comerio "attraverso i penetratori le scorie vengono depositate non dentro il mare, ma sotto i fondali marini" e poi ricorda che "ci sono Nazioni che non hanno firmato la Convenzione, con cui è possibile lavorare". Su di lui sono in corso indagini anche in Italia, da molti anni. Indagini dalle quali è emersa la rete di affari che ha proceduto per decenni con un'alternativa ai penetratori: le cosiddette "navi a perdere". In pratica si affonda dolosamente la nave, con l'intero carico pericoloso, simulando un incidente. Ancora oggi, non si sa quante siano di preciso le navi dolosamente affondatenel Mediterraneo.
Queste considerazioni, fanno anche parte del patrimonio della Commissione Ecomafie, fin dalla XV legislatura. Ci si potrebbe quindi chiedere come mai Pecorella non ne fosse al corrente. Però una novità c'è davvero: dopo il collegamento, già dimostrato, tra la morte di Ilaria Alpi e le attività in Africa del faccendiere italiano Giancarlo Marocchino, ora emerge la prova documentale di un collegamento con la figura di Giorgio Comerio.
Dal mare somalo ancora oggi affiorano, per galleggiamento, bidoni e cisterne. Vengono affondati pieni, poi si svuotavano per la corrosione, e tornano a galla, o vengono spinti a riva. Sulla costa di Boosaaso i tecnici dell’Agenzia per l'Ambiente dell'Onu rilevarono, nel 1994, altissime concentrazioni di sostanze tossiche. Concentrazioni tanto elevate che li indussero, per paura di essere contaminati, ad allontanarsi celermente. Nell'ultima intervista compiuta prima di essere assassinata, la giornalista della Rai aveva chiesto al sultano di Boosaaso, Abdullah Muse Bogor, proprio notizie sulle sostanze pericolose gettate in mare o sepolte sotto l'asfalto della strada Garoowe-Boosaaso.
Il sultano aveva risposto: "Si, la gente ne parla. Ho sentito dire che sono state trovate cisterne in mare, o sepolte sotto l'asfalto, stia attenta però signorina da noi chi ha parlato del trasporto di armi, chi ha detto di aver visto qualcosa, poi è scomparso. In un modo o nell’altro, è morto". Ilaria venne falciata dalle pallottole dei kalashnikov pochi giorni dopo.
 In realtà in Somalia non c'era alcun traffico d'armi. In piena guerra civile, nonostanto lo sbarco delle truppe della cosiddetta "missione di pace" che non ha portato alcuna pace nel Corno d'Africa, nessuno pagava per avere quelle armi. Perchè erano le armi ad essere il pagamento. Pagamento per le tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi, di provenienza occidentale, inviati in Somalia. I clan somali in quel periodo non accettavano in pagamento né dollari né altre valute, ma preferivano ricevere direttamente armi e munizioni. Solo dopo l'omicidio Alpi, e il conseguente rischio che l'affare venisse troppo alla luce, si scelse di incrementare l'eliminazione dei rifiuti mediante le navi a perdere. Navi su cui stavano compiendo accertamenti sia il maresciallo Scimone sia il comandante Natale De Grazia, poi morto misteriosamente.
In realtà in Somalia non c'era alcun traffico d'armi. In piena guerra civile, nonostanto lo sbarco delle truppe della cosiddetta "missione di pace" che non ha portato alcuna pace nel Corno d'Africa, nessuno pagava per avere quelle armi. Perchè erano le armi ad essere il pagamento. Pagamento per le tonnellate di rifiuti tossici e radioattivi, di provenienza occidentale, inviati in Somalia. I clan somali in quel periodo non accettavano in pagamento né dollari né altre valute, ma preferivano ricevere direttamente armi e munizioni. Solo dopo l'omicidio Alpi, e il conseguente rischio che l'affare venisse troppo alla luce, si scelse di incrementare l'eliminazione dei rifiuti mediante le navi a perdere. Navi su cui stavano compiendo accertamenti sia il maresciallo Scimone sia il comandante Natale De Grazia, poi morto misteriosamente.
Per quanto riguarda l'inchiesta condotta dalla Commissione parlamentare, il WWF Italia già nel 2009, in audizione, aveva richiesto di rintracciare ed ascoltare Giorgio Comerio. E se Pecorella vede per la prima volta Comerio collegato a Ilaria Alpi, è bene ricordare che già nel 2004 il ministro per i rapporti col Parlamento Giovanardi aveva dichiarato: "Evidenti segnali di allarme si sono colti in alcune vicende giudiziarie da cui è emersa una chiara sovrapposizione tra queste attività illegali ed il traffico d’armi. Numerosi elementi indicavano il coinvolgimento nel suddetto traffico di soggetti istituzionali di governi europei ed extraeuropei, nonché di esponenti della criminalità organizzata e di personaggi spregiudicati, tra cui il noto Giorgio Comerio, faccendiere italiano al centro di una serie di vicende legate alla Somalia".
Per ora, Comerio si guarda bene dal rendersi reperibile, ma non si sa mai. Potrebbe anche succedere che, con i soliti 20 anni di ritardo minimo, ci si stia avvicinando allo scoperchiare la pentola su questo ennesimo mistero italiano. Perché anche per quanto riguarda le armi ed i rifiuti in Somalia, è bene aspettarsi fin da ora che venga alla luce più made in Italy di quanto si possa immaginare.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Mariavittoria Orsolato
di Mariavittoria Orsolato
La Consulta in questi giorni ha dato parecchie soddisfazioni al livido popolo italiano. Poco prima di bocciare sonoramente il legittimo impedimento volto a scudare l’indagatissimo premier, i giudici della Corte costituzionale hanno giudicato ammissibili tre delle cinque proposte di referendum avviate in seguito alla liberalizzazione e alla privatizzazione di servizi energetici e di beni primari. I quesiti su cui i comitati promotori hanno raccolto ben un milione e mezzo di firme, vertono tutti sulla pubblicità dell’acqua e sullo spinoso ritorno al nucleare, tanto voluto dall’esecutivo ma che ancora divide gli italiani.
Grazie al parere positivo della Consulta, in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2011, si andrà alle urne per decidere se abrogare quanto fatto finora dal terzo esecutivo Berlusconi in materia di enti pubblici e nucleare. Il primo dei quattro quesiti che verranno proposti riguarda l’abrogazione dell’art. 23-bis della legge 166 del 2009 (servizi pubblici locali di rilevanza economica) contenuto in quella che allora venne definita “riforma Fitto”: nel testo si disponeva infatti che le vecchie e temute aziende municipalizzate, sovrane su tutti i servizi primari al cittadino, venissero smembrate a favore dei soggetti privati desiderosi di accaparrarsi una bella fetta di appalti pubblici.
Non si tratta solo di acqua infatti, con l’abrogazione del suddetto articolo si andrebbe a rivoluzionare l’assetto voluto solo due anni fa dal Governo in merito anche a tutti gli altri servizi pubblici locali cosiddetti “di rilevanza economica”: parliamo quindi di autobus, metropolitane, depurazione, fognature, raccolta dei rifiuti eccetera. Nel caso in cui, elezioni anticipate permettendo, le urne rendessero un sì, l’intero impianto della riforma Fitto verrebbe smantellato, ponendo un duro stop a liberalizzazioni e privatizzazioni.
Mentre i comitati pro acqua pubblica gioiscono, i più attenti e cinici osservatori del mercato giudicano la decisione della Consulta, se non come un suicidio economico, almeno come un gigantesco balzo indietro. Dalle colonne del quotidiano economico per antonomasia, il Sole 24 Ore, giunge infatti un monito ben circostanziato: “La cancellazione dell'intera riforma produrrebbe un ritorno all'epoca dell'in house, dello strapotere delle aziende pubbliche controllate dagli enti locali”.
 Orrore. La prospettiva di una parcellizzazione dei servizi pubblici primari non è certo meno orribile di quella che vede un ritorno del conflitto di interessi degli enti locali proprietari, regolatori ed erogatori dei servizi, con distribuzioni massicce di gettoni di presenza e inevitabili parentopoli annesse. Se infatti il referendum dovesse andare incontro alle richieste dei comitati pro acqua pubblica si ritornerebbe all’in-house voluto nel 2003 dal cosiddetto “lodo Buttiglione” che, in soldoni, significa l’affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta che però risulta essere controllata dall’ente pubblico stesso.
Orrore. La prospettiva di una parcellizzazione dei servizi pubblici primari non è certo meno orribile di quella che vede un ritorno del conflitto di interessi degli enti locali proprietari, regolatori ed erogatori dei servizi, con distribuzioni massicce di gettoni di presenza e inevitabili parentopoli annesse. Se infatti il referendum dovesse andare incontro alle richieste dei comitati pro acqua pubblica si ritornerebbe all’in-house voluto nel 2003 dal cosiddetto “lodo Buttiglione” che, in soldoni, significa l’affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta che però risulta essere controllata dall’ente pubblico stesso.
A governare era sempre Berlusconi ma è evidente che da allora le cose siano cambiate parecchio: a volere la legittimazione dell’in house nel 2003 era stata la Lega, nel tentativo di difendere ad oltranza le prerogative dei suoi amministratori locali, poi la crisi finanziaria americana ha sparigliato le carte in tavole e il centro-destra è tornato a preferire i privati alle nomenklature.
Insomma, qualsiasi sarà il responso referendario, gli italiani si troveranno di fronte una gestione della cosa pubblica problematica e conflittuale. Sia la privatizzazione che il monopolio delle municipalizzate sono nemici di un buon servizio al cittadino: se infatti la privatizzazione comporta esternalità negative a livello di prezzi al consumatore e di qualità dell’acqua, un ritorno alla gestione in house non alleggerirebbe le bollette dal momento che, orfani dell’ICI i comuni sono alla disperata caccia di introiti imponibili. Sarebbe poi ingenuo credere o anche solo sperare che le municipalizzate si comportino in modo eticamente più apprezzabile rispetto ai privati.
Certo a livello ideale i due soggetti sono gli estremi di una visione manichea della politica economica ma, nella realtà fattuale di quest’Italia allo sbando, il risultato della mediazione di entrambi va contro il cittadino/consumatore che si ritrova comunque costretto a pagare cifre esose per quello che a tutti gli effetti è un bene primario ed inalienabile. Scegliere il male minore è ormai il leitmotiv delle consultazioni elettorali e popolari degli ultimi 20 anni. E poi ci si lamenta dell’astensionismo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 Carlo Musilli
Carlo Musilli
Il vero problema non è l'impedimento in sé, quanto l'autorità cui viene affidato il potere di definirlo "legittimo". Quella della Corte di Cassazione sulla legge 51 del 2010 è stata definita una sentenza "salomonica", una bocciatura "parziale". Ma, a ben vedere, è qualcosa di più. Lo scudo che avrebbe permesso a Silvio Berlusconi di liberarsi del diritto penale, infatti, è stato amputato nelle sue parti più caratterizzanti e potenzialmente più utili al premier.
Partiamo dal comma 4 dell'articolo 1, quello che avrebbe permesso alla presidenza del consiglio di "autocertificare" l'impedimento del primo ministro a comparire in aula per sei mesi. Questo punto è stato considerato costituzionalmente illegittimo perché contrario, nientedimeno, all'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge".
Non basta. Della legge sul legittimo impedimento è stato giudicato inaccettabile anche il comma 3 dello stesso articolo 1, in cui si prescriveva al giudice di rinviare l'udienza "impedita" senza proferire verbo. Ed è proprio qui il punto. La consulta ha infatti stabilito che solo e soltanto un giudice può determinare se, a seconda dei casi contingenti, il legittimo impedimento sussiste o meno. Deve cioè valutare se i singoli impegni che affollano l'agenda del premier siano davvero tanto improrogabili da giustificare la sua mancata presenza in aula.
Niente da fare quindi per il cavaliere, neppure stavolta. Prima o poi dovrà rassegnarsi al fatto che il potere esecutivo non può sbarazzarsi di quello giudiziario. E' forse un concetto difficile da assimilare, ma in nessun paese democratico vincere le elezioni è garanzia di impunità.
Verrebbe da chiedersi allora per quale motivo la Corte Costituzionale non abbia bocciato in toto la legge, scegliendo piuttosto la strada della sentenza (parzialmente) interpretativa. Subito viene in mente l'italico cerchiobottismo, ma stavolta non c'entra. La verità è che non c'è nulla di incostituzionale nella semplice idea di "legittimo impedimento". Anzi, è previsto dal nostro Codice Penale.
 Qualsiasi cittadino può addurre delle ragioni per motivare la propria assenza in tribunale, ma queste devono essere ritenute valide dall'autorità giudiziaria. Ed è proprio qui che si misura l'assurdità dello scudo Berlusconiano. In sostanza, si pretendeva che la condizione stessa di presidente del Consiglio (e non i singoli impegni istituzionali) assicurasse la legittimità dell'impedimento. Il premier non avrebbe più avuto bisogno di alcuna giustificazione e, finalmente, sarebbe stato davvero al di sopra della legge.
Qualsiasi cittadino può addurre delle ragioni per motivare la propria assenza in tribunale, ma queste devono essere ritenute valide dall'autorità giudiziaria. Ed è proprio qui che si misura l'assurdità dello scudo Berlusconiano. In sostanza, si pretendeva che la condizione stessa di presidente del Consiglio (e non i singoli impegni istituzionali) assicurasse la legittimità dell'impedimento. Il premier non avrebbe più avuto bisogno di alcuna giustificazione e, finalmente, sarebbe stato davvero al di sopra della legge.
Certo, la sentenza della Consulta non elimina definitivamente tutti i rischi. Non è stato toccato, ad esempio, il comma 1 dell'articolo 2, in cui si aggiungono alla lista degli "impedimenti legittimi" anche le "attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo". Una dicitura un po' vaga che, se non venisse riformulata, potrebbe comprendere la stragrande maggioranza delle "attività" del primo ministro.
In ogni caso, non si può dire che la sentenza di due giorni fa non rappresenti l'ennesima bocciatura di una legge palesemente ad personam, smaccatamente in mala fede. E la lista si allunga: il legittimo impedimento diventa così il fratellino minore dei due lodi, quello Schifani e quello Alfano. Entrambi giudicati incostituzionali: il primo nel 2004, il secondo nel 2009. Fra le varie violazioni, i lodi contrastavano, nemmeno a dirlo, con l'articolo 3 della Costituzione (il principio di "eguaglianza" non gli va proprio giù).
Ma soprattutto, la Consulta ha inferto un altro duro colpo ai due oscuri legislatori berlusconiani, che accarezzavano l'idea di poter finalmente condurre una vita serena, libera dalle preoccupazioni per i processi del boss. Parliamo di Angelino Alfano e Niccolò Ghedini, rispettivamente ministro della Giustizia e avvocato del premier. O forse il contrario.
