- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Giuliano Luongo
di Giuliano Luongo
Da qualche anno a questa parte, come tristemente sappiamo, i paesi del cosiddetto “nord” del mondo stanno sviluppando una sempre più crescente fobia con tendenze violente verso la figura dell’immigrato, clandestino o meno. Questa categoria di soggetti “pericolosi, inquietanti e sovversivi” viene respinta con i modi strategicamente e politicamente più fantasiosi. Di recente è in voga una tattica alquanto stupefacente nella sua semplicità, o idiozia: quella dei muri. Ha iniziato Israele, per tener lontani i palestinesi; ha continuato l’Egitto, per tenere lontani un po’ tutti, sub-sahariani compresi; ci hanno pensato anche gli Stati Uniti, per tenere lontano i messicani.
Ora è il turno della Grecia. Esatto, la Grecia. Dopo aver deliziato la Comunità con una crisi leggendaria, raggiunta con un abile mix di politiche domestiche incompetenti e sgambetti da oltreoceano, il governo di Atene ha deciso, con l’inizio dell’anno nuovo, di far costruire un muro lungo “appena” 13 kilometri (e alto 3 metri) sul confine turco; per essere più precisi, sul quel tratto di confine con la Turchia ove il transito di migranti clandestini è maggiore e - almeno a quanto si dice dai palazzi del potere dell’ex-patria della dracma - eccessivo e incontrollabile.
Parole d’insofferenza hanno testimoniato lo stato dell’umore degli ufficiali greci nei confronti dell’immigrazione dalla Turchia (“ La Grecia non ne può più”) che hanno caratterizzato la lapidaria dichiarazione del Ministro per la protezione dei cittadini Christos Papoutsis, che ha spiegato al mondo il perché di quest’azione di forza, o almeno ci ha provato. In pratica, le motivazioni ufficiali comprendono un aumento del livello di cooperazione con l’Unione Europea nella lotta all’immigrazione clandestina e la volontà di placare la “voce del popolo”, stanco dell’irrefrenabile flusso di migranti che finisce per intasare le coste elleniche. Mah.
Invero, va detto che la migrazione clandestina che usa la Turchia come paese di transito ha raggiunto livelli elevati: si pensi che da gennaio a novembre 2010 hanno saltato il confine quasi 128mila sans papiers. E’ vero inoltre che la “questione di confine” greco-turca continua a far male dal 1919, e che il confinante dell’Asia Minore ha sempre rappresentato una sorta di rivale ed avversario non solo politico-economico, ma soprattutto sociale e culturale; ma in ogni caso ci troviamo di fronte ad una misura di carattere estremo che mal si concilia con lo spirito di un paese teoricamente democratico ed europeo.
E la cosa diviene ancor più comica di fronte alla realtà della tragica mancanza di competenza in fase di preparazione e messa in atto di qualsivoglia attività di sorveglianza: ogni aspetto della gestione delle frontiere faceva - e fa tutt’ora, muri o meno - acqua da tutte le parti, tant’è che da Bruxelles erano già state prese misure di supporto dalla fine di ottobre 2010. L’Unione ha infatti già attivato il Frontex per supportare i pattugliamenti frontalieri nelle aree greche più a rischio, tra cui appunto quella a sud del fiume Evros, dove sorgerà l’infame ammasso di mattoni. Con circa un paio di mesi di sorveglianza congiunta si è arrivati ad ottenere un abbassamento del 44% delle migrazioni clandestine: risultato oggettivamente spettacolare, ottenuto con sole 200 unità di personale competente extra. Unico neo: l’Unione voleva “impegno degli stati (Grecia e Turchia appunto)” per migliorare la situazione, ed in ogni caso il ritiro delle truppe avverrà a febbraio.
 E da qui, l’idea del governo di Atene: non perseverare nell’uso di milizia addestrata, ma avviare la costruzione di un bunker egeo. Sono state miste le reazioni dal continente: mentre da Bruxelles sono state numerose le perplessità al riguardo - benché non incanalate in una critica mirata, unita o quantomeno decente - da Parigi e Berlino è giunto un discreto apprezzamento per l’iniziativa greca: atto molto utile a mostrare tanto il livello di divisione dell’Unione quanto la volontà di dare un ennesimo segnale ai turchi di stare fuori dalla territorio comunitario. Interessante notare come nemmeno da Ankara si siano levate voci rabbiose: nonostante in ambito governativo siano state sollevate alcune perplessità - specie riguardo accuse indirette di facilitare l’immigrazione clandestina - la risposta alla costruzione del muro è stata un rilassato “no problem”.
E da qui, l’idea del governo di Atene: non perseverare nell’uso di milizia addestrata, ma avviare la costruzione di un bunker egeo. Sono state miste le reazioni dal continente: mentre da Bruxelles sono state numerose le perplessità al riguardo - benché non incanalate in una critica mirata, unita o quantomeno decente - da Parigi e Berlino è giunto un discreto apprezzamento per l’iniziativa greca: atto molto utile a mostrare tanto il livello di divisione dell’Unione quanto la volontà di dare un ennesimo segnale ai turchi di stare fuori dalla territorio comunitario. Interessante notare come nemmeno da Ankara si siano levate voci rabbiose: nonostante in ambito governativo siano state sollevate alcune perplessità - specie riguardo accuse indirette di facilitare l’immigrazione clandestina - la risposta alla costruzione del muro è stata un rilassato “no problem”.
Proprio il leader Erdogan, infatti, ha dichiarato che “sarebbe sbagliato chiamare la struttura progettata “un muro, è solo una barriera”, per poi aggiungere che entrambe le parti hanno fiducia l’una nell’altra. Ma torniamo a tre parole fa: “non è un muro, è una barriera” che tipologia di commento è? Nessuna, non è nemmeno un commento. Meglio: non ha senso. D’accordo che, dopo aver visto i dati sull’immigrazione dal suo paese si è preoccupato, ma fingere di usare sinonimie e sottigliezze semantiche non è certo un commento politico sensato. O meglio: è il commento politico di un leader che vuole mostrare “benevolenza” verso l’organizzazione regionale nella quale brama di far entrare da tempo il suo paese, ed al contempo che vuole dare un segnale contro l’immigrazione, senza andare troppo per il sottile.
Ma almeno una voce fuori dal coro c’è stata, proveniente da sede ONU: l’UNHCR (Alto Commissariato per i Rifugiati) ha dichiarato forti perplessità in merito, con riferimento ai possibili danni ai rifugiati politici, i quali finirebbero per subire lo stretto trattamento dei clandestini, e soprattutto in merito al fatto che la via più sensata sarebbe stata quella di continuare con azioni di polizia (come del resto il Frontex aveva mostrato possibile). Subito da Atene c’è stata risposta: il governo greco “non ci sta” alla “ipocrisia” di Bruxelles e delle Nazioni Unite, adducendo poi altre motivazioni bislacche che per decenza evitiamo di riportare. Fatto sta che la decisione, in data 19 gennaio, sembra essere ufficialmente passata e, pertanto, tempo qualche mese, avremo davvero questa “barriera che non è un muro”, pronta a rinsaldare le mura di cinta di quella che la stampa indipendente già da anni chiama “fortress Europe”.
E’ chiaro che, dopo l’innegabile contributo al fallimento dell’economia europea, la Grecia ha ben cercato di “riscattarsi”, “aiutando” l’Unione su di un tema spinoso, quello dell’immigrazione eccessiva. Da Atene stanno cercando di mostrare non solo i muscoli a turchi e migranti, ma anche la loro disponibilità a mostrarsi qualcosa di diverso da un paese periferico inutile, buono solo a risucchiare fondi strutturali.
Assurdo a dirsi, i due colossi free riders dell’Unione hanno dato il loro appoggio, galvanizzati dal mettere un’ennesima barriera - stavolta fisica - tra l’Europa e gli “invasori musulmani”. Siamo davanti all’ennesimo assurdo di propaganda di politica forte e delle “azioni ad effetto”, che non vede come soluzioni meno “clamorose” siano di fatto più efficaci: bastava poco ad adottare strategie del Frontex, assumere guardiani invece di “muratori” ed il gioco sarebbe stato fatto, senza ulteriori effetti in tema di immagine internazionale. Sullo sfondo, rimane il tema dello spauracchio che viene dal Vicino Oriente, nella forma dell’infiltrazione islamica, che deve ricevere dei respingimenti da ogni dove e in qualunque modo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di mazzetta
di mazzetta
La rivoluzione tunisina procede inarrestabile ormai lontana dall'attenzione dei media italiani. Meglio così, il nostro Ministro degli Esteri è stato l'unico insieme a Gheddafi a solidarizzare con la dittatura e il Sottosegretario agli Esteri Stefania Craxi è stata l'unica a lamentarsi perché il nostro governo non ha offerto asilo al dittatore tanto amico del suo papà; quel Bettino che portò al potere proprio Ben Alì organizzando un golpe e che poi godrà ricambiato della protezione del dittatore durante la latitanza.
I media e la politica non hanno discusso la posizione italiana, nessuno ci ha trovato nulla da ridire, anche se ci ha emarginato all'interno della UE e offerto una pessima immagine del nostro paese ai nordafricani. Frattini è stato poi particolarmente sfortunato, perché il giorno dopo che ha espresso la sua fiducia al governo di Ben Alì, questi è fuggito in Arabia Saudita. Identico destino quando si è congratulato perché il nuovo Esecutivo era formato da ministri del vecchio governo molto amici dell'Italia: è durato un giorno pure quello.
La pressione popolare ha nuovamente azzerato il governo provvisorio, creato cooptando pezzi dell'opposizione e della società civile (anche un blogger) nei posti meno significativi di un governo retto nei posti chiave da esponenti del regime, che si incaricava di organizzare le elezioni.
L'ipotesi non ha retto, le proteste sono continuate e il governo è ri-caduto, e con lui è caduto anche il partito unico di Ben Alì, svuotato dal ripudio di parte dei suoi maggiori esponenti un attimo prima di essere dichiarato illegale. Si dovrà riorganizzare con un altro nome o scindersi in diverse formazioni e fondarsi su altri presupposti, visto che da un lato non potrà contare su una bella reputazione e dall'altro non potrà più contare su finanziamenti illimitati e subirà la confisca di tutti i beni.
La rivoluzione tunisina non cessa di emozionare i cittadini degli altri paesi nordafricani, anche loro alle prese con problemi economici simili, ma soprattutto con dittature pluridecennali. Se in Occidente si continua a dare come unica lettura quella economica, negando di fatto qualsiasi plauso o esaltazione alla sacrosanta ribellione dei tunisini, nei paesi arabi la parola d'ordine sembra quella di negare qualsiasi possibilità di contagio e qualsiasi legittimità politica a rivolte simili. In linea di massima si tende a parlarne il meno possibile, anche se le Tv satellitari come al Jazeera e la rete portano comunque notizie che rallegrano i cittadini da Rabat a Il Cairo.
Notizie che non possono essere accolte che con favore da popoli che vivono ormai da decenni sotto il tallone di sovrani assoluti e spesso spietati nel reprimere il dissenso, ai quali non è dedicata che una frazione dell'attenzione dedicata al dittatore nemico del momento, sia Saddam o Ahmadinejad. Eppure i regimi nordafricani non hanno nulla da imparare da nessuno in termini di repressione violenta, soppressione della libertà di stampa, dei diritti umani e di quelli civili. I loro leader hanno la fortuna di essersi alleati con i buoni e quindi, per un processo di tramutazione all'interno del discorso politico e mediatico, diventano buoni anch’essi.
 Far parte della squadra dei buoni significa godere di buona stampa, contratti che andranno ad arricchire i regimi, forniture militari e la garanzia di poter colpire le opposizioni impunemente invocando la lotta al terrorismo anche quando non ci sono terroristi. Dal 2001 questo pacchetto d'indulgenze per i leader dei paesi arabi è stato arricchito ancora di più, fino a integrare la totale immunità per chi ha voluto stravolgere una Costituzione o liberarsi delle opposizioni. Opportunità dorate, che nessuno dei leader in questione si è lasciato sfuggire. Una pratica che ricorda molto il vassallaggio, con cui si è stretta una morsa su popoli arabi in nome della lotta all'estremismo islamico.
Far parte della squadra dei buoni significa godere di buona stampa, contratti che andranno ad arricchire i regimi, forniture militari e la garanzia di poter colpire le opposizioni impunemente invocando la lotta al terrorismo anche quando non ci sono terroristi. Dal 2001 questo pacchetto d'indulgenze per i leader dei paesi arabi è stato arricchito ancora di più, fino a integrare la totale immunità per chi ha voluto stravolgere una Costituzione o liberarsi delle opposizioni. Opportunità dorate, che nessuno dei leader in questione si è lasciato sfuggire. Una pratica che ricorda molto il vassallaggio, con cui si è stretta una morsa su popoli arabi in nome della lotta all'estremismo islamico.
Una vera e propria tenaglia che ha stretto le società di questi paesi entro confini ancora più stretti, proprio mentre la modernità elettronica e il desiderio di progresso economico e sociale si facevano sempre più forti, mentre questi paesi si popolavano sempre di più di giovani, sempre più lontani da una formazione compatibile con la sopportazione di geronto-dittature che hanno l'unico interesse nell'arricchimento e nella trasmissione del potere ai figli.
La retorica americana dell'esportazione della democrazia si è fermata sulla porta dei paesi alleati, gli americani hanno provato a portarla solo in Afghanistan, Iraq e Somalia e, anche lì, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se un giorno i popoli oppressi del Nordafrica dovessero guardare a chi ha appoggiato le dittature che li hanno oppressi per decenni, non potrebbero che volgere lo sguardo ad Europa e Stati Uniti, che non hanno certo perso il controllo di quei paesi dopo aver loro concesso un'indipendenza che è sempre stata più nella forma che nei fatti.
Si continuerà così fin che si potrà, con l'Europa e gli Stati Uniti che plaudono le autocrazie che sostengono da decenni al di là del Mediterraneo. Paesi, media e politici che sostengono di temere l'invasione islamica mentre opprimono e bombardano i paesi arabi e musulmani, mentre si associano a delinquenti locali per depredarne le ricchezze e assicurarsi che nessuno turbi la leggendaria “stabilità” invocata dall'Occidente prima ancora della democrazia e della libertà.
 La stabilità di regimi sanguinari e oppressivi non suona proprio come un gran valore, ma si vede che per qualcuno un valore ce l'ha. Purtroppo di questi dettagli non si discute proprio, nel nostro paese, che pure la rivoluzione tunisina ce l'ha alle porte; ma essa non è oggetto di dibattito e non dipende dal clamore delle vicende porcelle di Berlusconi. Sono anni che maggioranza e opposizione non si scontrano sulla politica estera, l'opposizione è riuscita a malapena a lamentarsi per il bunga bunga con Gheddafi e per qualche altra amicizia personale un po' trash del Presidente del Consiglio.
La stabilità di regimi sanguinari e oppressivi non suona proprio come un gran valore, ma si vede che per qualcuno un valore ce l'ha. Purtroppo di questi dettagli non si discute proprio, nel nostro paese, che pure la rivoluzione tunisina ce l'ha alle porte; ma essa non è oggetto di dibattito e non dipende dal clamore delle vicende porcelle di Berlusconi. Sono anni che maggioranza e opposizione non si scontrano sulla politica estera, l'opposizione è riuscita a malapena a lamentarsi per il bunga bunga con Gheddafi e per qualche altra amicizia personale un po' trash del Presidente del Consiglio.
La storia però corre a passo di carica, sempre più governi sentono che con i morsi della crisi arrivano al pettine anche nodi degli investimenti azzardati, le truffe, la corruzione e i progetti scellerati. Gli abitanti del Nordafrica restano alla finestra, ma la tensione non scende, l'esempio tunisino non cessa di produrre emulazioni qua e là, che per ora prendono la forma di suicidi di protesta.
In Egitto hanno tamponato la crisi dei suicidi mandando degli specialisti in televisione a dire che si tratta di malati di mente, “siamo tutti malati di mente” è subito diventato lo slogan dell'opposizione. Gheddafi in Libia ha reagito veloce alla rivolta tunisina togliendo le tasse sui beni alimentari, ma potrebbe non bastare, la notizia di ribellioni al regime libico è rara e quindi a suo modo significativa. In Marocco il re non può dare la colpa a un Parlamento che ha svuotato di senso, in Algeria il regime è in crisi d'idee e di legittimità, in Egitto il leader ha ottantadue anni e non sembra ancora essere riuscito a solidificare un progetto di successione certo e affidabile.
Operazione che raramente riesce alle dittature; la Siria degli Assad e la Corea dei Kim possono essere considerate le eccezioni che confermano la regola; spesso tendono a comportarsi come monarchie anche se guidano paesi che hanno scelto la repubblica come forma di governo. Una considerazione che induce a ritenere verosimile che l'attuale assetto politico del Nordafrica sia destinato ad essere messo in discussione seriamente negli anni a venire.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Giuliano Luongo
di Giuliano Luongo
Ormai tutti conoscono a menadito le abili strategie di Putin, grazie alle quali il leader post - o sarebbe meglio dire neo - sovietico riesce a serrare con forza sempre maggiore le proprie mani sul sistema energetico europeo: conosciamo quanto è successo e continua a succedere in ambito gas, e sappiamo anche cosa succede in tema di energia nucleare.
Un ambito invece sul quale siamo meno informati è quello della “Russia petrolifera”: a parte le notizie di qualche ingente crack risalente a diversi anni fa - e trascurando gli atti estremi di noti petrolieri celebri per le loro fesserie nel jet-set internazionale - conosciamo ben poco delle idee geostrategiche del Cremlino per conquistare la cara, vecchia, scricchiolante Europa occidentale.
Ebbene, stavolta abbiamo sotto i nostri occhil’ultimo atto della crociata energetica moscovita, che sta avendo luogo proprio nel settore petrolifero: la Rosneft, “compagnia di bandiera” dell’oro nero russo, ha siglato un accordo con la società anti-ecologica per eccellenza, la British Petroleum (in arte BP) in tema di diritti di trivellazione e soprattutto di quote societarie all’interno della grande compagnia britannica. Cerchiamo di andare per ordine onde chiarire statiche e dinamiche di questi nuovi assetti.
La BP ha comunicato uno share swap di “appena” 16 miliardi di dollari con la controparte russa, come parte di un’ambiziosa alleanza strategica che vedrà le due compagnie coinvolte in un’operazione di trivellazione congiunta nella zona dell’Artico controllata da Mosca. In tema di “numeri”, Rosneft entrerà in possesso del 5% della BP, che a sua volta prende il 9,5% del gruppo russo, del quale possedeva già l’1,2%. L’operazione è stata una vera e propria iniezione di salute per le azioni della compagnia britannica, cresciute di 4 punti al momento della pubblicazione della notizia: a circa 49$ per azione, i titoli del gruppo hanno raggiunto il loro massimo dal 6 maggio scorso, un’autentica rivitalizzazione dal momento in cui il disastro ecologico-economico del Golfo del Messico ha avuto luogo.
L’accordo è stato ovviamente accompagnato dalla fuffa di rito, con frasi del tipo “siamo davanti all’alleanza del 21esimo secolo”, “nuovi accordi, basta con le vecchie logiche” e via discorrendo: su temi più pratici, i manager BP hanno affermato che “avrebbero potuto” firmare un simile accordo anche se il disastro messicano non fosse avvenuto, e che un simile scambio può portare vantaggi alle loro “azioni sottovalutate”.
 Da parte moscovita, la soddisfazione è alle stelle: per mandare l’accordo a buon fine, centrale è stata l’azione del grande alleato politico di Putin, Igor Sechin, che ha tenuto a precisare quanto questo accordo smentisca coloro i quali sostengono che la Russia pratica una politica economica miope e poco lungimirante.
Da parte moscovita, la soddisfazione è alle stelle: per mandare l’accordo a buon fine, centrale è stata l’azione del grande alleato politico di Putin, Igor Sechin, che ha tenuto a precisare quanto questo accordo smentisca coloro i quali sostengono che la Russia pratica una politica economica miope e poco lungimirante.
Stavolta, il punto non è solo strettamente sull’ennesima espansione russa in Europa, Rosneft diviene sì il maggiore singolo azionista della compagnia britannica, ma per capire l’ampiezza dell’operazione si deve tenere bene a mente l’identità, per così dire, del primo “cliente” della BP: l’esercito degli Stati Uniti d’America. Per sillogismo, dunque, la forza militare più sopravvalutata al mondo compra “la” risorsa energetica per eccellenza dagli avversari di sempre.
Mica da ridere. Cioè, sì, fa ridere ed anche tanto, ovviamente se non si é dipendenti della Casa Bianca. Inutile dire che le reazioni da Washington si sono fatte sentire, anche se non in maniera eccessivamente “calda” come si sarebbe temuto né in maniera ufficiale, probabilmente a causa dei maggiori mali di fegato causati dalla concomitanza della visita cinese. Forse proprio perché impegnato a gestire la patata bollente Hu Jintao, Obama pare non si sia espresso ancora sulla faccenda, mentre qualcosa è trapelata dalla Commissione governativa presidenziale - già occupatasi del caso messicano - che ha semplicemente fatto un invito a non effettuare trivellazioni nell’Artico senza i dovuti controlli ambientali.
Mentre il deputato democratico Markey (membro del comitato per le risorse energetiche nazionali) ha preferito enunciare il proprio disappunto sbeffeggiando la BP con un gioco di parole squallido, il repubblicano Burgess si è limitato a parlare di “bisogno di attenta analisi” sull’accordo. Più interessante far notare come si sia reagito da Londra, dove il Ministro dell’energia Chris Huhn ha seccamente definito la Russia come “valido partner energetico”. Interessante ricordare che l’accordo in questione ha un suo peso anche nelle dinamiche interne alla Russia stessa: la Rosneft ha in corso una sorta di “rivalità” con la Gazprom per l’accaparramento di quote nelle imprese straniere.
Diversi rapporti di forza tra le imprese russe si concretizzano in diversi rapporti di forza nel “politburo” di Putin e dintorni: il colpaccio del Rosneft ha di certo portato molti punti a Sechin, e di sicuro numerose conseguenze non si faranno attendere. In tutto questo, la BP stessa ha sicuramente un semplice vantaggio: si allontanano le chance di chiudere bottega, dopo la cilecca leggendaria sulle coste americane che ben ricordiamo. La compagnia inglese va già smontandosi - con molti “pezzi” della catena produttiva che vanno nelle manine dei cinesi - e di conseguenza un accordo non troppo capestro con i russi significa una vita più lunga, almeno così si spera.
 Dunque, benché questo sia solo un inizio e pertanto non possiamo già trarre conclusioni, possiamo almeno abbozzare delle piccole ipotesi per provare a leggere sviluppi futuri. In primo luogo, vediamo che il partner russo, nonostante sia geostrategicamente il peggiore possibile, continua ad essere particolarmente attraente per le compagnie energetiche europee.
Dunque, benché questo sia solo un inizio e pertanto non possiamo già trarre conclusioni, possiamo almeno abbozzare delle piccole ipotesi per provare a leggere sviluppi futuri. In primo luogo, vediamo che il partner russo, nonostante sia geostrategicamente il peggiore possibile, continua ad essere particolarmente attraente per le compagnie energetiche europee.
Proponendo accordi più o meno vantaggiosi, facili, resi piacevoli anche per la politica, Mosca riesce ad accattivarsi le simpatie - e le quote - di compagnie di rilievo in tutti i maggiori (e minori) paesi d’Europa. La BP è solo l’ultima compagnia in ordine cronologico che decide di collaborare con un avversario/partner discutibile per un proprio profitto, con molta poca lungimiranza.
In secondo luogo, sarà opportuno tenere d’occhio le possibili mosse successive da parte nordamericana: di fatto, trattasi di operazione tra compagnie private e in un ipotetico sistema liberal-capitalista un governo non potrebbe/dovrebbe fare nulla. Eppure non dimentichiamo che i mezzi di pressione indiretta sono fin troppi. E l’amico Berlusconi? Lui, stavolta, non c’entra niente. Per ora.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Benedetti
di Carlo Benedetti
MOSCA. Personaggio manzoniano, simile all’Innominato. E’ una delle figure più complesse ed anche tragicamente più interessanti nell’arena post-sovietica. Viene presentato dai suoi nemici come uomo malvagio: più che ripugnanza, incute rispetto e timore. E’ descritto come un despota che s’ispira all’Urss; neri i pochi capelli che gli restano segnati dal riporto; faccia tirata; a prima vista, gli si possono dare circa sessant'anni, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro, ma vivo degli occhi, indicano una forza di corpo e d'animo.
Da un punto di vista psicologico, con gli occhi che riflettono molta diffidenza e poca meraviglia, appare subito come una figura misteriosa: temperamento volitivo da vero campagnolo, Innominato fin dall'adolescenza, con l'ansia di esser superiore a tutti d'ardore e di costanza; le parole e le frasi che ne ritraggono l'esistenza hanno tutte una forza e un colorito fantastico particolare. Ha parecchi uomini di fiducia, grazie ai quali tutti i potenti locali sono costretti a scendere a patti con lui.
E lui è il (rieletto) Presidente della Repubblica Belarus, Aleksandr Grigor'evich Lukashenko, sposato (due figli Viktor e Dmitrij), nato il 30 agosto del 1954 nel villaggio di Kopyc’, provincia di Orsha, nella regione di Vitebsk (quella che diede i natali a Chagall...). Cresciuto ed educato senza il padre, fin dall’adolescenza ha dovuto portare sulle proprie spalle una parte significativa nella cura della famiglia.
Due lauree: nel 1975 presso l’Università Statale di Mogilev “A.A. Kuleshova” e nel 1985 presso l’Accademia Bielorussa di Agricoltura. Storico ed Economista. Negli anni 1975-77 e dopo nel 1980-82 ha svolto il servizio militare nelle guardie di frontiera (Kgb) e nell’esercito sovietico. Nel 1978-79 e dopo il 1982 lavora in vari organismi, quindi entra nella sfera dell'attività economica occupando varie posizioni in imprese dell’industria dei materiali da costruzione e del complesso agro-industriale della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia.
Nel 1990 diviene deputato e viene eletto al Soviet Supremo della Repubblica. L’incarico di Presidente della Commissione del Soviet Supremo per la lotta alla corruzione, svolto in maniera autorevole dall’aprile 1993 al luglio 1994 lo rende noto al grande pubblico. Il 10 luglio 1994, dopo una dura battaglia elettorale con altri 5 candidati rappresentanti di tutto lo spettro delle forze politiche del Paese, è eletto Presidente della Repubblica con oltre l’80% dei voti.
Il suo obiettivo - stando a pubbliche dichiarazioni - consisterà nel dare forma al nuovo Stato nazionale, a riorganizzare e riformare gli elementi fondamentali che caratterizzano un moderno stato democratico e, infine, affrontare i vari problemi socio-economici del paese. E’ poi noto che con i referendum del 1995 e del 1996 è stata approvata la Costituzione, si sono decisi i problemi linguistici (con l’introduzione di due lingue statali: il russo e il bielorusso), sono stati ratificati i simboli statali (viene introdotta l’attuale bandiera rosso-verde con la decorazione verticale sul lato sinistro, riprendendo quindi, la bandiera dei tempi della repubblica sovietica, e viene introdotto l’attuale stemma della Repubblica), è stato poi dato un inequivocabile parere favorevole all’unione con la Russia.
Il 7 settembre del 2001, al primo turno delle elezioni presidenziali, Lukashenko è rieletto per la seconda volta Presidente della Repubblica con il 75.65% dei voti. Andando ad occupare, ancora una volta, gli incarichi di “Comandante Supremo delle Forze Armate della Repubblica Belarus”, di presidente del "Consiglio di Difesa della Repubblica Belarus", e del “Consiglio Statale Supremo dell’Unione degli Stati di Belarus e Russia". E, di elezione in elezione, si è ritrovato ancora una volta a comandare sull’intero paese.
 Si caratterizza con una gestione personale ed autoritaria. Reprime il dissenso e non lascia spazio agli oppositori politici. Segue una politica “sovietica” e si caratterizza per un nazionalismo sfrenato. Mostra evidente l’orgoglio di una nazione che durante gli anni dell’Unione Sovietica veniva coniderata come una filiale di Mosca. Ed oggi - tra scontri ed aperte contestazioni - ottiene l’investitura ufficiale, pur se gli ambasciatori dei paesi accreditati a Minsk non assistono alla cerimonia e lasciano il Paese in segno di protesta contro le repressioni.
Si caratterizza con una gestione personale ed autoritaria. Reprime il dissenso e non lascia spazio agli oppositori politici. Segue una politica “sovietica” e si caratterizza per un nazionalismo sfrenato. Mostra evidente l’orgoglio di una nazione che durante gli anni dell’Unione Sovietica veniva coniderata come una filiale di Mosca. Ed oggi - tra scontri ed aperte contestazioni - ottiene l’investitura ufficiale, pur se gli ambasciatori dei paesi accreditati a Minsk non assistono alla cerimonia e lasciano il Paese in segno di protesta contro le repressioni.
Ed è boicottaggio anche da parte dell'ambasciatore Usa, che non è presente all’investitura e sceglie una visita di piacere in una città della Bielorussia occidentale. Mentre la Russia mostra un basso profilo mandando solo il suo ambasciatore Aleksandr Surikov ad ossequiare il nuovo presidente.
Ora agli osservatori diplomatici non resta che tirare le somme di questa partita geopolitica che si gioca nel cuore di una Europa dove vige il dogma del potere assoluto. E mentre le orchestre del sistema suonano le fanfare che annunciano l’insediamento nel tavolo della presidenza bielorussa si accumulano i dossier negativi.
Dal Parlamento Europeo arriva infatti una risoluzione che esorta all’immediata introduzione di sanzioni contro i massimi dirigenti di Minsk. Al Consiglio d’Europa si raccomanda, in particolare, di negare il visto d’ingresso e congelare gli averi dei massimi dirigenti bielorussi nei paesi comunitari. Ciò riguarda funzionari, collaboratori degli organi giudiziari e degli organi di pubblica sicurezza che, secondo l’Ue, portano la responsabilità per la falsificazione dei risultati delle elezioni presidenziali di dicembre nonché per le repressioni nei confronti dell’opposizione.
Mosca, in tale contesto, si trova ad operare in una zona incerta e pericolosa: cerca di attenuare i vari aspetti della crisi. Come sempre punta a non isolare un paese che, tutto sommato, è amico e vicino al Cremlino. Di conseguenza la direzione russa risparmia alla Bielorussia l'isolamento internazionale: con Putin che torna a far sapere che concederà ai "cugini" bielorussi sussidi per il settore petrolifero per 4,124 miliardi di dollari e con Medvedev che ribadisce che per la Russia la Bielorussia è sempre uno dei paesi più vicini, culturalmente e storicamente, chiunque sia alla sua guida.
 In questo quadro generale Lukashenko avvia la sua nuova era presidenziale rifacendosi alla procedura del “silenzio-assenso”. Si rivela sempre più come un personaggio dinamico, un Innominato che non mostra paura: cambia pelle, passa da una sponda all’altra. E all’opposizione, che viene regolarmente repressa, non resta che fare il bilancio con i suoi tre candidati - Sannikov, Statkevic, Kostusev - arrestati. Mentre si parla già del possibile scioglimento di alcune strutture politiche e mediatiche - “Combattenti per i diritti e la liberta” e “Carta ’97” - ostili alla presidenza attuale.
In questo quadro generale Lukashenko avvia la sua nuova era presidenziale rifacendosi alla procedura del “silenzio-assenso”. Si rivela sempre più come un personaggio dinamico, un Innominato che non mostra paura: cambia pelle, passa da una sponda all’altra. E all’opposizione, che viene regolarmente repressa, non resta che fare il bilancio con i suoi tre candidati - Sannikov, Statkevic, Kostusev - arrestati. Mentre si parla già del possibile scioglimento di alcune strutture politiche e mediatiche - “Combattenti per i diritti e la liberta” e “Carta ’97” - ostili alla presidenza attuale.
Gli Usa, intanto, continuano la loro guerra diplomatica e mediatica contro il potere di Minsk. Il Dipartimento di Stato definisce Lukashenko “l’ultimo dittatore d’Europa” collocando la Bielorussia tra gli “avamposti della tirannia”. Per il portavoce della Casa Bianca, Scott McClellan, il voto bielorusso è segnato da “un clima di paura”. Duro anche il giudizio dell’Ocse, che per bocca del presidente della sua Assemblea parlamentare, Alcee L. Hastings, definisce ufficialmente la consultazione bielorussa “non in linea con i criteri internazionali richiesti per elezioni libere e giuste”. E su tutto questo c’è sempre quella Condoleeza Rice che definì la Bielorussia di Lukashenko un “avamposto di tirannia”.
Dal canto suo il ministro degli Esteri austriaco Ursula Plassnik a nome della Presidenza europea ha parlato di “clima di intimidazione”. E il commissario alle Relazioni estere della stessa Unione Europea, Benita Ferrero-Waldner, annuncia sanzioni, pur rassicurando che non s’intende “fare del male al popolo bielorusso”.
Intanto lui, l’Innominato di Minsk, vive i giorni del trionfo. Ottenuti mettendo a ferro e fuoco gli oppositori e una parte dell’intellighentsia. Punta a farsi forte con i suoi contadini ed operai che vedono in lui il continuatore di una politica di stabilità tipica degli anni della “stagnazione” brezneviana e sempre segnata da comportamenti pomposi, ottusi ed arroganti.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Nonostante gli onori della visita di stato riservati al presidente cinese Hu Jintao e le amichevoli dichiarazioni di circostanza, il summit di Washington tra i vertici delle due principali potenze economiche del pianeta poco o nulla ha fatto per risolvere le tensioni e i nodi irrisolti nei loro rapporti. E non poteva essere diversamente, viste le provocazioni americane degli ultimi mesi nei confronti di Pechino e i crescenti conflitti tra i rispettivi interessi che stanno accompagnando l’inesorabile avanzata dell’influenza cinese su scala planetaria e il conseguente declino degli Stati Uniti.
A fissare gli argomenti dell’ottavo faccia a faccia in due anni tra il presidente americano e Hu Jintao erano state, nei giorni precedenti, una serie di dichiarazioni minacciose da parte dei tre più influenti membri dell’amministrazione Obama. Nel suo tour in estremo oriente il numero uno del Pentagono, Robert Gates, poco prima di visitare proprio il leader cinese aveva avvertito come gli USA siano intenzionati a contrastare il rafforzamento militare di Pechino nell’Oceano Pacifico incrementando a loro volta gli investimenti in questo ambito.
Alla questioni del confronto militare e del sovrapporsi delle sfere di influenza nel Pacifico hanno fatto seguito poi quelle legate all’economia e ai diritti umani. Il Segretario al Tesoro, Tim Geithner, ha così ribadito il ritornello della necessità del rafforzamento della moneta cinese, il renminbi, per favorire le esportazioni americane, mentre dal Dipartimento di Stato, Hillary Clinton ha criticato apertamente la Cina per il trattamento del dissidente e recente premio Nobel per la Pace - nonché fermo sostenitore di una totale apertura al libero mercato del proprio paese - Liu Xiaobo.
Su questi e altri temi simili è quindi consistito l’incontro che il consigliere per la sicurezza nazionale dell’ex Presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, ha definito come il più importante per le due potenze dal 1978, quando Deng Xiaoping fece visita proprio all’allora presidente democratico. Se le aspettative erano molte, i risultati sono stati però decisamente modesti. Le richieste di Obama ad un Hu Jintao che si appresta entro poco più di un anno a passare il testimone all’interno del Partito Comunista Cinese, pare abbiano strappato almeno qualche promessa, almeno a parole, sul fronte del rispetto della proprietà intellettuale dei prodotti tecnologici e dell’apertura del mercato cinese alle aziende americane.
Nel consueto clima cordiale della conferenza stampa che mercoledì ha seguito l’incontro ufficiale tra i due presidenti, tuttavia, si sono intravisti alcuni dei punti di scontro che rimangono difficilmente superabili. Tra di essi spiccano la contesa attorno alla Corea del Nord e al riassestamento degli equilibri di potere in Asia orientale, il nucleare iraniano, il Tibet, i rapporti con Taiwan e le già accennate questioni riguardanti il commercio e l’economia che interessano soprattutto le corporation americane.
 Se la stampa istituzionale d’oltreoceano in questi giorni ha ripetutamente insistito nel dipingere la Cina come un crescente pericolo, per gli USA e per l’intero occidente “democratico”, a causa del suo comportamento teso a destabilizzare l’ordine mondiale, è in realtà da Washington che sono giunte le provocazioni che in questi mesi hanno inasprito le divergenze tra i due paesi.
Se la stampa istituzionale d’oltreoceano in questi giorni ha ripetutamente insistito nel dipingere la Cina come un crescente pericolo, per gli USA e per l’intero occidente “democratico”, a causa del suo comportamento teso a destabilizzare l’ordine mondiale, è in realtà da Washington che sono giunte le provocazioni che in questi mesi hanno inasprito le divergenze tra i due paesi.
Ad esempio, l’aggressività dell’amministrazione democratica in estremo oriente si è manifestata esemplarmente nel conflitto sfiorato con la Corea del Nord. L’affondamento di una nave da guerra sud-coreana nel marzo 2010 e il più recente bombardamento da parte di Pyongyang di un’isola appartenente al vicino meridionale sono stati sfruttati senza scrupoli dagli Stati Uniti.
Le ostilità tra le due Coree hanno rischiato di trasformarsi in guerra aperta dopo che Washington ha condotto una serie di provocatorie esercitazioni militari in acque contese. Allo stesso modo questi stessi episodi hanno spinto gli Stati Uniti a promuovere una storica collaborazione militare tra la Corea del Sud e il Giappone. Il tutto con l’intenzione di accerchiare la Cina e cercare di limitarne la sfera d’influenza in un’area ovviamente vitale per i suoi interessi strategici.
Parallelamente, l’ipocrisia americana è apparsa evidente anche nell’insistente campagna orchestrata sui media occidentali per spingere Pechino a far lievitare il valore della propria moneta. Secondo il Tesoro USA le pratiche manipolative della Cina terrebbero artificialmente basso il cambio del renminbi, dando al suo export un vantaggio sleale. La pretesa degli Stati Uniti tuttavia tralascia di ricordare come la politica della Fed dopo la crisi del 2008 sia stata indirizzata precisamente alla svalutazione del dollaro, come confermano le più o meno sommesse critiche lanciate da quegli alleati-competitori le cui economie si basano sulle esportazioni, come Germania e Giappone.
Anche gli stessi richiami a un’apertura democratica e al rispetto dei diritti umani suonano vuoti. A molti in occidente, tra cui i giornalisti americani che alla Casa Bianca hanno incalzato Hu Jintao sulla continua repressione dei diritti civili in Cina, sfugge infatti come questa amministrazione sia responsabile di comportamenti anti-democratici, per non dire criminali, come l’uccisione di centinaia di civili innocenti in Afghanistan, Pakistan e Yemen, la detenzione indefinita di presunti terroristi senza prove né processo, l’approvazione di metodi di tortura negli interrogatori e delle cosiddette “extraordinary renditions” o l’espansione di programmi domestici di sorveglianza destinati al controllo dei cittadini e delle loro attività.
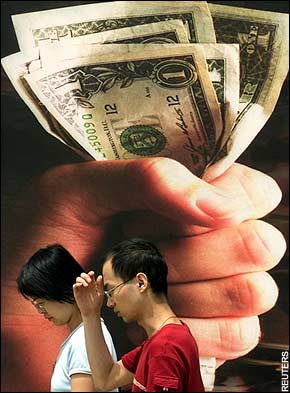 I frutti maggiori nelle relazioni sino-americane si sono visti piuttosto nell’ambito degli affari. Per quanti timori gli Stati Uniti possano nutrire nei confronti del gigante asiatico, quest’ultimo rappresenta pur sempre un mercato potenzialmente enorme per le aziende americane. Tanto più che la bilancia commerciale risulta ancora sbilanciata a favore della Cina per un totale annuo di qualcosa come 275 miliardi di dollari.
I frutti maggiori nelle relazioni sino-americane si sono visti piuttosto nell’ambito degli affari. Per quanti timori gli Stati Uniti possano nutrire nei confronti del gigante asiatico, quest’ultimo rappresenta pur sempre un mercato potenzialmente enorme per le aziende americane. Tanto più che la bilancia commerciale risulta ancora sbilanciata a favore della Cina per un totale annuo di qualcosa come 275 miliardi di dollari.
Prima di recarsi a Chicago per incontrare una delegazione di imprenditori cinesi attivi in territorio americano, Hu Jintao e il suo seguito hanno siglato contratti di fornitura per il valore di 45 miliardi di dollari. A beneficiarne saranno colossi come Caterpillar, Honeywell, Westinghouse Electric e, soprattutto, Boeing, la quale grazie alla mediazione dell’amministrazione Obama ha ottenuto una commessa di 19 miliardi per la realizzazione di duecento velivoli da consegnare alla Cina tra il 2011 e il 2013.
Sul fronte dei rapporti diplomatici, in definitiva, i sia pure modesti progressi proclamati da quasi tutti i giornali americani sono stati pressoché inesistenti. Nel prossimo futuro, anzi, la tensione rischia di aumentare ulteriormente, come dimostra il provvedimento presentato da alcuni senatori democratici e repubblicani in occasione della visita di Hu Jintao e che prevede tariffe doganali punitive per quei paesi accusati di manipolare la propria valuta.
Con una Cina ben decisa a proseguire un percorso di crescita impetuoso, che l’ha già proiettata al secondo posto tra le potenze economiche del pianeta, pronta a giocare un ruolo di primo piano nelle questioni internazionali, e un’America determinata all’impiego della propria superiorità militare per difendere uno status declinante nello scacchiere mondiale, un’ulteriore escalation della rivalità tra Washington e Pechino è tutt’altro che da escludere. E a frenarla, di certo, non saranno i pur buoni rapporti personali che Obama e Hu Jintao hanno mostrato di aver stabilito in questi due anni.
