- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Carlo Musilli
di Carlo Musilli
Quando il potere si occupa di satira dimostra la propria fragilità con un’efficacia superiore a quella di mille comici. Ne sa qualcosa la Cancelliera tedesca Angela Merkel, che da giorni viene massacrata sui giornali di mezzo mondo per aver autorizzato un processo penale contro un saltimbanco, cedendo al ricatto di Recep Tayyip Erdogan.
Il caso riguarda Ian Bomermann, comico tedesco famosissimo in patria che si è preso gioco del presidente turco con una serie di battute volgari. Durante il programma “Extra 3”, trasmesso dall'emittente pubblica NDR, Bomermann ha recitato una poesiola in cui definiva Erdogan un “idiota di professione” che “prende a calci i curdi e picchia i cristiani mentre si dedica alla pedopornografia” e al sesso con pecore e capre. Il Presidente turco lo ha querelato per diffamazione, definendo la trasmissione “inaccettabile” e chiedendo una punizione per l’attore, che secondo Ankara sarebbe colpevole di aver insultato “anche 78 milioni di turchi”.
Fin qui nulla di sorprendente, considerando l’attitudine fascista del regime turco nei confronti delle libertà di opinione e di espressione. L’aspetto grottesco della vicenda si concentra in un dettaglio tecnico: Ankara chiede che il comico sia processato in Germania in base a una legge tedesca che punisce con una pena da uno a tre anni chi lede l’onore di un capo di Stato. Si tratta di una legge del 1871 (anno dell’unificazione della Germania) e l’ultimo a chiederne l’applicazione era stato nientemeno che lo scià di Persia, contestato durante una visita a Berlino nel 1967. Per quanto suoni inverosimile, la norma esiste ancora e la cancelliera ha scelto di applicarla contro Bomermann.
“Ho deciso di prendermi una piccola pausa televisiva - ha scritto il comico su Facebook, annunciando la sospensione del suo spettacolo - in modo che il pubblico possa concentrarsi sulla cose veramente importanti, come la crisi dei rifugiati, le videochat in diretta e la vita sentimentale di Sophia Thomalla, attrice e modella tedesca”.
L’aspetto che più colpisce della vicenda è la gestione disastrosa da parte di Merkel. Siccome per applicare la legge in questione è necessario il via libera del governo alla magistratura, prima la cancelliera ha avocato a sé la decisione (in teoria di competenza del ministro degli Esteri, che però era contrario), poi ha dato lei stessa il via libera, suscitando l’indignazione della stampa e dei socialdemocratici, i quali hanno colto l’occasione per risalire nei sondaggi.
“Sono per la satira ma in questo caso deve decidere la magistratura - ha detto Merkel - nello Stato di diritto non è di competenza del governo, ma della magistratura e dei processi decidere del diritto della persona lesa e di altre questioni sulla libertà di stampa”. La Cancelliera ha anche aggiunto che Berlino si prepara a eliminare dal codice penale la famigerata legge ultracentenaria.
Difficile immaginare una chiosa migliore per un’autodifesa così imbarazzante e imbarazzata, che racchiude in poche parole tutte le contraddizioni possibili. Se Merkel è per la satira, perché non la difende, visto che le è consentito dalla stessa legge? Se invece sono i magistrati a doversi occupare di queste vicende, perché abolire la legge?
Il problema della Cancelliera è che nessuno ha creduto ai suoi scrupoli giudiziari. Tutti, al contrario, hanno capito che si è semplicemente piegata al volere di Erdogan, da sempre ipersensibile alle critiche. Del resto, in Turchia si viene arrestati per molto meno di quello che ha detto Bomermann. Ma perché tanto riguardo? La deduzione più ovvia è che Merkel voglia accontentare la Turchia per non rischiare di rimettere in discussione il faticoso accordo Ue-Ankara sui migranti.
Ma perché tanto riguardo? La deduzione più ovvia è che Merkel voglia accontentare la Turchia per non rischiare di rimettere in discussione il faticoso accordo Ue-Ankara sui migranti.
Qualche settimana fa l’Europa si chiedeva se, pur di arginare l’arrivo dei rifugiati, fosse il caso di siglare un’intesa con un Paese che non rispetta i diritti umani, a cominciare da quello d’espressione. Il dibattito è stato breve e la risposta affermativa, principalmente perché la barriera turca è fondamentale per tenere sotto controllo il flusso di migranti verso il Nord Europa in generale e la Germania in particolare.
Alla fine, il governo tedesco ha scelto di tutelare quell’accordo vergognoso piuttosto che una delle libertà fondamentali su cui si basa la sua stessa Costituzione. Ancora una volta, Berlino ha dato prova di essere mossa da un pragmatismo senza scrupoli che non attribuisce alcuna importanza alla dignità dei singoli. Oltre che, ma questo era già noto, di avere gravi problemi con l’umorismo.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Il trionfo del partito di governo di centro-destra in Corea del Sud, previsto da praticamente tutti i sondaggi alla vigilia del voto per il rinnovo del Parlamento di Seoul, non si è manifestato in nessun modo alla chiusura delle urne mercoledì nel paese dell’Asia nord-orientale. Anzi, il Partito Saenuri, o della “Nuova Frontiera”, della presidente, Park Geun-hye, è stata la prima formazione al potere a mancare la maggioranza assoluta da sedici anni a questa parte, oltretutto di fronte a un’opposizione di centro-sinistra divisa e screditata.
Dei 300 seggi del Parlamento unicamerale sudcoreano (Assemblea Nazionale), al Saenuri ne venivano accreditati fino a 180 da alcuni istituti di ricerca. L’ottimismo della classe dirigente e dei grandi conglomerati industriali del paese era palpabile, viste anche le ultime prestazioni elettorali dei partiti di opposizione, ed era ampiamente diffusa la speranza che il programma di liberalizzazione dell’economia della presidente Park avesse potuto alla fine sbloccarsi dopo lo stallo legislativo registrato nei primi tre anni del suo mandato.
Se l’agenda “pro-business” del centro-destra veniva e viene descritta dai principali media sudcoreani e internazionali come l’unica ricetta in grado di rivitalizzare l’economia, l’opinione degli elettori è risultata differente. La situazione interna è in effetti in chiaro deterioramento, con gli indicatori relativi al debito privato e alla disoccupazione, soprattutto giovanile, in netto aumento. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), inoltre, nel suo ultimo rapporto sullo stato dell’economia mondiale, pubblicato settimana scorsa, ha ridotto le previsioni di crescita della Corea del Sud per il 2016 e il 2017 al 2,7% e al 2,9%, rispettivamente dal 2,9% e 3,2%.
Gli elettori sudcoreani hanno tuttavia percepito in maniera molto lucida il rischio di un ulteriore peggioramento in caso di implementazione delle misure ultra-liberiste volute dalla presidente Park, quanto meno riguardo le condizioni di vita di lavoratori e classe media, e alle urne hanno agito di conseguenza.
L’esito del voto è stato ancora più sorprendente se si considera che in campagna elettorale le questioni legate all’economia sono state a malapena trattate dai principali partiti, mentre il rinnovo del Parlamento è avvenuto nel pieno di una nuova crisi nei rapporti con la Corea del Nord. Il riaccendersi delle tensioni nella penisola di Corea favorisce in genere il partito conservatore che predilige un atteggiamento più fermo nei confronti del regime di Pyongyang. Il centro-sinistra, al contrario, preferisce tradizionalmente il ricorso al dialogo.
Il governo della presidente Park aveva cercato di capitalizzare gli eventi dei mesi scorsi, culminati con il quarto test nucleare da parte della Nordcorea. Ai primi di marzo, le sanzioni approvate dal Consiglio di Sicurezza ONU erano state poi seguite da quelle unilaterali decise da Seoul. La Corea del Sud aveva infine sfruttato la situazione per far passare un pacchetto “anti-terrorismo” con varie misure anti-democratiche, amplificando la minaccia nordcoreana.
Alla fine, mercoledì il Partito Saenuri ha ottenuto appena 122 seggi, contro i 157 che occupava nel Parlamento uscente, ed è stato superato di un solo seggio dalla principale formazione di centro-sinistra, il Partito Minjoo. L’appena creato Partito Popolare è stato poi indicato come il vero vincitore delle elezioni, poiché a meno di tre mesi dalla sua fondazione ha raccolto 38 seggi, tra cui molti nelle province sud-occidentali di Jeolla (Settentrionale e Meridionale), tradizionale feudo del Partito Democratico, predecessore in varie incarnazioni del Minjoo. Se la maggioranza assoluta è dunque perduta, il partito Saenuri potrebbe comunque tornare a essere il primo partito nel caso dovesse ricomporre le divisioni con alcuni suoi ex membri che hanno conquistato seggi presentandosi agli elettori come indipendenti. Alcuni di questi ultimi avevano abbandonato il loro partito, secondo la Associated Press in seguito a una “spaccatura tra la fazione dominante fedele a[lla presidente] Park e i riformisti”.
Se la maggioranza assoluta è dunque perduta, il partito Saenuri potrebbe comunque tornare a essere il primo partito nel caso dovesse ricomporre le divisioni con alcuni suoi ex membri che hanno conquistato seggi presentandosi agli elettori come indipendenti. Alcuni di questi ultimi avevano abbandonato il loro partito, secondo la Associated Press in seguito a una “spaccatura tra la fazione dominante fedele a[lla presidente] Park e i riformisti”.
A influire sulla sconfitta del partito di governo è stata forse anche l’affluenza in aumento rispetto alle precedenti elezioni. Anche per questo dato i sondaggi sudcoreani hanno fallito le previsioni, dal momento che prospettavano un calo dei votanti a vantaggio dei conservatori.
La batosta subita dal Saenuri potrebbe quindi fare arenare in Parlamento le misure del governo per “stimolare” la crescita economica, anche se il sistema presidenziale “forte” sudcoreano prevede comunque un ampio controllo sulla politica domestica ed estera da parte del capo dello stato.
Tra le iniziative più controverse allo studio ve n’erano alcune relative al mercato del lavoro, soprattutto per estendere il periodo di utilizzo dei lavoratori con contratti temporanei e per facilitare i licenziamenti. I vertici del Partito Minjoo, peraltro, a dicembre avevano fatto sapere di essere disposti a valutare alcune di queste misure se l’allora maggioranza vi avesse apportato qualche modifica. Il Minjoo e il Partito Popolare, al di là della retorica, fanno infatti riferimento principalmente alle piccole e medie imprese sudocoreane, mentre il Saenuri è tradizionalmente l’espressione dei “chaebol”, cioè i grandi gruppi industriali del paese.
Le proposte del governo avevano comunque incontrato una forte resistenza tra la popolazione sudcoreana, evidentemente sottovalutata sia dalla classe politica sia dai media indigeni e internazionali. Nel novembre dello scorso anno, ad esempio, a Seoul era stata organizzata una massiccia manifestazione di protesta contro le politiche della destra, a cui avevano partecipato più di 100 mila persone. In quell’occasione, le forze di polizia erano intervenute duramente, lasciando sul campo decine di feriti.
Il voto di mercoledì ha dato poi indicazioni importanti anche in vista delle presidenziali che si terranno nel dicembre del 2017. In Corea del Sud, il capo dello stato può restare in carica per un singolo mandato di cinque anni, così che Park Geun-hye non potrà presentarsi alle prossime elezioni. Con il risultato deludente appena incassato, il Partito Saenuri vede dunque complicarsi gli scenari politici futuri. La leadership di Kim Moo-sung sarà quanto meno messa in discussione e quest’ultimo ha già offerto giovedì le proprie dimissioni a partito che ha convocato una sessione d’emergenza del direttivo per stabilire i prossimi passi.
In crescita sono invece da oggi le quotazioni dei due leader di centro-sinistra. Il numero uno del Partito Popolare, l’imprenditore informatico Ahn Cheol-soo, si è costruito un’immagine di onestà ed efficienza che incontra un qualche favore tra i più giovani. Già nel 2012 Ahn aveva annunciato la propria candidatura da indipendente alla presidenza, per poi abbandonare la corsa e appoggiare il candidato del Partito Democratico, Moon Jae-in, successivamente sconfitto da Park Geun-hye.
Il Partito Minjoo è guidato da Kim Chong-in, anch’egli possibile futuro candidato alla guida del paese asiatico per il 2017. Kim è in realtà il leader ad interim del partito, i cui vertici lo hanno installato solo pochi mesi fa, ed è stato consigliere economico della attuale presidente Park durante la campagna elettorale del 2012.
Il successo dell’opposizione nel voto di mercoledì è dovuto in ogni caso più all’impopolarità del partito al potere che ai propri meriti. I predecessori del Minjoo avevano perso due elezioni presidenziali consecutive - nel 2007 e nel 2012 - in larga misura a causa dell’ostilità popolare nei confronti delle politiche economiche implementate dai presidenti Kim Dae-jung (1998-2003) e Roh Moo-hyun (2003-2008).
Il discredito della principale formazione di centro-sinistra nell’ultimo decennio è testimoniato anche dal continuo ricorso a fusioni e cambi di nome. Quest’ultima è peraltro una pratica comune tra le forze politiche sudcoreane che cercano di ripulire la propria immagine e di far dimenticare i precedenti non troppo apprezzati dagli elettori. Lo stesso Saenuri aveva assunto questa denominazione nel febbraio del 2012, mentre in precedenza era noto come Grande Partito Nazionale. Il partito Democratico, poi partito Democratico Unito e Nuova Alleanza Politica per la Democrazia aveva inoltre patito una scissione nel mese di gennaio di quest’anno, da cui era nato appunto il Partito Popolare. Le defezioni che avevano portato alla nascita di quest’ultima formazione, tra cui quella di Ahn Cheol-soo, avevano convinto i leader a ribattezzare il partito Minjoo.
Il partito Democratico, poi partito Democratico Unito e Nuova Alleanza Politica per la Democrazia aveva inoltre patito una scissione nel mese di gennaio di quest’anno, da cui era nato appunto il Partito Popolare. Le defezioni che avevano portato alla nascita di quest’ultima formazione, tra cui quella di Ahn Cheol-soo, avevano convinto i leader a ribattezzare il partito Minjoo.
La rottura era avvenuta proprio attorno alla leadership del partito e dopo che nel mese di dicembre Ahn aveva lanciato un ultimatum per indire un congresso straordinario al fine di rimpiazzare Moon Jae-in, da lui considerato inadatto a condurre il partito stesso alla vittoria nelle elezioni per l’Assemblea Nazionale.
Queste vicende testimoniano di un centro-sinistra sudcoreano tutt’altro che compatto o preparato ad affrontare i nuovi scenari parlamentari e le presidenziali del 2017, ma soprattutto a dare una risposta efficace alle tensioni sociali prodotte dalla situazione economica del paese e dai riflessi delle delicate questioni di politica estera che gravano su Seoul, a cominciare dallo scontro in atto con la Corea del Nord e dalle manovre dell’alleato americano in Estremo Oriente in chiave anti-cinese.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
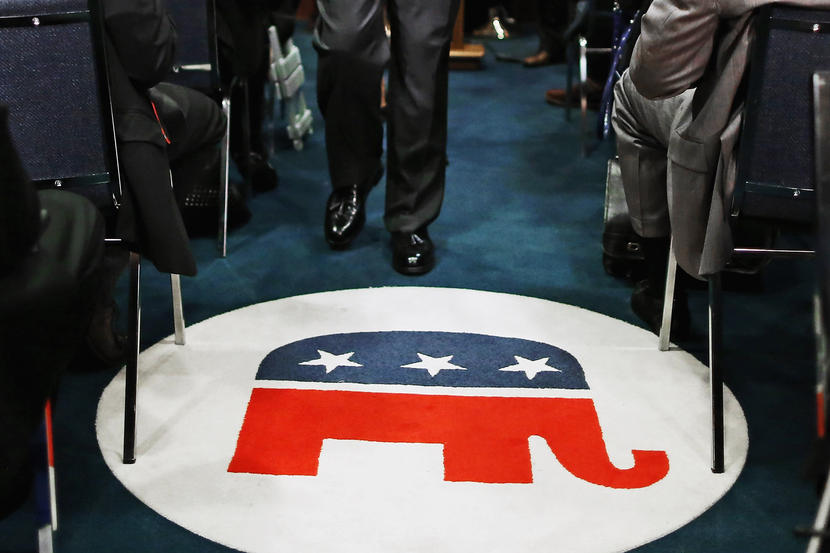 di Michele Paris
di Michele Paris
Le manovre all’interno del Partito Repubblicano per impedire a Donald Trump di conquistare la nomination nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti si stanno intensificando in previsione delle ultime primarie e della convention nazionale del mese di luglio. La sfida sembra però essersi ormai spostata in buona parte dagli appuntamenti con le urne delle prossime settimane alle iniziative in atto per il controllo dei delegati del partito che, vista la natura della sfida tra i Repubblicani in questo 2016, potrebbero essere chiamati a decidere in prima persona il nome del candidato alla Casa Bianca.
Lo scontro si è aggravato dopo che Trump ha mostrato evidenti segni di vulnerabilità di fronte agli attacchi dei rivali interni, ovvero praticamente tutti i vertici Repubblicani e i grandi finanziatori del partito. La netta sconfitta nelle primarie del Wisconsin della settimana scorsa, in particolare, è stata assieme la dimostrazione dell’efficacia della campagna anti-Trump e il catalizzatore dei nuovi sforzi messi in atto per fermare lo slancio del miliardario di New York.
Se Trump continua ad avere ottime possibilità di vincere il 19 aprile nel suo Stato e nelle successive primarie in vari stati del nord-est, la maggior parte degli osservatori ritiene che l’esito più probabile, una volta esaurito il calendario elettorale, sarà l’assenza di un candidato in grado di presentarsi alla convention di Cleveland con la maggioranza assoluta dei delegati, cioè la soglia necessaria per incassare automaticamente la nomination del partito.
Le primarie e i “caucuses” dei due principali partiti politici americani prevedono che gli elettori scelgano in ogni singolo stato non direttamente il candidato alla presidenza, bensì un certo numero di delegati da inviare alla convention del partito, dove saranno loro a votare per l’assegnazione della nomination.
Le regole del Partito Repubblicano, così come in larga misura quelle del Partito Democratico, prevedono che, durante la prima votazione alla convention, il 95% dei delegati provenienti da tutto il paese sia tenuto a dare la propria preferenza in base al risultato delle primarie o dei “caucuses” nei rispettivi stati. La prima votazione riflette così fedelmente l’esito delle elezioni dei mesi precedenti o, meglio, la distribuzione dei delegati che esse hanno decretato.
Se, però, nessun candidato si è assicurato durante primarie e “caucuses” il 50% più uno dei delegati in palio, la prima votazione si risolverà quasi certamente senza l’assegnazione della nomination. In tal caso, alla seconda tornata il 60% dei delegati alla convention può votare per il candidato preferito senza alcun vincolo. Alla terza, poi, la quota di delegati svincolati dal voto delle primarie sale all’80% e così via.
Su questo scenario puntano dunque i leader Repubblicani e i candidati che inseguono Trump – il senatore del Texas, Ted Cruz, e il governatore dell’Ohio, John Kasich – e a tale fine hanno creato strategie relativamente insolite che stanno diventando sempre più chiare in queste settimane.
Il Washington Post ha scritto mercoledì che Cruz e il suo staff sono ormai praticamente certi dell’impossibilità per Trump di ottenere la nomination in un’eventuale seconda votazione alla convention, obbligandolo quindi a raggiungere la maggioranza assoluta dei delegati al termine di primarie e “caucuses”. Se ciò dovesse corrispondere al vero, questo risultato sarebbe determinato dall’opera, ancora in corso, degli uomini di Cruz nelle più o meno oscure assemblee locali e statali, nelle quali si è iniziato a scegliere i delegati da inviare alla convention di Cleveland.
Se ciò dovesse corrispondere al vero, questo risultato sarebbe determinato dall’opera, ancora in corso, degli uomini di Cruz nelle più o meno oscure assemblee locali e statali, nelle quali si è iniziato a scegliere i delegati da inviare alla convention di Cleveland.
In tornate elettorali nelle quali emerge precocemente il favorito alla nomination, queste procedure richiamano ben poca attenzione, ma risultano importanti quando prevale l’equilibrio o, come quest’anno, si prevede che nessun candidato possa ottenere la maggioranza dei delegati in palio.
Le sezioni statali del Partito Repubblicano selezionano in vari stadi i delegati che voteranno alla convention nazionale e se, come già spiegato, essi sono vincolati all’esito di primarie o “caucuses” nella prima votazione, in seguito potranno votare secondo le loro preferenze. Per questa ragione, i candidati alla nomination hanno deciso di intervenire per cercare di influenzare i meccanismi delle assemblee locali, così da cercare di fare eleggere delegati che votino per loro a partire dalla seconda elezione alla convention.
Trump, in realtà, ha mostrato una grave impreparazione in questo ambito, mentre Cruz sta avendo un successo decisamente maggiore. Il senatore ultra-conservatore del Texas ha infatti da tempo costruito una struttura organizzativa capillare ed efficiente in molti stati che sta tornando utile in questo frangente. Trump, al contrario, ha puntato fin dall’inizio sulla sua immagine e sul web, tralasciando i dettagli di una campagna che potrebbe giocarsi proprio su meccanismi di selezione enigmatici e quasi sempre trascurati.
In definitiva, i delegati di parecchi stati potrebbero essere sostenitori di Ted Cruz anche se alla prima votazione alla convention saranno tenuti a votare Trump. Cruz, ad esempio, si è assicurato l’appoggio della maggioranza dei delegati eletti recentemente in Colorado, North Dakota e Iowa. A suo favore dovrebbero impegnarsi, in caso di mancato successo di Trump alla prima votazione, anche un nutrito numero di delegati che verranno selezionati a breve in stati come Indiana, Wyoming e Arkansas.
A sostenere questa campagna anti-Trump è anche l’organizzazione “Our Principles”, una “Super PAC” (“Political Action Committee”) che ha come unico obiettivo quello di far naufragare la corsa del favorito Repubblicano. Le “Super PAC” sono organi previsti dalla legge elettorale USA che hanno la facoltà di raccogliere e spendere cifre illimitate a sostegno di una causa particolare o di un determinato candidato, a patto che non coordinino direttamente con quest’ultimo le loro attività.
La maggior parte dei dollari spesi finora da “Our Principles” è andata a finanziare campagne pubblicitarie per screditare Trump, ma recentemente un certo flusso di denaro è stato destinato anche alle operazioni descritte in precedenza per evitare la selezione di delegati intenzionati a sostenere l’uomo d’affari newyorchese. Per quest’ultimo scopo sono stati spesi finora meno di 100 mila dollari, contro svariati milioni in spot televisivi e su internet. Una simile voce di spesa è però decisamente insolita, o addirittura inedita, per una “Super PAC”.
Trump, da parte sua, non è rimasto a guardare il coalizzarsi di forze a lui ostili nel proprio partito. In alcune apparizioni pubbliche, questa settimana ha sparato a zero contro l’establishment Repubblicano. Il sistema di regole che Cruz sta sfruttando è stato ad esempio definito “truccato” e fatto apposta per “escludere” determinati candidati. Su FoxNews è invece tornato a prospettare possibili disordini nel caso la nomination dovesse essergli sottratta alla convention, ovvero assegnata a un candidato che non ha ottenuto la maggioranza delle preferenze e dei delegati durante primarie e “caucuses”.
Al di là dell’esito finale della sfida Repubblicana, i toni dello scontro, le manovre in atto per ostacolare Donald Trump e lo stesso emergere di quest’ultimo come serio contendente alla Casa Bianca testimoniano dello stato di profonda crisi che sta attraversando il partito. L’emergenza Trump a cui l’apparato di potere Repubblicano sta cercando di far fronte è d’altra parte il risultato di decenni di costante spostamento a destra del partito, assieme all’intero panorama politico americano, e della promozione di forze reazionarie. A tutto ciò vanno aggiunti il persistere degli effetti della crisi economica e il crescente discredito della classe politica di Washington; fattori che hanno finito per lanciare forse per la prima volta negli Stati Uniti un candidato per molti versi dalle caratteristiche di stampo apertamente fascista.
L’emergenza Trump a cui l’apparato di potere Repubblicano sta cercando di far fronte è d’altra parte il risultato di decenni di costante spostamento a destra del partito, assieme all’intero panorama politico americano, e della promozione di forze reazionarie. A tutto ciò vanno aggiunti il persistere degli effetti della crisi economica e il crescente discredito della classe politica di Washington; fattori che hanno finito per lanciare forse per la prima volta negli Stati Uniti un candidato per molti versi dalle caratteristiche di stampo apertamente fascista.
Se anche Trump verrà fermato prima della conquista della nomination, ad ogni modo, la battaglia tra i Repubblicani non potrà che lasciare strascichi pesantissimi in vista del voto di novembre, col rischio forse di spaccare il partito e, quasi certamente, di consegnare la Casa Bianca nuovamente ai Democratici.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Goldman Sachs e il Dipartimento di Giustizia di Washington hanno annunciato questa settimana il raggiungimento di un accordo per il pagamento di una sanzione di circa 5,1 miliardi di dollari a causa del comportamento fraudolento tenuto dal colosso bancario americano alla vigilia dell’esplosione della crisi finanziaria del 2008. Più che una punizione, tuttavia, si tratta appunto di un “accordo” tra le due parti che, nel concreto, risulterà decisamente meno gravoso di quanto appaia per una delle banche più coinvolte nella truffa dei cosiddetti mutui “subprime” negli Stati Uniti.
Goldman Sachs, secondo i termini dell’accordo, ha dovuto ammettere le proprie responsabilità nella vendita ai propri clienti - tra il 2005 e il 2007 - di prodotti finanziari legati a mutui non solvibili, per i quali la banca aveva proposto una “immagine falsa e fuorviante”.
Emblematico della condotta di Goldman Sachs è stato un episodio riportato da vari giornali negli USA e non solo. Un rapporto del 2006 che raccomandava agli investitori di acquistare titoli della banca Countrywide, i cui mutui problematici erano finiti nei prodotti finanziari di Goldman Sachs, era stato commentato in questo modo da un dipendente di quest’ultima: “se solo sapessero”.
Una speciale commissione era stata inoltre creata dalla stessa banca per valutare l’affidabilità dei titoli legati ai mutui da proporre ai clienti, ma tra il 2005 e il 2007 essa non ne aveva bocciato nemmeno uno. I vertici di Goldman Sachs sostengono ora che alla commissione erano state fornite solo informazioni parziali sui prodotti che avrebbero poi contribuito ad affondare l’intero sistema finanziario americano.
L’ammissione di colpa, prevedibilmente, non ha comunque portato né a misure punitive adeguate né, tantomeno, all’incriminazione di un solo dirigente di Goldman Sachs. I termini del patteggiamento rendono dunque risibili le dichiarazioni sull’esemplarità della sanzione rilasciate da vari esponenti del Dipartimento di Giustizia americano, come quelle del numero uno della divisione che si occupa delle cause civili, Benjamin Mizer. Secondo quest’ultimo, “l’accordo odierno è un altro esempio della determinazione del Dipartimento [di Giustizia] di mettere di fronte alle proprie responsabilità quanti, a causa della loro condotta illegale, hanno provocato la crisi finanziaria del 2008”.
Sulla carta, la sanzione “esemplare” imposta o, meglio, concordata e approvata da Goldman Sachs prevede il pagamento di 2,4 miliardi di dollari in sede civile, a cui vanno aggiunti 1,8 miliardi sotto forma di iniziative destinate a investitori e sottoscrittori di mutui penalizzati dalle pratiche della banca, ma anche a comunità negli Stati Uniti gravemente colpite dalla crisi immobiliare. 875 milioni, infine, dovrebbero coprire le richieste di danni avanzate da altre agenzie federali e statali.
Di per sé, le cifre in questione andrebbero a pesare solo in maniera relativamente minima sui profitti di Goldman Sachs. Per il Financial Times, i 5,1 miliardi di dollari totali sarebbero coperti dalla maggior parte degli utili registrati dalla banca solo nel terzo trimestre del 2015.
In realtà, solo una parte di questo importo verrà effettivamente pagato da Goldman Sachs. Come ha spiegato il fondatore dell’organizzazione Better Markets, che si batte per una più severa regolamentazione dell’industria finanziaria, le parti hanno “gonfiato enormemente l’importo della sanzione per scopi di propaganda”. Cioè, sostanzialmente, per “ingannare l’opinione pubblica, mentre i dettagli dell’accordo permetteranno a Goldman Sachs di risparmiare tra il 50% e il 75%” della cifra annunciata. Il New York Times ha scritto martedì che la banca “godrà di considerevoli concessioni” in particolare nell’adottare le iniziative destinate ai consumatori ingannati. Infatti, “in linea di massima, il denaro che Goldman spenderà [a questo scopo] potrà essere detratto dal proprio carico fiscale”. Se la banca dovesse ad esempio sborsare 2,5 miliardi per far fronte ai problemi provocati da essa stessa agli investitori e l’aliquota teorica a cui è soggetta sarà del 35%, vale a dire quella nominalmente prevista per le corporation negli USA, potrà ottenere un credito fiscale pari a 875 milioni di dollari.
Il New York Times ha scritto martedì che la banca “godrà di considerevoli concessioni” in particolare nell’adottare le iniziative destinate ai consumatori ingannati. Infatti, “in linea di massima, il denaro che Goldman spenderà [a questo scopo] potrà essere detratto dal proprio carico fiscale”. Se la banca dovesse ad esempio sborsare 2,5 miliardi per far fronte ai problemi provocati da essa stessa agli investitori e l’aliquota teorica a cui è soggetta sarà del 35%, vale a dire quella nominalmente prevista per le corporation negli USA, potrà ottenere un credito fiscale pari a 875 milioni di dollari.
In definitiva, Goldman Sachs avrà di fatto la possibilità di pagare una cifra molto inferiore rispetto a quella che sembrerebbe essere stata fissata dall’accordo, a detta del Times non più di 4 miliardi. Tutte le condizioni che consentono un simile risparmio sono descritte in vari allegati che di solito accompagnano i patteggiamenti tra il Dipartimento di Giustizia e i grandi istituti finanziari.
Le stesse banche che negli anni scorsi sono state colpite da sanzioni hanno beneficiato di “sconti” vari, prevalentemente sotto forma di crediti d’imposta. Goldman Sachs, però, sembra essere riuscita a spuntare condizioni migliori rispetto ad altre, con ogni probabilità grazie a legali più capaci o con legami più importanti all’interno del governo.
Goldman Sachs, ad esempio, ha ottenuto un credito d’imposta di 1,5 dollari per ogni dollaro di debito cancellato entro i primi sei mesi dalla firma dell’accordo, mentre JPMorgan Chase nel 2013 dovette accontentarsi di 1,15 dollari.
Un anonimo esponente del Dipartimento di Giustizia ha spiegato sempre al New York Times che Goldman Sachs ha avuto questo trattamento di favore per avere accettato di impegnarsi in “attività incoraggiate dal governo, come il finanziamento di abitazioni destinate ai redditi più bassi o il sostegno ad aree colpite da calamità naturali”. La stessa fonte ha però anche ammesso che i termini dell’accordo sono stati in larga misura il risultato delle trattative tra la banca e il governo, ovvero della capacità della prima di convincere quest’ultimo a non imporre misure eccessivamente gravose.
Quello con Goldman Sachs è il quinto patteggiamento raggiunto dal Dipartimento di Giustizia dal 2012, quando il presidente Obama creò una commissione (“Residential Mortgage-Backed Securities Working Group”) incaricata precisamente di far luce sulla condotta delle grandi banche di Wall Street responsabili del disastro finanziario scoppiato nel 2008.
L’amministrazione Obama ha in realtà fatto di tutto da allora per salvare gli istituti e i loro vertici dalle conseguenze legali di pratiche criminali descritte qualche anno fa nel dettaglio e con toni molto duri anche da una commissione di indagine del Senato. Le iniziative prese dal governo di Washington servono e sono servite più che altro a placare l’avversione popolare nei confronti degli istituti finanziari.
Oltre a Goldman Sachs, hanno già patteggiato sanzioni con il Dipartimento di Giustizia per gli abusi legati ai “subprime” anche JPMorgan Chase (13 miliardi di dollari), Bank of America (16,6 miliardi), Citibank (7 miliardi) e Morgan Stanley (3,2 miliardi). In questi e altri casi, relativi a crimini finanziari di diversa natura, le ammende sono state concordate con i colpevoli e gli importi dichiarati sono sempre risultati di molto superiori a quelli effettivamente pagati o da pagare. Quella finanziaria è d’altra parte una delle industrie che ha la maggiore influenza sulla politica americana e, di conseguenza, sulle agenzie di regolamentazione del settore in cui operano. Le dimensioni raggiunte dalle principali banche, come ammise qualche anno fa l’allora ministro della Giustizia, Eric Holder, le rende inoltre agli occhi del governo e del Congresso “too big to fail” - troppo grandi per fallire - così che i provvedimenti nei loro confronti non possono in nessun modo comprometterne la stabilità.
Quella finanziaria è d’altra parte una delle industrie che ha la maggiore influenza sulla politica americana e, di conseguenza, sulle agenzie di regolamentazione del settore in cui operano. Le dimensioni raggiunte dalle principali banche, come ammise qualche anno fa l’allora ministro della Giustizia, Eric Holder, le rende inoltre agli occhi del governo e del Congresso “too big to fail” - troppo grandi per fallire - così che i provvedimenti nei loro confronti non possono in nessun modo comprometterne la stabilità.
Le sanzioni modeste - in relazione ai loro profitti - che sono chiamate a pagare, per lo meno quando viene scongiurata la totale impunità, cioè nella maggior parte dei casi, corrispondono così sostanzialmente a una sorta di tassa da corrispondere di quando in quando per poter continuare a fare affari (enormi) senza preoccuparsi delle regole o della sorte di decine di milioni di persone.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La visita a sorpresa nel fine settimana in Afghanistan del segretario di Stato americano, John Kerry, è giunta nel pieno della grave crisi politica che sta attraversando il fragile governo di “unità nazionale” del paese sotto occupazione USA dal 2001. Il capo della diplomazia statunitense ha cercato di invitare tutte le parti coinvolte a collaborare per il bene del paese, ribadendo la fiducia in un esecutivo che egli stesso aveva contribuito in maniera decisiva a far nascere nel 2014 dopo le ennesime elezioni contestate.
L’accordo che Kerry aveva mediato quasi due anni fa prevedeva l’affiancamento al presidente, Ashraf Ghani, della figura di un “chief executive” nella persona di Abdullah Abdullah, cioè il principale sfidante di Ghani nelle elezioni. I due avrebbero dovuto costituire una sorta di super-governo per superare le divisioni etniche e gli interessi di parte che minacciavano di far scivolare il paese nuovamente nella guerra civile.
Il ruolo assegnato a Abdullah non era previsto dalla costituzione afgana, così che alcune modifiche a quest’ultima avrebbero dovuto creare la posizione di primo ministro per legittimare l’intesa tra i due contendenti alla presidenza. Quello che era stato salutato nel 2014 come un successo della diplomazia USA è diventato però l’ennesimo incubo, soprattutto per la popolazione afgana, costretta a far fronte alle conseguenze della paralisi politica che ne è derivata, ma anche della consueta corruzione dilagante, dell’aggravamento della sicurezza interna e del persistere dello sfacelo dell’economia.
Sabato a Kabul, Kerry ha provato comunque a ostentare un qualche ottimismo o, per lo meno, ad assicurare i vertici politici afgani della fiducia dell’amministrazione Obama in un processo che, come hanno ammesso molti diplomatici occidentali alla stampa internazionale, non ha al momento alternative percorribili. Così, anche se la scadenza del governo di “unità nazionale” era stata fissata per il prossimo mese di ottobre, data in cui dovrebbero tenersi le elezioni parlamentari, già si parla di un quasi certo rinvio almeno alla primavera del 2017, vista l’assenza di progressi sulla riforma elettorale promessa.
Lo stesso Kerry ha affermato che il patto tra Ghani e Abdullah ha validità per tutto il mandato elettorale – cinque anni – e il governo in carica ha legittimità per proseguire con l’attuale formula, quindi anche senza modifiche alla Costituzione. La benedizione americana al gabinetto di Kabul non è necessariamente di buon auspicio per la stabilità afgana, anzi, il permanere dello stallo che ha caratterizzato questi mesi rischia di aggravare i già enormi problemi del paese ma, ancora una volta, per le forze di occupazione l’alternativa potrebbe risultare anche peggiore.
Qualche progresso o, meglio, la sopravvivenza di una struttura di governo a livello centrale con un livello minimo di legittimità agli occhi della comunità internazionale è d’altra parte condizione indispensabile per convincere i paesi occidentali già scettici a non interrompere il flusso di denaro che tiene in piedi l’economia dell’Afghanistan e le sue forze di sicurezza.
A Varsavia nel mese di luglio si terrà un importante summit della NATO nel quale dovrebbero essere discusse le modalità per finanziare il rafforzamento delle forze armate afgane, mentre a ottobre a Bruxelles sarà l’entità degli aiuti finanziari civili a essere al centro dell’attenzione. A sottolineare quanto siano cruciali questi appuntamenti per il futuro del governo-fantoccio di Kabul è stato Kerry nel fine settimana, quando nella conferenza stampa con il presidente Ghani ha inviato quest’ultimo ad “assicurarsi che tra oggi e i vertici di Varsavia e Bruxelles, l’Afghanistan si mantenga nella giusta direzione”. Intanto, forse anche grazie alla presenza di Kerry a Kabul, sabato il parlamento afgano ha finalmente approvato la nomina di due membri del governo, il ministro dell’Interno e il Procuratore Generale, i quali, assieme al ministro della Difesa e al capo dell’intelligence, hanno ricoperto finora i loro incarichi in via provvisoria. Il nuovo ministro dell’Interno – generale Taj Mohammad Jahid – è un fedelissimo di Abdullah ed era stato nominato nel mese di febbraio in seguito alle dimissioni del suo predecessore.
Intanto, forse anche grazie alla presenza di Kerry a Kabul, sabato il parlamento afgano ha finalmente approvato la nomina di due membri del governo, il ministro dell’Interno e il Procuratore Generale, i quali, assieme al ministro della Difesa e al capo dell’intelligence, hanno ricoperto finora i loro incarichi in via provvisoria. Il nuovo ministro dell’Interno – generale Taj Mohammad Jahid – è un fedelissimo di Abdullah ed era stato nominato nel mese di febbraio in seguito alle dimissioni del suo predecessore.
Proprio una serie di dimissioni nelle ultime settimane ha ulteriormente indebolito il governo, contribuendo a intensificare le richieste di dimissioni rivolte a Ghani da parte di svariati leader dell’opposizione e di membri del precedente governo dell’ex presidente, Hamid Karzai.
La stabilità del governo di Kabul e la situazione relativa alla sicurezza interna influenzeranno poi la decisione di Washington di mantenere o ridurre il contingente di occupazione in Afghanistan, peraltro legata anche alle dinamiche strategiche in Asia centrale che appaiono in fase di riallineamento soprattutto riguardo la Cina e il Pakistan.
Obama aveva già congelato il numero di truppe USA a 9.800 per l’intero 2016, ma a partire dal 2017 gli uomini dovrebbero scendere a 5.500. I leader militari americani mettono però in guardia da mosse affrettate, se di fretta si può parlare dopo quasi 15 anni di occupazione, facendo notare come nell’ultimo periodo la situazione interna in Afghanistan sia nuovamente peggiorata. Kerry, da parte sua, ha affermato che la riduzione nel numero dei propri soldati non è in discussione, salvo poi vincolare ogni iniziativa al “parere” dei generali.
I Talebani sono tornati d’altronde a condurre operazioni con un certo successo, in taluni casi anche in maniera clamorosa, e controllano oggi circa un terzo del territorio afgano. I colloqui di pace con gli studenti del Corano appaiono inoltre in alto mare, nonostante Kerry abbia rinnovato una vaga offerta di sedersi al tavolo delle trattative con gli “insorti” nel corso della sua visita.
La precarietà degli scenari afgani e le prospettive ben poco rosee per il futuro di questo paese sono apparse evidenti proprio subito dopo la partenza di Kerry da Kabul, quando un paio di esplosioni hanno colpito il quartiere diplomatico della capitale.
Al di là delle dichiarazioni ottimistiche e degli inviti, seguiti da immancabili promesse, alla costruzione di istituzioni democratiche in Afghanistan, il bilancio della più lunga guerra della storia americana continua a essere rovinoso. Gli stessi giornali ufficiali negli USA faticano a nascondere una realtà che, nelle parole ad esempio del Washington Post, è fatta prevalentemente di “illegalità, corruzione” ed “espansione dell’influenza dei Talebani”.
Il caso della provincia meridionale di Helmand è emblematico del fallimento del progetto americano di stabilizzazione dell’Afghanistan a oltre 14 anni dall’invasione seguita agli attentati dell’11 settembre 2001. Un’indagine pubblicata settimana scorsa dal New York Times ha messo in luce come Helmand continui a fornire i due terzi dell’eroina prodotta in Afghanistan, paese da cui a sua volta proviene il 90% del totale consumato nel pianeta. In questa provincia, per quest’anno non è in programma nessuna operazione per sradicare le coltivazioni della materia prima destinata alla produzione di eroina, il papavero da oppio, a causa dell’avanzata dei Talebani ma anche della corruzione “fuori controllo”.
In questa provincia, per quest’anno non è in programma nessuna operazione per sradicare le coltivazioni della materia prima destinata alla produzione di eroina, il papavero da oppio, a causa dell’avanzata dei Talebani ma anche della corruzione “fuori controllo”.
La marcia indietro rispetto agli sforzi del 2014 e del 2015 è dovuta infatti principalmente proprio agli interessi economici che sostengono la coltivazione del papavero da oppio, la quale consente a molti uomini di potere, sia a livello locale che a Kabul, sia tra i Talebani che gli esponenti del governo, di intascare centinaia di migliaia, se non milioni, di dollari.
