- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
All’inizio di questa settimana, il primo ministro conservatore neozelandese, John Key, in carica da oltre otto anni, ha annunciato a sorpresa le proprie dimissioni, lasciando il suo Partito Nazionale in cerca di un nuovo leader che lo sostituisca alla guida del paese dell’oceano Pacifico a poco meno di un anno dal voto per il rinnovo del parlamento.
L’addio di Key sembra essere stato un vero e proprio shock sia per i media locali e internazionali sia per la classe politica della Nuova Zelanda. Gli stessi compagni di partito e i membri del suo gabinetto, alcuni dei quali si sono già candidati alla successione, hanno manifestato stupore alla notizia delle dimissioni, comunicata privatamente solo poche ore prima dell’annuncio pubblico.
Oltre a non esserci stati segnali apparenti delle intenzioni del premier, la sua guida del governo è considerata tra le più salde nei paesi “avanzati”. Praticamente tutti i media ufficiali in Occidente hanno parlato in questi giorni della stabilità della Nuova Zelanda e di un’economia robusta nonostante gli effetti della crisi globale e una serie di terremoti devastanti che hanno colpito il paese negli ultimi anni.
Key, da parte sua, ha motivato la decisione di lasciare con il desiderio di dedicare più tempo e attenzioni alla sua famiglia. Simili giustificazioni sono tutt’altro che rare tra i leader politici, soprattutto nel mondo anglo-sassone, ma servono quasi sempre a nascondere le vere ragioni che stanno dietro a scelte così radicali, soprattutto se impreviste o apparentemente tali.
Il Partito Nazionale, formazione di maggioranza in una coalizione che include altri partiti minori, si riunirà il prossimo 12 dicembre per eleggere il nuovo leader che, automaticamente, assumerà l’incarico di primo ministro. John Key ha già fatto sapere di appoggiare il suo ministro delle Finanze, Bill English, artefice, assieme al premier uscente, dell’adozione di politiche economiche di stampo neo-liberista in questi otto anni di governo.
Gli altri due principali contendenti di English sono anch’essi ministri del governo Key e hanno entrambi le necessarie credenziali per guidare un partito e un governo di destra. Judith Collins è l’attuale ministro che sovrintende alle forze di Polizia, alle quali ha garantito poteri sempre più ampi, mentre nel marzo del 2014 fu costretta alle dimissioni da ministro della Giustizia in seguito all’emergere dei suoi legami con un blogger di estrema destra. Jonathan Coleman è invece il ministro della Sanità e si è distinto in particolare per gli sforzi prodotti nel ridurre i fondi destinati all’assistenza pubblica.
Chiunque sarà scelto per succedere a John Key si troverà a guidare un partito che ha vinto le ultime tre elezioni in Nuova Zelanda e, almeno finora, è dato per favorito sul principale partito di opposizione, quello Laburista. Secondo un recente sondaggio, il Partito Nazionale è accreditato del 49,5% dei consensi, contro il 37,5% che otterrebbe un’eventuale alleanza elettorale tra il “Labour” e i Verdi.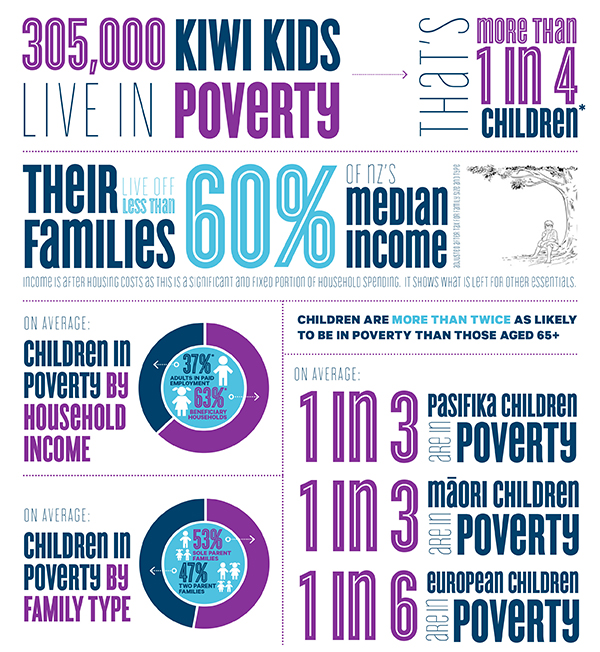 L’apparente popolarità della destra neozelandese e del governo Key nasconde però una strisciante ostilità nel paese e diffuse tensioni sociali, contenute dall’assenza di una reale alternativa politica, visto anche il discredito del Partito Laburista.
L’apparente popolarità della destra neozelandese e del governo Key nasconde però una strisciante ostilità nel paese e diffuse tensioni sociali, contenute dall’assenza di una reale alternativa politica, visto anche il discredito del Partito Laburista.
Al di là dell’immagine di prosperità e solidità del sistema neozelandese offerta dalla stampa e dagli ambienti finanziari internazionali, la situazione interna al paese è quanto meno contraddittoria e anche qui non si sono evitate le misure di ristrutturazione economica che hanno colpito lavoratori, giovani e anziani.
Le fasce più disagiate della popolazione anche in Nuova Zelanda hanno dovuto fare i conti con anni di austerity. Il governo Key ha presieduto non solo a un ridimensionamento del welfare e all’abbattimento del carico fiscale per i più ricchi, ma ha fatto ben poco per invertire il processo di deindustrializzazione e la crisi del settore estrattivo.
A ciò vanno aggiunte anche le ripercussioni dovute alle rivelazioni sull’esistenza di un sistema segreto di sorveglianza di massa, condotto dall’intelligence in accordo con il governo americano.
Inoltre, svariati studi hanno ad esempio messo in evidenza l’esplosione di una bolla speculativa nel settore edilizio che ha fatto salire a livelli proibitivi il costo delle abitazioni. Ancora, il numero di minori che vivono al di sotto del livello di povertà è salito in maniera consistente in parallelo all’esclusione di migliaia di famiglie dall’accesso ai benefit garantiti in precedenza.
La Nuova Zelanda ha infine risentito negativamente, come la vicina Australia, del rallentamento dell’economia cinese, con la quale i rapporti commerciali sono cresciuti esponenzialmente nell’ultimo decennio.
Ai malumori presenti nel paese ha fatto riferimento in maniera velata proprio uno dei favoriti alla successione del primo ministro uscente, il ministro delle Finanze Bill English. In un’apparizione di fronte alla stampa nella capitale, Wellington, quest’ultimo ha promesso una distribuzione dei frutti della crescita economica a un numero maggiore di neozelandesi, evidentemente frustrati dall’aggravamento delle disuguaglianze alimentate dai governi conservatori e Laburisti negli ultimi due decenni.
Per quanto riguarda le dimissioni di John Key, è per ora impossibile conoscere le vere ragioni che lo hanno spinto a farsi da parte. La sua scelta è avvenuta però in circostanze del tutto particolari che stanno avendo un impatto non indifferente sulla Nuova Zelanda, così come su molti altri paesi dell’area asiatica e del Pacifico.
Il fattore principale è l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e il conseguente rafforzamento delle spinte nazionaliste e protezioniste in quello che è il principale alleato della classe dirigente neozelandese. Proprio il primo ministro Key era stato nelle scorse settimane uno dei più accesi difensori del libero commercio e di una globalizzazione ritenuta ora in pericolo in vista dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca.
L’economia della Nuova Zelanda si fonda principalmente sull’export e Key si era adoperato per la promozione del trattato di libero scambio denominato Partnership Trans Pacifica (TPP), lanciato dall’amministrazione Obama e ora sull’orlo del fallimento dopo la vittoria di Trump nelle elezioni di novembre. Oltre al probabile naufragio del TPP, l’era Trump potrebbe portare con sé anche un aggravamento dello scontro con la Cina, del quale Wellington subirebbe il contraccolpo, visti i vincoli con Washington e i già ricordati rapporti commerciali con Pechino. Significativa, forse anche per comprendere le sue dimissioni, era stata la difesa da parte di Key dei principi del libero scambio durante il summit del gruppo APEC (Cooperazione Economica dell’Asia e del Pacifico), tenuto in Perù lo scorso 20 novembre. Nell’affermare la partnership con gli Stati Uniti e la necessità della presenza americana nell’area del Pacifico, il primo ministro neozelandese aveva messo in guardia e assieme previsto l’inevitabile allargamento dell’influenza cinese nel caso di un disimpegno da parte di Washington.
Significativa, forse anche per comprendere le sue dimissioni, era stata la difesa da parte di Key dei principi del libero scambio durante il summit del gruppo APEC (Cooperazione Economica dell’Asia e del Pacifico), tenuto in Perù lo scorso 20 novembre. Nell’affermare la partnership con gli Stati Uniti e la necessità della presenza americana nell’area del Pacifico, il primo ministro neozelandese aveva messo in guardia e assieme previsto l’inevitabile allargamento dell’influenza cinese nel caso di un disimpegno da parte di Washington.
Anzi, in una delle ultime iniziative da capo del governo, a fine novembre Key aveva annunciato l’avvio dei negoziati per portare a un livello superiore il trattato di libero scambio con la Cina, che la Nuova Zelanda aveva sottoscritto già nel 2008.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La telefonata dello scorso fine settimana tra il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha portato all’ordine del giorno la più che probabile evoluzione in senso negativo dei rapporti tra Washington e Pechino che si prospetta dopo l’insediamento alla Casa Bianca della nuova amministrazione Repubblicana.
Anche se in molti, dagli USA alla Cina, hanno provato a giustificare il gesto provocatorio come un errore di valutazione dovuto all’inesperienza di Trump in politica estera o, quanto meno, un innocente conversazione in occasione dell’elezione di quest’ultimo, il gesto sembra essere stato tutt’altro che casuale ed è anzi perfettamente in linea con l’attitudine del miliardario newyorchese verso la seconda potenza economica mondiale.
Trump e la presidente taiwanese del Partito Progressista Democratico (DPP), che promuove cautamente la causa indipendentista dell’isola, si sono sentiti per telefono venerdì scorso in quello che è stato il primo colloquio diretto ufficiale tra i leader dei due paesi a partire dal 1979.
In questa data, USA e Taiwan avevano interrotto formalmente le relazioni diplomatiche a causa del riconoscimento della Cina da parte americana, principalmente in funzione anti-sovietica. I rapporti, regolati dal cosiddetto “Taiwan Relations Act”, firmato dal presidente Carter nel 1979, sarebbero comunque proseguiti in maniera non ufficiale, sanzionando una voluta ambiguità che non ha evitato manifestazioni di scontento da parte di Pechino, soprattutto in occasione dei trasferimenti di armi da Washington a Taipei.
Ufficialmente, però, gli Stati Uniti hanno sempre abbracciato la politica di “una sola Cina” e le pratiche diplomatiche seguite da tutte le amministrazioni in quasi quattro decenni hanno evitato provocazioni come quella che ha visto protagonista Trump nei giorni scorsi.
La rottura della pratica consolidata nei rapporti con Cina e Taiwan da parte del neo-presidente americano è apparsa ancora più grave alla luce dei probabili contenuti della telefonata con Tsai Ing-wen. Quest’ultima ha affermato che il colloquio non è consistito semplicemente nelle solite formalità che accompagnano un’elezione, ma ha toccato questioni di natura economica e strategica in relazione ai rapporti bilaterali e agli eventi nel continente asiatico.
I tentativi dell’entourage di Trump di minimizzare la portata della conversazione sono stati ad ogni modo smentiti dallo stesso presidente eletto. Se di avventatezza si fosse trattato, Trump non avrebbe ad esempio scritto una serie di “tweet” nel fine settimana diretti contro la Cina. In uno di questi si è chiesto ironicamente se Pechino abbia mai chiesto il parere americano prima di “svalutare la propria moneta” o di “costruire un imponente sistema militare nel Mar Cinese Meridionale”.
Il Washington Post ha inoltre scritto che la telefonata non è stata un evento estemporaneo, bensì una mossa studiata, frutto di “mesi di preparazioni e considerazioni da parte dei consiglieri di Trump su una nuova strategia da tenere nei confronti di Taiwan”. Da un certo punto di vista, Trump ha messo in luce l’ipocrisia dell’atteggiamento ufficiale degli Stati Uniti nei confronti della questione di Taiwan, giudicando “interessante” il modo in cui Washington “venda armi per miliardi di dollari” a Taipei quando il nuovo inquilino della Casa Bianca “non può accettare una telefonata di congratulazioni” dal presidente di questo paese.
Da un certo punto di vista, Trump ha messo in luce l’ipocrisia dell’atteggiamento ufficiale degli Stati Uniti nei confronti della questione di Taiwan, giudicando “interessante” il modo in cui Washington “venda armi per miliardi di dollari” a Taipei quando il nuovo inquilino della Casa Bianca “non può accettare una telefonata di congratulazioni” dal presidente di questo paese.
Tuttavia, l’apparente predisposizione di Trump a trasgredire le regole di una politica basata puramente sulla forma a favore di misure e iniziative concrete che vadano al cuore delle questioni, porta con sé in questo caso la minaccia di un aggravamento delle tensioni già vicine al livello di guardia tra Stati Uniti e Cina.
A ben vedere, l’ultima performance di Trump in merito a Taiwan è la logica conseguenza delle promesse fatte in campagna elettorale per cercare di colpire gli interessi economici e strategici di Pechino, come quella di applicare pesantissimi dazi sulle esportazioni cinesi dirette verso il mercato americano.
Tutto ciò prospetta un ulteriore peggioramento dei rapporti tra Washington e Pechino nel prossimo futuro. L’aggressività, per ora solo verbale, di Trump si innesta peraltro sulla condotta tenuta dall’amministrazione Obama fin dall’annuncio della cosiddetta “svolta” asiatica che ha comportato, negli ultimi anni, una escalation di dichiarazioni provocatorie e iniziative diplomatico-militari in Asia sud-orientale per accerchiare la Cina e cercare di contenerne in tutti modi l’ascesa.
L’aspetto preoccupante delle prese di posizione di Trump è che le provocazioni dell’amministrazione Democratica uscente, malgrado abbiano già fatto aumentare il rischio di uno scontro militare tra le due potenze nucleari, minacciano di moltiplicarsi rapidamente. Una simile evoluzione si intravede dalle dichiarazioni di vari “falchi” coinvolti nel processo di transizione verso la Casa Bianca o candidati ad assumere incarichi di rilievo nel nuovo governo Trump.
Uno di questi è John Bolton, ex ambasciatore alle Nazioni Unite durante la presidenza Bush e preso in considerazione per la carica di segretario di Stato. Bolton ha recentemente auspicato una “scossa” nelle relazioni con Pechino, ovviamente nel senso di una maggiore aggressività americana nel contrastare l’espansione cinese in Asia e non solo. L’ex “speaker” della Camera del Congresso americano, Newt Gingrich, in un’apparizione nella mattinata di domenica su FoxNews, ha invece assicurato che Trump intende “rompere” con l’atteggiamento troppo “timido” del dipartimento di Stato.
A fianco di Trump, in definitiva, ci sono consiglieri e aspiranti a ruoli di governo che hanno denunciato e continuano a denunciare come troppo prudente la condotta di Obama verso la Cina e la sua espansione economica e militare.
Che Trump intenda muoversi in questa direzione è risultato chiaro anche dal mancato coordinamento con il dipartimento di Stato nel prendere contatti con la presidente di Taiwan e dalla reazione sorpresa e irritata della Casa Bianca, da dove è stato confermato il rispetto della politica di “una sola Cina” e l’interesse per la stabilità dei rapporti tra Pechino e Taipei.
Se solo lo scorso anno l’amministrazione Obama aveva creato parecchi malumori all’interno del regime cinese in seguito all’approvazione di una fornitura di armi a Taiwan per quasi due miliardi di dollari, una parte della classe dirigente americana ha tutto l’interesse a evitare il precipitare delle relazioni con la Cina in questo frangente. Alcune delle ragioni di questa cautela sono state spiegate ad esempio da una dichiarazione riportata dal Financial Times del presidente della Camera di Commercio Americana in Cina, James Zimmerman, il quale ha avvertito che “il business USA ha bisogno di certezze e stabilità”.
Le preoccupazioni sono alimentate anche dalla comprensibile reazione della Cina, da dove Taiwan è considerata una provincia ribelle che finirà prima o poi per tornare sotto il controllo della madrepatria. Pechino ha presentato una protesta formale al governo americano, mentre numerosi sono stati i commenti alla vicenda apparsi sugli organi ufficiali di stampa. Dagli editoriali che hanno giudicato la telefonata come un “errore” dovuto all’inesperienza di Trump ad avvertimenti circa la spirale negativa in cui potrebbe entrare la relazione con Washington a partire da gennaio, la risposta cinese ha mostrato come ci sia parecchia apprensione per il nuovo governo che si insedierà a Washington.
Dagli editoriali che hanno giudicato la telefonata come un “errore” dovuto all’inesperienza di Trump ad avvertimenti circa la spirale negativa in cui potrebbe entrare la relazione con Washington a partire da gennaio, la risposta cinese ha mostrato come ci sia parecchia apprensione per il nuovo governo che si insedierà a Washington.
Una certa preoccupazione l’ha espressa proprio il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un incontro nella giornata di venerdì con Henry Kissinger, architetto della distensione tra USA e Cina durante la presidenza Nixon. A conferma dell’allarme suonato a Pechino dopo il voto dell’8 novembre scorso, Xi ha affermato che il suo governo “sta seguendo attentamente la situazione [a Washington]”, dal momento che i rapporti bilaterali sono entrati in quella che ha definito “una fase critica”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
L’annuncio dei risultati provvisori delle elezioni presidenziali a Haiti, tenute il 20 novembre scorso, è stato seguito da proteste di piazza e scontri con le forze di polizia, nonché da prevedibili denunce di brogli formulate dai candidati dichiarati perdenti. A superare da subito la soglia del 50% dei voti, utile per evitare il secondo turno di ballottaggio, è stato il semi-sconosciuto imprenditore Jovenel Moïse, candidato promosso dal discusso presidente uscente, Michel Martelly, dopo che già si era imposto nel voto, successivamente annullato, dell’ottobre 2015.
Secondo la commissione elettorale haitiana, Moïse ha ottenuto il consenso di oltre il 55% dei votanti, ben davanti al secondo classificato tra gli altri 26 sfidanti, Jude Célestin, della Lega Alternativa per il Progresso e l’Emancipazione Haitiana (LAPEH). Célestin, fermatosi a poco meno del 20%, era finito dietro Moïse anche tredici mesi fa, ma aveva boicottato un secondo turno elettorale che, a causa di brogli diffusi, sarebbe stato poi cancellato.
I risultati preliminari resi noti questa settimana possono essere contestati e lo saranno con ogni probabilità da parte dei candidati sconfitti, visto che le segnalazioni di abusi e brogli sono già numerose in tutta l’isola caraibica. Se le autorità non rileveranno però irregolarità tali da modificare l’esito del voto, i risultati saranno ratificati il 29 dicembre e il nuovo presidente verrà insediato ai primi di febbraio.
A protestare maggiormente in questi giorni sono i sostenitori del partito Fanmi Lavalas dell’ex presidente Jean-Bertrand Aristide, primo capo dello stato di Haiti eletto democraticamente e due volte deposto da golpe organizzati da Washington. La candidata di questo partito, Maryse Narcisse, nonostante la popolarità tra i poveri haitiani di Aristide, il quale aveva invitato a votare per lei, avrebbe raccolto solo il 9% dei suffragi.
Il risultato del voto del 20 novembre, se confermato, rappresenta così una vittoria per il presidente uscente Martelly e il suo partito Tèt Kale (“teste calve”). Martelly è un ex cantante del genere musicale haitiano Kompa e non ha mai nascosto le sue simpatie per la dittatura dei Duvalier che ha guidato con l’isola con il pugno di ferro fino al 1986.
Il suo mandato è stato segnato fondamentalmente da tre fattori: i legami con il governo americano, l’impegno a favorire le attività del business domestico e internazionale nel suo paese e le accuse di corruzione. A ciò va aggiunta l’inclinazione all’autoritarismo, evidente dalla decisione di governare per decreto dopo lo scioglimento nel gennaio 2015 del parlamento, rinnovato con il voto popolare solo nell’agosto seguente.
Nel febbraio 2016, al termine del suo mandato, Martelly si era infine dimesso malgrado non fosse stato ancora eletto il suo successore a causa della già ricordata cancellazione del voto nell’ottobre precedente. I poteri provvisori di capo di stato erano stati allora trasferiti al presidente del Senato, Jocelerme Privert, del partito di centro-sinistra Inite, a cui appartiene anche l’ex presidente René Préval. Dopo un’ennesima grave crisi politica, era stata raggiunta un’intesa per organizzare le presidenziali in data 9 ottobre, ma l’arrivo dell’uragano Matthew aveva determinato lo spostamento al 20 di novembre. La devastazione provocata da questa nuova catastrofe naturale a Haiti ha influito sul voto, in particolare sull’affluenza, risultata di poco superiore al 20%. Inoltre, in molti tra le decine di migliaia di persone colpite dall’uragano hanno perso i loro documenti d’identità, necessari per presentarsi ai seggi, ma solo una minima parte ha fatto richiesta per ottenerne di nuovi prima delle elezioni.
Dopo un’ennesima grave crisi politica, era stata raggiunta un’intesa per organizzare le presidenziali in data 9 ottobre, ma l’arrivo dell’uragano Matthew aveva determinato lo spostamento al 20 di novembre. La devastazione provocata da questa nuova catastrofe naturale a Haiti ha influito sul voto, in particolare sull’affluenza, risultata di poco superiore al 20%. Inoltre, in molti tra le decine di migliaia di persone colpite dall’uragano hanno perso i loro documenti d’identità, necessari per presentarsi ai seggi, ma solo una minima parte ha fatto richiesta per ottenerne di nuovi prima delle elezioni.
A scoraggiare i votanti sono state anche le restrizioni imposte dal governo per evitare disordini durante la consultazione, così come lo schieramento di quasi diecimila poliziotti e più di tremila caschi blu del contingente ONU (MINUSTAH) stanziato sull’isola.
Se anche i dati provvisori diffusi nei giorni scorsi dovessero essere corretti, è evidente che l’astensione - volontaria o più probabilmente forzata - ha riguardato gli elettori più poveri e disperati, cioè la maggioranza a Haiti, con ovvie ripercussioni sugli equilibri tra i candidati. La vittoria di Moïse sembra essere stata perciò assicurata soprattutto dal voto delle classi più benestanti, come confermano i festeggiamenti andati in scena a Pétionville, sobborgo ricco della capitale, Port-au-Prince.
I sospetti sui brogli sono comunque giustificati, se non altro alla luce della storia elettorale haitiana. Come molti altri in precedenza, il voto dell’ottobre 2015 era stato ad esempio caratterizzato da clamorose illegalità e per questo rimandato più volte prima di essere annullato definitivamente. Osservatori locali ai seggi e candidati dell’opposizione avevano denunciato manipolazioni per favorire Jovenel Moïse, il quale comunque, a differenza dell’elezione del 20 novembre scorso, si era fermato a poco meno del 33%.
Va ricordato, però, che gli Stati Uniti, l’Unione Europea e l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) avevano ratificato l’esito del voto, dichiarandolo regolare. Memorabile fu in particolare la dichiarazione del capo degli osservatori UE, l’euro-deputata del Partito Socialista Spagnolo Elena Valenciano, la quale aveva definito le elezioni “un respiro di speranza per la democrazia haitiana”.
Come sarebbe emerso in seguito, le massicce frodi elettorali erano state attuate soprattutto per mezzo dei cosiddetti “mandataires”, cioè osservatori affiliati ai partiti che avevano ricevuto appositi permessi per votare liberamente e di fatto senza verifiche nei seggi che erano stati incaricati di controllare invece che nel loro luogo di residenza.
Queste autorizzazioni si erano moltiplicate a dismisura, tanto che se ne sarebbero contate più di 900 mila, spesso vendute per pochi dollari. In questo modo, un “osservatore” aveva la possibilità di votare più volte in seggi diversi. Nelle elezioni appena concluse i permessi di questo genere sono scesi a circa 126 mila, ma in molti hanno comunque segnalato episodi più che sospetti. Se i dati preliminari saranno confermati, in ogni caso, il prossimo presidente di Haiti sarà dunque Jovenel Moïse. Quest’ultimo non ha praticamente nessuna esperienza politica, ma è proprietario di una piantagione di banane nel nord dell’isola. Inoltre, nel 2014 Moïse ha fondato una joint venture con il governo per coltivare ed esportare frutta da Haiti verso l’Europa grazie a un prestito da 6 milioni di dollari approvato dall’amministrazione del presidente Martelly.
Se i dati preliminari saranno confermati, in ogni caso, il prossimo presidente di Haiti sarà dunque Jovenel Moïse. Quest’ultimo non ha praticamente nessuna esperienza politica, ma è proprietario di una piantagione di banane nel nord dell’isola. Inoltre, nel 2014 Moïse ha fondato una joint venture con il governo per coltivare ed esportare frutta da Haiti verso l’Europa grazie a un prestito da 6 milioni di dollari approvato dall’amministrazione del presidente Martelly.
In precedenza era stato segretario della Camera di Commercio del paese e, almeno secondo le informazioni diffuse in campagna elettorale, è stato protagonista di un progetto che ha assicurato fonti di energia eolica e solare a dieci “comunità” haitiane.
Se Moïse resta per il momento un oggetto misterioso dal punto di vista politico, quel che è certo è che la sua ascesa è dovuta interamente ai legami con il presidente uscente Martelly e che di quest’ultimo seguirà il percorso una volta assunti i poteri. Ciò sembra garantire, nonostante le promesse, che la disperata situazione economica e sociale della grande maggioranza degli abitanti del paese più povero dell’emisfero occidentale non vedrà miglioramenti significativi nemmeno nel prossimo futuro.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Il neo-eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riservato parole acide, volgari e senza senso nei confronti di Fidel Castro. Insultare chi ormai non può rispondere a tono, versare veleno sui resti di un uomo molto migliore di lui, rappresenta in qualche modo la cifra del tycoon che non riesce ad indossare i panni del Presidente. A fronte della compostezza nel dolore manifestata da milioni di cubani, Trump ha proposto lo sguaiato uso della volgarità che gli è riconosciuta.
Il buon gusto, del resto, non gli appartiene e, di fronte a ciò che non conosce e non capisce, come dinanzi ad una gonna, ha difficoltà a tenere sotto controllo i suoi istinti più bassi, che in lui coincidono con gli istinti in generale.
Dovrebbero esserci dei limiti alla mancanza di rispetto ed alla bassezza umana ma forse Donald Trump non li conosce. Dovrebbe limitarsi nella barbarie verbale, anche solo per il ruolo istituzionale che si esercita, ma anche qui siamo lontani dalla consapevolezza di cosa significhi.
Gli insulti e le cialtronate inviate via Twitter non devono sorprendere. Twitter è lo strumento preferito da Trump proprio per essere utilizzabile con un massimo di 140 caratteri, che corrispondono precisamente all’estensione massima dell’elaborazione culturale del neopresidente americano. Ma oltre a ciò, emerge con preoccupazione l’affidamento per la sua politica verso Cuba alla banda di terroristi e faccendieri legati alla FNCA di Miami.
Costoro hanno concepito e pianificato con ogni Amministrazione - ad eccezione di quella di Obama - la politica statunitense verso l’isola. Politica che, come aveva giustamente sottolineato lo stesso Obama, si è rivelata un fallimento totale, visto che 11 presidenti e 20 direttori della CIA si erano presentati con la caduta di Fidel Castro ai primi punti del loro programmi, per poi uscire di scena con il Lider Maximo al potere e loro nel dimenticatoio. Terrorismo e persino atti di guerra biologica, blocco economico e diplomatico, piani per la sovversione interna, hanno causato circa 3500 vittime e danni per miliardi di dollari allo sviluppo possibile dell’isola, ma non ne hanno mai spostato di una virgola le scelte politiche.
Ma se per l’establishment statunitense l’ostilità ridicola ed anacronistica contro Cuba è stata una delle manifestazioni più evidenti della lsua impotenza, per la Fondazione Nazionale Cubano Americana, fondata dal defunto Jorge Mas Canosa, il blocco economico e il terrorismo contro Cuba sono stati un gran business. Sia per i loschi personaggi che girano intorno alla FNCA, sia per la distrazione di fondi pubblici verso le bande terroristico-mafiose che hanno riempito le tasche a diversi attori della politica terroristica contro l’isola.
Ma non solo di terrorismo si è trattato. Dal traffico di migranti ai fondi statali destinati ai piani di sovversione contro Cuba, la FNCA ha ampliato ricchezze ed influenza senza pari. E aver costituito un bacino elettorale a disposizione di chiunque dimostrasse di voler affamare ed aggredire l’isola, ha rappresentato una azione di lobbyng che ha arricchito enormemente i suoi esponenti mentre ha tenuto gli Stati Uniti con la testa nel secchio, impedendogli di guardare ciò che succedeva a 90 miglia dalle sue coste. Agli USA, l’aggressione contro Cuba è costata figuracce planetarie, miliardi di dollari buttati ed isolamento politico nel consesso internazionale. Benché Trump appaia già come ostaggio della FNCA, la Fondazione non dispone più del livello d’influenza che ebbe sotto Reagan - che la promosse ad interlocutore della Casa Bianca - o durante le diverse amministrazioni della famiglia Bush (compresa la presidenza della Florida di Jeb) e lo stesso Trump dovrebbe sapere che la maggioranza dei voti in Florida sono andati ad Hillary Clinton e non a lui.
Benché Trump appaia già come ostaggio della FNCA, la Fondazione non dispone più del livello d’influenza che ebbe sotto Reagan - che la promosse ad interlocutore della Casa Bianca - o durante le diverse amministrazioni della famiglia Bush (compresa la presidenza della Florida di Jeb) e lo stesso Trump dovrebbe sapere che la maggioranza dei voti in Florida sono andati ad Hillary Clinton e non a lui.
Naturale, visto che le nuove generazioni di cubano-americani, che rappresentano l’emigrazione economica da Cuba, da diverso tempo esprimono sentimenti e volontà politica di dialogo con L’Avana e lo fanno anche scontrandosi duramente contro i vecchi sodali di Batista.
A proporre impensabili invasioni ed ostilità continua sono infatti rimasti solo i residui maleodoranti dell’esercito batistiano riparati a Miami dopo l’abbattimento della dittatura militare nel 1959, meglio noti come gusanos. Sono, costoro, ormai solo un manipolo di vecchi assassini e torturatori che passano il loro tempo a raccontare gesta spesso inventate ai loro amici che vivono giocando a domino nella Calle Ocho di Miami.
I furbetti business man della FNCA, con annessi i parlamentari cubano-americani che li rappresentano, sono solo un residuato bellico, capace sì di avvelenare il clima tra Washington e L’Avana ma non in grado di proporre una politica estera e tanto meno i suoi aspetti collegati. Gli affari legati ai loro traffici criminosi non possono infatti - per volume e decenza - rappresentare una alternativa a quelli legali, che vedono ormai compagnie aeree e di navigazione, aziende turistiche ed immobiliari, società farmaceutiche ed aziende alimentari, progressivamente impegnate negli scambi con Cuba.
Anche solo per essere uomo d’affari, Trump dovrebbe riuscire a comprendere come l’isola rappresenti un bacino d’utenza importante oggi e ancor più in prospettiva per l’economia statunitense. Lui stesso, del resto, poco tempo addietro aveva inviato tre manager del suo gruppo a Cuba per studiare investimenti e, quando gli venne chiesto se fosse interessato a fare affari con l’isola, rispose:“Si, ma solo quando sarà legale farlo”.
Ma, qualora non riuscisse a comprendere commercio e scambi al netto delle truffe, almeno gli si dovrebbe spiegare come dopo oltre cinquant’anni di fallimenti, gli Stati Uniti non hanno nulla da guadagnare nel proseguire a sbattere la testa contro il muro. In questo modo continuerebbero solo a distrarre risorse, arricchire mafiosi e terroristi ed accumulare sconfitte. Cuba, anche dopo Fidel, non è sola nel continente e nel mondo. Ha resistito e vinto in condizioni più difficili di quelle in cui versa oggi, in periodi storici più oscuri e contro amministrazioni più influenti di quella che rappresenterà Trump. Ha cumulato esperienza da vendere in questo ambito.
Cuba, anche dopo Fidel, non è sola nel continente e nel mondo. Ha resistito e vinto in condizioni più difficili di quelle in cui versa oggi, in periodi storici più oscuri e contro amministrazioni più influenti di quella che rappresenterà Trump. Ha cumulato esperienza da vendere in questo ambito.
Non si faccia dunque illusioni il neopresidente circa le ricadute politiche o psicologiche della scomparsa fisica di Fidel Castro. Il sistema cubano è adulto e vaccinato, strutturato e indisponibile a cambi repentini e, soprattutto, inabile alla cessione di dignità e sovranità nazionale.
Se Trump pensa che minacciando Cuba qualcuno sull’isola si spaventi, non ha capito nulla. Se crede che una politica aggressiva porti a qualche risultato è completamente fuori strada. Più facile, se non cambierà atteggiamento, che Cuba lo consegni alla galleria dei fallimenti simili a quelli di altri suoi predecessori, che non a quella della novità che vorrebbe rappresentare.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Da alcune settimane, un nuovo grave scandalo giudiziario sta sconvolgendo la politica della Corea del Sud, con la presidente del paese del nord-est asiatico, Park Geun-hye, sempre più vicina a essere clamorosamente rimossa dal proprio incarico. Il coinvolgimento della presidente in una vicenda legale fatta di estorsioni e pressioni indebite ai massimi livelli dello stato e dell’economia ha scatenato proteste con una partecipazione popolare mai vista nella storia sudcoreana, tanto da convincere il Parlamento ad avviare un procedimento di impeachment e la stessa Park ad accogliere, almeno in parte, gli inviti a fare un passo indietro.
Le accuse - che la presidente continua a respingere - hanno a che fare con una vicenda dai contorni oscuri che ruota attorno alla figura di una sua stretta consigliera, Choi Soon-sil, che non ricopre però cariche ufficiali né nel governo né nell’ufficio di Park Geun-hye. Choi Soon-sil è la figlia del deceduto Choi Tae-min, fondatore di un culto pseudo-cristiano e amico intimo del padre dell’attuale presidente, l’ex dittatore sudcoreano Park Chung-hee, assassinato dal capo dei servizi segreti del suo paese nel 1979.
Choi Tae-min era sospettato di esercitare una profonda influenza su Park Chung-hee, utilizzando il suo rapporto con quest’ultimo per ottenere favori e somme in denaro da personalità pubbliche e uomini d’affari. Questi stessi crimini sarebbero stati commessi anche dalla figlia, Choi Soon-sil, la quale aveva instaurato un rapporto simile con la presidente in carica.
Secondo i magistrati sudcoreani, Park Geun-hye avrebbe favorito il versamento di centinaia di migliaia di dollari a organizzazioni e aziende fondate o vicine a Choi Soon-sil da parte di compagnie come Samsung e Hyundai. Inoltre, l’amica e confidente della presidente avrebbe avuto accesso a documenti governativi riservati senza averne l’autorizzazione e influito su decisioni prese da Park in merito a nomine importanti e all’avvio di dispendiose opere pubbliche.
Insediata alla guida della Corea del Sud nel 2013, la presidente del partito conservatore Saenuri aveva visto crollare rapidamente la sua popolarità nel paese, in primo luogo a causa dell’implementazione di politiche che hanno aggravato il precariato nel mondo del lavoro e peggiorato le condizioni di vita delle classe più disagiate.
Inoltre, Park Geun-hye non è mai stata in grado di stabilire un rapporto di fiducia con i sudcoreani, mostrandosi fin troppo distaccata e lontana dai bisogni della gente comune. Prima dello scandalo in atto, l’immagine della presidente aveva già subito un grave colpo in seguito a un incidente che provocò l’affondamento di un traghetto nell’aprile del 2014 e la morte di oltre 300 persone, tra cui numerosi studenti in gita scolastica.
Sulla presidente sono dunque andate crescendo le pressioni in seguito all’arresto di Choi Soon-sil. I propositi di rimanere al proprio posto, nonostante l’allargamento dell’inchiesta e gli inviti a dimettersi fatti anche da esponenti del suo partito, hanno iniziato a vacillare dopo che, una decina di giorni fa, la procura di Seoul aveva definito Park Geun-hye “complice” della sua consigliera.
La presidente si è scusata in più di un’occasione in diretta televisiva per avere scelto con poco giudizio i propri collaboratori, ma, oltre a essersi rifiutata di dimettersi, ha sempre respinto le richieste degli investigatori di essere interrogata sui fatti. In qualità di presidente, Park Geun-hye gode dell’immunità e potrebbe essere incriminata ufficialmente solo se venisse rimossa con un voto del parlamento o dovesse cedere alle pressioni e farsi da parte in maniera volontaria.
La posizione di Park è sembrata comunque ammorbidirsi nella giornata di martedì, quando in un nuovo intervento pubblico si è detta disposta ad accettare un piano approvato dal parlamento sudcoreano per “abbreviare” il suo mandato, la cui scadenza naturale è prevista per il febbraio 2018. In questo modo, la presidente ha però escluso le dimissioni immediate e, secondo alcuni, starebbe cercando di prendere tempo, forse per evitare un voto sull’impeachment che i partiti di opposizione hanno da tempo messo nell’agenda parlamentare. Proprio la dichiarazione di martedì di Park ha riacceso il dibattito politico a Seoul, con qualche deputato del partito di governo favorevole alla rimozione della presidente che ha mostrato quanto meno di voler rallentare il procedimento.
In questo modo, la presidente ha però escluso le dimissioni immediate e, secondo alcuni, starebbe cercando di prendere tempo, forse per evitare un voto sull’impeachment che i partiti di opposizione hanno da tempo messo nell’agenda parlamentare. Proprio la dichiarazione di martedì di Park ha riacceso il dibattito politico a Seoul, con qualche deputato del partito di governo favorevole alla rimozione della presidente che ha mostrato quanto meno di voler rallentare il procedimento.
I tre principali partiti di opposizione di centro-sinistra, tra cui quello Democratico, hanno invece ribadito la volontà di procedere con l’impeachment dopo un vertice tenuto mercoledì. Il voto in parlamento dovrebbe avere luogo venerdì e alle opposizioni serviranno almeno 28 voti dei deputati del partito Saenuri di governo per vedere approvata la loro mozione contro la presidente.
I media sudocoreani hanno stimato in una quarantina il numero dei parlamentari della maggioranza disposti a votare contro Park, ma l’apertura al compromesso mostrata da quest’ultima martedì potrebbe avere convinto qualcuno a fare marcia indietro, mettendo in dubbio l’esito del voto di venerdì.
Il discorso della presidente ha dato invece animo ai suoi fedelissimi in parlamento, così che il leader della delegazione del partito Saenuri, Chung Jin-suk, ha ipotizzato un accordo con l’opposizione che prevederebbe le dimissioni di Park Geun-hye entro il 30 aprile prossimo. Hwang Young-cheul, portavoce della fazione favorevole all’impeachment nello stesso partito di maggioranza che chiede invece un’uscita di scena più rapida, si è detto a sua volta disponibile a cercare un’intesa sul percorso da seguire. Ma se ciò non dovesse avvenire entro una settimana, il suo gruppo intende unirsi all’opposizione in un eventuale secondo voto per l’impeachment che dovrebbe tenersi il 9 dicembre, ultimo giorno della sessione legislativa in corso.
Se il procedimento di impeachment dovesse essere avviato, la Costituzione della Corea del Sud prevede che i poteri del presidente siano immediatamente sospesi e trasferiti al primo ministro. La decisione finale spetta però alla Corte Costituzionale, la quale ha sei mesi di tempo per deliberare sulla sorte del capo dello stato.
Se almeno sei dei nove giudici che la compongono dovessero ratificare l’impeachment, Park sarebbe formalmente rimossa dal suo incarico e entro 60 giorni dovrebbero tenersi nuove elezioni presidenziali. Se, al contrario, la Corte dovesse ritenerla innocente, riotterrebbe tutti i suoi poteri, come accadde nel 2004 all’allora presidente, Roo Moo-hyun, finora unico capo di stato sudcoreano ad avere subito una procedura di impeachment, prosciolto dall’accusa di avere violato la neutralità richiesta dal suo incarico dopo che aveva lanciato un appello a votare per il suo partito nelle elezioni parlamentari.
Comunque vadano le cose in parlamento nei prossimi giorni, i commentatori sudcoreani sembrano vedere come inevitabili elezioni presidenziali anticipate nei prossimi mesi, possibilmente già ad aprile. Molto dipenderà però dalle decisioni del partito di maggioranza, al cui interno lo scandalo che coinvolge Park ha provocato gravi spaccature, grosso modo tra coloro che ne chiedono le dimissioni per evitare un ulteriore sprofondamento del Saenuri nel gradimento degli elettori e quanti preferirebbero un rinvio della prova con le urne proprio a causa dell’impreparazione del partito.
La stessa opposizione non naviga peraltro in acque migliori, visto che soprattutto il Partito Democratico continua a scontare le politiche impopolari adottate durante i mandati dei presidenti Roh Moo-hyun (2003-2008) e Kim Dae-jung (1998-2003), segnati dalla ristrutturazione in senso liberista dell’economia e da livelli di crescita decisamente modesti.
Mentre i possibili candidati alla successione di Park Geun-hye nel suo partito sono ancora lontani dall’essere individuati, anche se da tempo si parla del segretario generale uscente delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, negli ultimi mesi sono salite le quotazioni del numero uno del Partito Democratico, Moon Jae-in, già sconfitto dall’attuale presidente nelle elezioni del dicembre 2012. La crisi politica in Corea del Sud e l’ondata di manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni di Park Geun-hye sono ad ogni modo motivate non solo dallo scandalo in cui la presidente è coinvolta, ma anche dalle conseguenze su milioni di giovani e lavoratori degli affanni dell’economia e delle misure adottate per farvi fronte. La crescita economica sudcoreana continua a far segnare tassi nettamente inferiori rispetto al periodo pre-crisi e la disoccupazione giovanile è attorno all’8,5%, ovvero altissima per gli standard di questo paese.
La crisi politica in Corea del Sud e l’ondata di manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni di Park Geun-hye sono ad ogni modo motivate non solo dallo scandalo in cui la presidente è coinvolta, ma anche dalle conseguenze su milioni di giovani e lavoratori degli affanni dell’economia e delle misure adottate per farvi fronte. La crescita economica sudcoreana continua a far segnare tassi nettamente inferiori rispetto al periodo pre-crisi e la disoccupazione giovanile è attorno all’8,5%, ovvero altissima per gli standard di questo paese.
Quello che sta accadendo a Seoul rischia infine di intrecciarsi alle questioni geopolitiche della regione asiatica nord-orientale. La perenne crisi attorno al programma nucleare della Corea del Nord, assieme e ancor più alla rivalità tra Cina e Stati Uniti, potrebbero infatti precipitare nei prossimi mesi in concomitanza con l’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump.
Ciò lascerebbe Washington a interrogarsi circa i riflessi sui propri interessi strategici di un alleato costretto a fare i conti con uno stallo politico prolungato e, possibilmente, con un pericoloso vuoto di potere ai vertici stessi dello stato.
