- Dettagli
- Scritto da Administrator
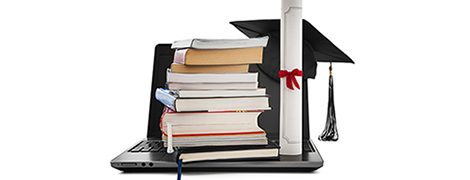 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Vivono tra esperienze di studio all’estero, tirocini formativi e lavori durante i corsi. E dietro, l’ombra della famiglia. Così, secondo il XVI Rapporto sul profilo dei laureati di Almalaurea, si muovono gli studenti universitari italiani del 2013. Con ordine: la probabilità di accesso agli studi universitari è il risultato di un processo causale in cui l’origine sociale ha un ruolo determinante. E cioè, gli studenti di estrazione elevata sono favoriti per quanto riguarda la possibilità di proseguire gli studi oltre l’obbligo scolastico, fino al completamento degli studi universitari.
Di più: il contesto socio-economico di origine ne influenza anche le preferenze disciplinari. Esempio: i laureati provenienti da famiglie più istruite hanno scelto frequentemente le discipline di medicina, giurisprudenza e farmacia. Completamente indipendenti, invece, dalle condizioni socioeconomiche della famiglia sono le motivazioni che spronano all’iscrizione all’università. Fattori culturali e fattori professionalizzanti alla base della scelta del corso di laurea, entrambi determinanti per la metà degli studenti, ma i secondi sono stati decisivi per i laureati in ingegneria, statistica, insegnamento e professioni sanitarie.
Al contesto familiare di provenienza è legata anche l’eventualità di lavorare nel corso degli studi universitari: all’aumentare del titolo di studio dei genitori, infatti, diminuisce la percentuale di laureati che hanno svolto un’attività lavorativa. La quale, negli ultimi anni, complici forse le crescenti difficoltà occupazionali legate alla crisi in atto, è andata sensibilmente contraendosi.
A rimboccarsi le maniche durante gli studi sono soprattutto i maschi; gli studenti delle facoltà di scienze umane e sociali e quelli del centro-nord, e circa la metà dei lavoratori-studenti, ha svolto un’attività coerente con gli studi in corso. Come ovvio, poi, al crescere dell’impegno lavorativo si associa una diminuzione della frequentazione delle lezioni. E lo spettro delle origini socio-familiari si aggira anche sulla partecipazione o meno ai programmi di studio all’estero: il livello di istruzione dei genitori interviene come fattore selettivo nei confronti della probabilità di accesso allo studio all’estero.
Esperienza che è più fattibile per gli studenti degli atenei dell’Italia nord orientale, destinazione Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, mentre quella meridionale e insulare si mantiene un’area in cui le reti di accordo sulla mobilità per studio sono meno diffuse.
 E il grado (elevato) di istruzione dei genitori influenza pure la possibilità di ottenere buoni risultati, insieme al genere (femminile), al diploma secondario liceale, ai buoni voti di diploma e alle forti motivazioni culturali nella scelta del corso di laurea. Fattore, quest’ultimo, che, insieme alla riuscita negli studi scolastici, al gruppo disciplinare e al lavoro durante i corsi universitari, determina la regolarità o meno negli studi.
E il grado (elevato) di istruzione dei genitori influenza pure la possibilità di ottenere buoni risultati, insieme al genere (femminile), al diploma secondario liceale, ai buoni voti di diploma e alle forti motivazioni culturali nella scelta del corso di laurea. Fattore, quest’ultimo, che, insieme alla riuscita negli studi scolastici, al gruppo disciplinare e al lavoro durante i corsi universitari, determina la regolarità o meno negli studi.
Dal 2001 al 2013, i laureati in corso sono più che quadruplicati mentre quelli fuori corso sono diminuiti e il ritardo alla laurea, complice il fatto che l’elaborazione della prova finale nell’università post riforma richiede un impegno di tempo inferiore, si è più che dimezzato. Un netto miglioramento anche se eterogeneo: irregolari gli studenti del gruppo giuridico e molto in regola quelli dell’area medica.
Tirando le somme, tra i laureati del 2013 si rileva una generale soddisfazione per l’esperienza universitaria. Apprezzati il corso di studio e i rapporti con i docenti, contestati l’inadeguatezza delle aule e delle postazioni informatiche. Con la laurea in mano, non tutti i dottori hanno intenzione di mettersi subito alla ricerca di un impiego. Che preferirebbero trovare fra quattro aree: ricerca e sviluppo, organizzazione e pianificazione, risorse umane e selezione, marketing e comunicazione. Magari anche fuori dal Belpaese.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Dal pater familias ai nuovi padri. Quelli degli anni Dieci hanno abbandonato il rapporto padre-figlio basato sull’autorità e sul giudizio, in vigore fino al periodo della Restaurazione, e si sono orientati, dopo l’industrializzazione con la sua buona dose di femminismo, verso una paternità che include anche la sfera affettiva, prima ad appannaggio delle madri.
E’ quanto si legge in uno studio effettuato da Eurispes, che dimostra come oggi la figura materna e quella paterna siano intercambiabili nella cura dei figli. Per cui è del tutto normale che un padre dia da mangiare ai figli, racconti loro le favole, li accompagni alle attività extrascolastiche, li faccia addormentare, li lavi, cambi loro i pannolini e li vesta, li segua nei compiti.
Una concezione moderna di padre anche se alcuni risultati emersi dalle risposte degli intervistati indicano il permanere di una resistenza a riconoscere che i padri sacrifichino la sfera lavorativa per occuparsi della prole. La “rivoluzione paterna” non è ancora approdata a una visione pienamente paritaria: quasi la metà del campione preso in esame si dice abbastanza convinto che ci siano attività legate alla cura dei figli più adatte alle mamme che ai papà.
Va da sé che alla sfera lavorativa e alla carriera professionale delle donne non venga attribuita la stessa rilevanza che viene riservata a quelle degli uomini. A fare questa considerazione sono soprattutto quelli che hanno un basso titolo di studio, i quali faticano ad accogliere alcuni cambiamenti avvenuti nella società contemporanea. In corrispondenza di titoli di studio più elevati, infatti, si nota una sempre maggiore sensibilità rispetto all’importanza di un’equa ripartizione delle mansioni, anche al fine di tutelare la posizione lavorativa della donna. Ma, definizione (grossolana) dei ruoli a parte, dall’insieme delle risposte emerge un quadro che dipinge i “nuovi padri” molto presenti nella vita dei figli, che offrono cure e beni materiali, che li aiutano a risolvere i problemi, lasciando loro poco spazio per affrontarli in prima persona, che ne indirizzano il percorso di vita, intervenendo nelle scelte fondamentali. Sono più protettivi ma anche più invadenti. Un punto di riferimento e una guida. Più aperti al dialogo e alla comprensione che in passato. Più amici che educatori. Più empatici e meno autorevoli. Anche se qualcuno, fra gli intervistati, li vorrebbe più punitivi e più autoritari.
Ma, definizione (grossolana) dei ruoli a parte, dall’insieme delle risposte emerge un quadro che dipinge i “nuovi padri” molto presenti nella vita dei figli, che offrono cure e beni materiali, che li aiutano a risolvere i problemi, lasciando loro poco spazio per affrontarli in prima persona, che ne indirizzano il percorso di vita, intervenendo nelle scelte fondamentali. Sono più protettivi ma anche più invadenti. Un punto di riferimento e una guida. Più aperti al dialogo e alla comprensione che in passato. Più amici che educatori. Più empatici e meno autorevoli. Anche se qualcuno, fra gli intervistati, li vorrebbe più punitivi e più autoritari.
Viene fuori, dunque, un’immagine di padre che non è più legata alla stabilità economica ma si focalizza sull’affettività e sull’interesse, sebbene argomenti intimi e profondi come la sessualità , il rapporto con gli amici e il consumo di sostanze stupefacenti non rientrano fra i temi della loro dialettica. Faticano, insomma, ad avere un confronto aperto con i figli. Nonostante tutto, però, difendono la loro paternità con le unghie e con i denti: preferiscono gestirla in maniera autonoma e sono abbastanza sicuri di questa loro identità. Più ricca, fatta di “tenerezza, empatia e vicinanza fisica”, maggiormente solida perché il rispetto da parte dei figli non viene dal timore della figura genitoriale ma da una forma di “stima”.
Tutto confermato anche per i single e i monogenitori, fuori però dalle dinamiche di gestione di cura e coinvolti, invece, in tanti casi, nelle aule di tribunale dove regna incontrastato lo stereotipo materno e viene mortificato il ruolo di padre, considerato solo un salvadanaio dal quale attingere un sostentamento economico. Invece, loro nella vita quotidiana di rapporto con i figli tirano fuori più “amore” e più “responsabilità” dei padri in coppia. Dostoevskij docet: “Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Rosa Ana De Santis
di Rosa Ana De Santis
La pubblicità progresso, che vede protagonisti anche Niki Vendola e il suo compagno, ha un claim di assoluta efficacia: “Ci vediamo fuori”. "Fuori", come il Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano, l'associazione di Mario Mieli e altri, che negli anni Settanta si batteva per i diritti civili. E fuori anche contro i tanti episodi di pestaggi e discriminazione.
Sabato 7 agosto Roma vedrà sfilare un altro gay pride. Variopinto, eccessivo ed esagerato come sempre stato. L’ultima indagine condotta da Eurispes sul tema dell’omosessualità racconta di una “normalizzazione etica” maturata in Italia sul tema dell’omoessualità. Il tabù di un tempo sembrerebbe esser stato superato: ben l’82% dichiara di non avere o sentire atteggiamenti diversi verso i gay da quelli che avrebbe verso chiunque altro, soltanto poco più di un 15% ha comportamenti di disagio estremo o vera e propria disapprovazione.
Possiamo addurre questo cambio di rotta generale all’outing di personaggi più o meno celebri, anche i vip più amati dai giovani, e non da ultimo ad un’apertura da parte della Chiesa cattolica che tanto costume sociale condiziona nella vita del nostro Paese. Con Papa Francesco infatti si è finalmente iniziato a parlare di un tema prima solo censurato, con rispetto e accoglimento. Un passo in avanti senza precedenti rispetto all’anatema della sodomia di un tempo.
L’indagine documenta anche che le donne hanno maggiore apertura e disinvoltura sulla condizione dell’amore omosessuale rispetto ai maschi e che dal Centro al Sud le percentuali di accettazione dell’unione tra gay scendono dal 55% al 45% circa. Se quindi questo ritratto numerico tratteggia i contorni di un Paese meno spaventato dalla differenza e meno vincolato a certi retaggi di tradizione, dall’altro nessuno può cancellare il ritardo che ci vede indietro a tanti Paesi europei sui diritti civili.
Se quindi questo ritratto numerico tratteggia i contorni di un Paese meno spaventato dalla differenza e meno vincolato a certi retaggi di tradizione, dall’altro nessuno può cancellare il ritardo che ci vede indietro a tanti Paesi europei sui diritti civili.
Non arriviamo a parlare dell’adozione, ma ancor prima del riconoscimento ufficiale, pubblico e giuridico delle coppie gay che convivono e che ad oggi patiscono una pesante discriminazione di fronte alla legge rispetto alle coppie eterosessuali che si sposano.
Chi anche da sinistra pur nel rispetto della carta costituzionale ravvede l’urgenza di aggiornarne forme e modelli di ordine sociale forse adesso ha la strada in discesa. Cosi come sulla cittadinanza e su molte altre sfide legate ai cambiamenti della società contemporanea.
Si darà pace Guido Barilla se dovrà cambiare i suoi spot di maggior successo per raccontare un’altra famiglia italiana. Sabato 7 a piazza della Repubblica dietro ai colori di qualche maschera di troppo troverà tutte le istruzioni.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sono tanti ma invisibili. Sono sempre più diseguali. E crescono. Le persone disabili sono il 16,7 per cento della popolazione totale, cioè quattro milioni. E nel 2020, secondo stime ISTAT e secondo quanto si legge in uno studio del Censis, arriveranno a quarantotto milioni. Quelle con sindrome di Down sono circa quarantottomila, di cui il 21 per cento ha fino a quattordici anni. La fascia d’età più ampia è quella dai quindici ai quarantaquattro anni e il 13 per cento ne ha più di quarantaquattro.
Le persone affette da disturbi di tipo autistico sono circa cinquecentomila, pari all’1 per cento della popolazione. Di quelli che hanno fino a diciannove anni, frequenta la scuola il 93,4 per cento ma il dato cala al 67,1 per cento tra i ragazzi dai quattordici ai venti anni per arrivare al 6,7 per cento tra chi ha più di venti anni. I bambini Down in età prescolare sono l’82 per cento e quelli di età compresa tra i sette e i quattordici anni sono il 97,4 per cento. Dai quindici ai ventiquattro, invece, la percentuale di quelli che frequentano la scuola scende a poco meno della metà, anche se l’11,2 per cento prosegue il percorso formativo professionale.
Dopo la scuola, il nulla. Oltre l’età scolastica, gli adulti Down e autistici scompaiono. Con minime possibilità di inserimento sociale e di integrazione in termini di pari opportunità. Nel mondo del lavoro, infatti, l’inclusione è pressoché inesistente: solo il 31,4 per cento delle persone Down over 24 svolge un’attività e la maggioranza di quelli che lavorano non è inquadrata con contratti di lavoro standard.
Per lo più sono occupati in mansioni all’interno di cooperative sociali, spesso senza un vero e proprio contratto. Talvolta, nel 70 per cento dei casi, senza nessuno stipendio. E fra gli adulti autistici, a lavorare è il 10 per cento degli over 20. Rimangono a casa. In famiglia, che è l’unica risposta alla disabilità e che si fa carico in toto della responsabilità, con sostegni istituzionali limitati, e ridotti al solo supporto economico.
Ristrettissimo: pari a quattrocentotrentasette euro pro capite l’anno, inferiore alla media europea (cinquecentotrentacinque euro). Ridotta è pure l’opportunità di accesso ai servizi: fra gli over 25 affetti da sindrome di Down, solo il 32,9 per cento frequenta un centro diurno e il 50 per cento fra i soggetti autistici. I restanti? Non fanno niente, inseriti in quel contesto di isolamento in cui si trovano anche le loro famiglie, che diventano il soggetto centrale della cura e che dedicano complessivamente diciassette ore al giorno per la gestione assistenziale dei loro ragazzi disabili. Una marginalità che, nel tempo, aumenta insieme al senso di abbandono e alla quota di quelle che non possono contare sul sostegno di nessuno quando pensano alla prospettiva vita futura dei loro figli. Una condizione, quella dei disabili, che la maggior parte dell’opinione pubblica scotomizza: un italiano su quattro, infatti, afferma che non gli è mai capitato di avere a che fare con un disabile e due italiani su tre intendono la disabilità come limitazione dei movimenti ignorando che quella intellettiva è ben più diffusa, più misconosciuta e più rimossa.
Una marginalità che, nel tempo, aumenta insieme al senso di abbandono e alla quota di quelle che non possono contare sul sostegno di nessuno quando pensano alla prospettiva vita futura dei loro figli. Una condizione, quella dei disabili, che la maggior parte dell’opinione pubblica scotomizza: un italiano su quattro, infatti, afferma che non gli è mai capitato di avere a che fare con un disabile e due italiani su tre intendono la disabilità come limitazione dei movimenti ignorando che quella intellettiva è ben più diffusa, più misconosciuta e più rimossa.
E pensare che proprio lì dove risiede l’unica risposta istituzionale alla disabilità, cioè l’inclusione scolastica - che, pur con tutti i suoi limiti e lacune, rappresenta la sola occasione di integrazione sociale - arrivano i tagli dello Stato e dei Comuni. In cinque anni, al Sud, dove sarebbe più necessario investire, è arrivata una sforbiciata pari al 13 per cento e tutta ai danni degli alunni disabili, scuolabus e mense.
Vittime dei tagli anche gli insegnanti di sostegno che, solo nell’ultimo biennio, nel Sud e nelle isole sono stati ridotti di oltre quattromila, di cui più di duemila in Sicilia e novecento in Campania. Per colmo, delle ventiduemila assunzioni programmate per l’anno prossimo, quasi diciottomila si effettueranno al Nord.
Le regioni più penalizzate saranno Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. I docenti precari continueranno a cambiare scuola, non garantendo quella continuità didattica e di rapporto, fondamentali per l’apprendimento da parte dei bambini disabili. I quali nelle scuole statali sono aumentati del 3,7 per cento, diventando più di duecentonovemila. Anche questo ce lo chiede l’Europa?
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Silvia Mari
di Silvia Mari
“Freddo non gli prende perché ha due carabinieri sopra”. E’ la notte in cui Magherini muore a Borgo San Frediano. “Ragazzo immobilizzato dai carabinieri. Trenta anni. Stanno rianimando. Per ora metti droga, poi vediamo”. Questa la sequenza delle telefonate del soccorso medico e i carabinieri, tra tutte quelle dei cittadini del posto che svegliati dalle urla di Riccardo chiamano le forze dell’ordine per segnalare che qualcosa di grave sta accadendo sotto le loro finestre.
I fatti di quella notte, 3 marzo scorso, sono affidati alla ricostruzione degli amici di Riccardo che lo vedono per ultimi, del taxi, dell’amico del bar che lo accoglie spaventato, quasi terrorizzato ma inoffensivo fino all’arrivo dei carabinieri che lo immobilizzano brutalmente e che dichiarano che il ragazzo è ubriaco, nudo e spacca macchine.
Ma il video amatoriale rubato da un testimone alla finestra con il telefonino che ha già fatto il giro del web non mostra un uomo pericoloso e minaccioso, non documenta alcun atto vandalico, ma un ragazzo accerchiato da tanti uomini, che lo comprimono a terra, gli danno un bel calcio per farlo tacere con qualche sarcastica battutina d’accompagnamento, mentre il giovane Riccardo non fa che gridare “aiuto” e dire che “sta morendo”. Queste le sue ultime parole.
L’autopsia ha certificato che la morte di Magherini, ex calciatore del Prato di 40 anni, in realtà è sopraggiunta dopo lunga e dolorosa agonia. La causa principale della consulenza medica viene addebitata ad uno stupefacente assunto da Riccardo, ma c’è una parte residuale (su cui si farà battaglia) dovuta a complicanze asfittiche e cardiologiche. Per ora si escludono traumi di tipo lesivo dovuti a percosse, ma ancora una volta le foto del corpo dopo il decesso mostrano segni e lividi che vanno ben oltre la morte per soffocamento.
Non è difficile ipotizzare che il balletto di telefonate con i soccorsi e l’accerchiamento brutale e la compressione sul corpo di Riccardo non abbiano aiutato il giovane a superare la crisi, ma lo abbiano definitivamente condannato a morte. Sono quattro i carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale, cinque operatori e due centralinisti del 118 per omicidio colposo. Viene in mente, per analogia di cronaca, il caso del diciottenne Aldovrandi.
La famiglia chiede di far luce sulle responsabilità. Non è chiaro e non è legalmente tollerabile che un uomo che grida, fosse pure in preda ad una crisi per droga, che non ha colpito o danneggiato niente e nessuno, invece di essere tempestivamente soccorso, sia accerchiato, sbattuto a terra anzi schiacciato quando già gridava di soffocare, preso a calci, come sentono i cittadini in quella notte, anche con un sarcasmo orribile da branco e con tanta sottovalutazione da parte degli uomini del soccorso, che arrivano per “sedare” un uomo che è a faccia in giù sull’asfalto, ammanettato e senza respiro. Un controsenso, un’errata valutazione delle sue condizioni fisiche, un’overdose di violenza di gruppo su un uomo terrorizzato, visibilmente fuori di sé e in preda al panico, ma non aggressivo come tutti coloro che incontrano e sentono Riccardo quella notte sono pronti a testimoniare. Ancora una volta c’è, aldilà degli esiti giudiziari anche facili da immaginare, una sproporzione evidente tra l’azione delle forze dell’ordine - in questo caso carabinieri - e la persona per la quale sono chiamati ad intervenire. Nel caso di Riccardo un uomo destabilizzato da qualche stupefacente che teme di essere accusato di rapina per non aver pagato il taxi, che scappa e chiama aiuto, che non “spacca macchine”, che non aggredisce alcuno. Nel caso di Aldovrandi un ragazzetto che tornava a casa, pestato a morire e soffocato, per cui tutte le istituzioni sono scese in campo a processo concluso e dopo l’orrore degli applausi agli agenti assassini.
Ancora una volta c’è, aldilà degli esiti giudiziari anche facili da immaginare, una sproporzione evidente tra l’azione delle forze dell’ordine - in questo caso carabinieri - e la persona per la quale sono chiamati ad intervenire. Nel caso di Riccardo un uomo destabilizzato da qualche stupefacente che teme di essere accusato di rapina per non aver pagato il taxi, che scappa e chiama aiuto, che non “spacca macchine”, che non aggredisce alcuno. Nel caso di Aldovrandi un ragazzetto che tornava a casa, pestato a morire e soffocato, per cui tutte le istituzioni sono scese in campo a processo concluso e dopo l’orrore degli applausi agli agenti assassini.
E ancora Stefano Cucchi, anche lui tumefatto di calci e lasciato morire dentro un ospedale dello Stato. La giustizia che come al solito salva gli uomini in divisa a priori e nonostante i fatti, quelli che proprio per onore di ciò che rappresentano – giustizia, legalità e sicurezza - dovrebbero pagare più degli altri quando ledono la legge e i diritti umani fondamentali, lasciano soprattutto un altro interrogativo sui corpi di queste vittime.
Non si sa se sia stato per incompetenza, impreparazione o per un’odiosa esaltazione accompagnata da rivalsa ideologica contro chi ha il peccato di essere più fragile, magari di essere o esser stato un tossicodipendente, di chi vive nella marginalità o nel disagio. Un debole contro cui è facile e barbaro essere forti e scatenare campagne di odio sociale. Lo stesso che vediamo quando vengono affrontati i cortei degli studenti.
Mentre indisturbati i delinquenti, drappelli di barbari a piede libero, riempiono gli stadi ogni domenica con la scusa del tifo calcistico e assediano città per ore e ore, lasciando i cittadini perbene in balia e in ostaggio degli incappucciati delle tifoserie. Qui non c’è uso sproporzionato della forza, qui tutto avviene al cospetto di divise imbarazzate, prudenti e obbedienti ad ordini che, evidentemente, considerano la vita di un delinquente allo stadio di maggior valore di quella di un uomo isolato e spaventato che grida di essere aiutato.
