- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La vigilia dell’ennesimo vertice dei cosiddetti “Amici della Siria”, al via da giovedì a Londra, è stata segnata da una serie di eventi legati al paese mediorientale in guerra da oltre tre anni che hanno confermato sia il crescente fallimento dell’opposizione armata anti-Assad sia la volontà dei governi occidentali di continuare ad alimentare il conflitto in corso, ricorrendo ancora una volta, se necessario, a menzogne e manipolazioni della realtà.
L’ammissione della totale incapacità da parte della comunità internazionale anche solo di gettare le basi per un negoziato efficace sulla crisi è avvenuta martedì con le dimissioni dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Lakhdar Brahimi.
Il diplomatico algerino ha annunciato la propria decisione ai membri del Consiglio di Sicurezza nel corso di una riunione a porte chiuse, durante la quale avrebbe espresso delusione per la mancanza di impegno da parte dei sostenitori di entrambi gli schieramenti nel fermare l’afflusso di armi in Siria e di alleviare la crisi umanitaria.
La sorte di Brahimi era risultata evidente già nel mese di marzo, quando i colloqui di Ginevra tra il regime e l’opposizione “moderata” erano finiti nel nulla dopo due round di negoziati. Per il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon, l’impossibilità di percorrere la strada diplomatica sarebbe dovuta all’intransigenza mostrata al tavolo delle trattative da Assad e dai suoi uomini.
Lo stesso Brahimi, nonostante abbia puntato il dito contro tutte le parti in causa per la drammatica evoluzione della crisi in Siria, ha più volte lasciato intendere che il fallimento dei negoziati di Ginevra è la diretta conseguenza della decisione del regime di Damasco di organizzare le elezioni presidenziali per il 3 giugno prossimo nelle quali Assad sarà regolarmente tra i candidati.
Le affermazioni di Ban e Brahimi la dicono lunga sulla presunta imparzialità delle Nazioni Unite in relazione alla Siria, visto che le ragioni principali del naufragio di qualsiasi ipotesi diplomatica sono da ricercare piuttosto nell’inflessibilità mostrata a Ginevra dai rappresentanti dell’opposizione anti-Assad.
I “ribelli”, cioè, hanno sempre posto come condizione imprescindibile per l’accettazione di un eventuale piano di transizione l’esclusione del presidente siriano e degli uomini ritenuti più compromessi del suo regime, negando così una realtà militare sempre più favorevole a Damasco e sorvolando sull’avversione nutrita dalla maggior parte della popolazione nei confronti di un’opposizione composta in larga misura da forze fondamentaliste violente. Proprio mentre Brahimi rassegnava le proprie dimissioni, la visita a Washington del leader politico dell’opposizione siriana, Ahmad Jarba, raggiungeva il proprio culmine con un incontro alla Casa Bianca. Il burattino saudita aveva trascorso i giorni precedenti parlando a media e think tank americani, nel tentativo di raccogliere consensi per la richiesta da sottoporre all’amministrazione Obama di fornire ai ribelli nuove armi, in particolare missili terra-aria per abbattere gli aerei del regime.
Proprio mentre Brahimi rassegnava le proprie dimissioni, la visita a Washington del leader politico dell’opposizione siriana, Ahmad Jarba, raggiungeva il proprio culmine con un incontro alla Casa Bianca. Il burattino saudita aveva trascorso i giorni precedenti parlando a media e think tank americani, nel tentativo di raccogliere consensi per la richiesta da sottoporre all’amministrazione Obama di fornire ai ribelli nuove armi, in particolare missili terra-aria per abbattere gli aerei del regime.
Jarba, dopo avere incassato da Washington il riconoscimento dello status di “missione diplomatica” per l’organizzazione che dirige, aveva anche confermato che gli USA hanno recentemente fornito missili anti-carro al Libero Esercito della Siria, per poi sottolineare la competenza e la responsabilità che i militanti anti-Assad avrebbero mostrato con queste armi.
Il presidente Obama, così come gli uomini all’interno dell’amministrazione democratica che condividono la sua posizione relativamente cauta sulla Siria, continua però a dubitare dell’opportunià di fornire i cosiddetti “manpads” ai ribelli, visto che con ogni probabilità queste armi finirebbero nelle mani di formazioni estremiste che le potrebbero utilizzare contro velivoli commerciali.
Questa possibilità è stata confermata da un articolo uscito la settimana scorsa sul Wall Street Journal, nel quale alcune fonti all’interno del Libero Esercito della Siria hanno rivelato come le fazioni anti-Assad ritenute “moderate” dall’Occidente stiano collaborando da qualche settimana con il Fronte al-Nusra, vale a dire l’unica organizzazione riconosciuta ufficialmente da Al-Qaeda tra quelle attive in Siria.
In particolare, il Libero Esercito e il Fronte al-Nusra sono partner sui campi di battaglia nel sud-ovest della Siria, non lontano dalle alture del Golan occupate da Israle, dove tra l’altro gli Stati Uniti operano da tempo tramite la CIA un programma di addestramento per i ribelli.
Se le rassicurazioni di Jarba sono dunque crollate miseramente già prima di essere esposte al presidente Obama, le manovre per mantenere la Siria nel caos da parte dell’Occidente, in alternativa al sogno per ora irrealizzabile di provocare la caduta di Assad, stanno passando anche da altre strade, sia pure non esattamente nuove.
Con una dose difficilmente misurabile di ipocrisia e cinismo, ad esempio, il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, sempre nella giornata di martedì, ha espresso il proprio rammarico per la mancata decisione da parte di Obama di bombardare la Siria dopo le accuse mosse contro Assad l’agosto scorso per avere usato armi chimiche contro i ribelli.
Secondo Fabius, se il governo USA in quell’occasione avesse dato seguito alle proprie minacce autorizzando attacchi aerei contro il regime, “molte cose sarebbero cambiate”. In effetti, se Washington avesse inaugurato una nuova guerra criminale basata sulla menzogna in Medio Oriente, la Siria sarebbe oggi, quanto meno, già nelle mani di bande fondamentaliste sull’esempio della Libia “liberata” dalla NATO.
La criminalità della tesi di Fabius è amplificata dal fatto che le sue dichiarazioni rilasciate a Washington giungono dopo quasi nove mesi dagli attacchi in questione, avvenuti a Ghouta, nei pressi di Damasco, durante i quali sono emersi numerosi dettagli e rivelazioni - anche se quasi mai riportati dai media ufficiali - che hanno dimostrato come l’uso di armi chimiche fosse da attribuire quasi certamente proprio alle formazioni ribelli, interessate a provocare la reazione della comunità internazionale contro un regime che già allora stava mettendo a segno importanti successi militari sul campo.
Il giornalista investigativo americano Seymour Hersh, soprattutto, nei mesi scorsi ha pubblicato due indagini molto approfondite per smontare la tesi americana della responsabilità di Assad, rivelando tra l’altro come gli USA sapevano perfettamente delle capacità dei ribelli di produrre e utilizzare il Sarin a scopi bellici e come dietro all’attacco di Ghouta ci fosse addirittura il governo turco, disperatamente intenzionato a provocare un intervento internazionale per rimuovere il regime di Damasco. Ciononostante, Fabius è tornato nuovamente ad accusare Assad di avere condotto 14 attacchi con armi chimiche a partire dallo scorso ottobre, sostanzialmente da quando ha accettato l’accordo USA-Russia per la distruzione del proprio arsenale. Il ministro francese ha citato “testimoni credibili”, verosimilmente pescati tra le fila dei ribelli e, perciò, nessuno di essi nella posizione di fornire prove irrefutabili che, infatti, non sono state presentate.
Ciononostante, Fabius è tornato nuovamente ad accusare Assad di avere condotto 14 attacchi con armi chimiche a partire dallo scorso ottobre, sostanzialmente da quando ha accettato l’accordo USA-Russia per la distruzione del proprio arsenale. Il ministro francese ha citato “testimoni credibili”, verosimilmente pescati tra le fila dei ribelli e, perciò, nessuno di essi nella posizione di fornire prove irrefutabili che, infatti, non sono state presentate.
Le accuse infondate di Fabius potrebbero servire in ogni caso da pretesto agli “Amici della Siria” riuniti a Londra per aumentare il loro impegno a favore dei ribelli, così come allo scopo tornerà utile un rapporto diffuso ancora martedì da Human Rights Watch sull’uso di armi chimiche.
L’organizzazione americana, teoricamente indipendente, sostiene che nel mese di Aprile le forze del regime avevano lanciato bombe al cloro su tre città nel nord della Siria. Pur affermando che quelle reperite su questi attacchi sarebbero “prove”, Human Rights Watch ha dovuto ammettere che “non è stato possibile confermarle in maniera indipendente”. Anche in questo caso, appare evidente, le presunte “prove” devono essere state fornite esclusivamente dalle forze anti-governative.
L’allineamento di Human Rights Watch alle posizioni del Dipartimento di Stato americano appare peraltro ben poco sorprendente, visti i legami di molti suoi uomini di spicco con il governo USA, a cominciare da Tom Malinovski, recentemente dimessosi da responsabile delle relazioni dell’organizzazione per i diritti umani a Washington per diventare assistente al segretario di Stato per “la democrazia, i diritti umani e il lavoro”.
Il problema di credibilità di Human Rights Watch è stato in questi giorni sollevato anche da un gruppo di autorevoli accademici, tra cui il premio Nobel per la Pace argentino Adolfo Pérez Esquivel, i quali hanno indirizzato una lettera al direttore esecutivo Kenneth Roth per denunciare i rapporti della sua organizzazione con il governo di Washington che ne mettono in dubbio l’indipendenza.
Oltre a Malinovski, che ricoprì vari incarichi già durante l’amministrazione Clinton, la lettera evidenzia la presenza nel comitato consultivo di Human Rights Watch di personaggi come ad esempio Myles Frechette, ex ambasciatore USA in Colombia, Miguel Diaz, ex analista della CIA, e Michael Shifter, già direttore per l’America Latina del “National Endowment for Democracy”, uno degli strumenti utilizzati da Washington per la destabilizzazione di governi stranieri poco graditi.
Tra gli altri possibili sviluppi della crisi siriana vanno infine segnalate le bozze di due risoluzioni ONU proposte da Russia e Francia. Mentre la prima intende estendere ad altre località del paese in guerra il recente accordo di cessate il fuoco negoziato a Homs tra il regime e l’opposizione armata, la seconda è un altro capolavoro di ipocrisia occidentale.
Con essa, Parigi vorrebbe deferire il caso della guerra in Siria al Tribunale Penale Internazionale ma la sua vera natura è illustrata dalle manovre francesi per definirne il testo. La risoluzione, infatti, è stata studiata per limitare le indagini sui crimini commessi in Siria a dopo il 2011, così da escludere quelli commessi in precedenza da Israele nelle alture del Golan, e per dispensare da eventuali incriminazioni i cittadini dei paesi non firmatari dello Statuto di Roma - che ha istituito appunto il Tribunale - ad eccezione della Siria.
Quest’ultima disposizione serve appositamente a escludere qualsiasi denuncia ai danni di membri del governo e delle forze armate degli Stati Uniti, nel caso in cui il paese più importante che non ha mai ratificato lo Statuto di Roma decidesse di invadere la Siria per forzare il cambio di regime.
Se la risoluzione francese dovesse finire ai voti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la Russia ha comunque già annunciato di volere esercitare il proprio diritto di veto.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Da oltre una settimana, la Cina e il Vietnam sono nel pieno di un’accesa disputa attorno al posizionamento di una piattaforma petrolifera nel Mar Cinese Meridionale da parte di Pechino. Il nuovo scontro non solo retorico in Asia orientale rientra nel quadro delle contese territoriali riaccese dal riposizionamento degli Stati Uniti in questa parte del globo e che stanno pericolosamente mettendo di fronte Pechino a svariati paesi vicini, la cui crescente aggressività continua ad essere incoraggiata proprio dalle necessità strategiche di Washington.
A inizio mese le autorità cinesi avevano installato la piattaforma in un’area vicina alle isole Paracel (Xisha in cinese), controllate da Pechino ma rivendicate dal Vietnam. L’azione aveva subito provocato la replica di Hanoi, il cui governo nei giorni scorsi ha inviato nella zona alcune imbarcazioni della propria Guardia Costiera, accolte però da navi cinesi con cannoni ad acqua.
Nella giornata di lunedì, il governo vietnamita ha nuovamente accusato la Cina di avere respinto con gli stessi metodi una motovedetta che, a sua volta, secondo i media locali avrebbe risposto anch’essa con l’uso di cannoni ad acqua.
Secondo Hanoi, le attività di trivellazione avviate dalla Cina sono illegali, poiché la piattaforma in questione si troverebbe nella cosiddetta “zona economica esclusiva” del Vietnam, fissata dalle norme internazionali a 200 miglia al largo delle coste di un determinato paese.
Pechino, al contrario, respinge categoricamente una simile interpretazione e sostiene che la Cina ha l’assoluta sovranità sulla zona in cui si trova la piattaforma, essendo ad appena una trentina di chilometri al largo delle isole Paracel che essa controlla fin dal 1974.
Pechino ha poi denunciato la marina vietnamita per avere inviato nell’area di crisi 35 imbarcazioni che hanno speronato navi cinesi in almeno 171 occasioni tra il 3 e il 7 di maggio. Nel corso degli ultimi dieci anni, inoltre, la Cina ha già condotto attività esplorative nei pressi delle isole contese e il recente posizionamento della piattaforma petrolifera sarebbe un’operazione non differente dalle precedenti. Il Vietnam, in ogni caso, non ha lesinato iniziative che hanno fatto aumentare le tensioni. Per cominciare, nel fine settimana il regime ha autorizzato alcune dimostrazioni di fronte alle sedi diplomatiche cinesi per denunciare la presunta aggressione di Pechino. Già nel 2011, Hanoi permise proteste simili in occasione di un altro scontro tra i due paesi vicini, per poi disperderle senza troppi complimenti quando stavano per trasformarsi in una rara occasione per esprimere il malcontento popolare nei confronti del governo.
Il Vietnam, in ogni caso, non ha lesinato iniziative che hanno fatto aumentare le tensioni. Per cominciare, nel fine settimana il regime ha autorizzato alcune dimostrazioni di fronte alle sedi diplomatiche cinesi per denunciare la presunta aggressione di Pechino. Già nel 2011, Hanoi permise proteste simili in occasione di un altro scontro tra i due paesi vicini, per poi disperderle senza troppi complimenti quando stavano per trasformarsi in una rara occasione per esprimere il malcontento popolare nei confronti del governo.
Il primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, ha poi avuto parole molto dure per la Cina, accusata di essersi macchiata di “serie e pericolose violazioni” nell’ambito delle dispute, mettendo a rischio “la pace, la stabilità e la sicurezza” nella regione.
Il messaggio di Dung è stato indirizzato in particolare ai dieci membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti nella giornata di domenica in Myanmar. Qui, il premier del Vietnam ha cercato di raccogliere il supporto di qualche governo - alcuni dei quali coinvolti anch’essi in contese territoriali con Pechino - ma senza troppo successo.
I leader del gruppo non hanno infatti menzionato esplicitamente la Cina nel loro comunicato ufficiale al termine del vertice, limitandosi ad esprimere “gravi preoccupazioni in merito agli sviluppi in corso nel Mar Cinese Meridionale”.
L’ASEAN, d’altra parte, continua a trattare con estrema cautela le dispute riesplose in questi anni, principalmente perché la Cina è il principale partner commerciale di praticamente tutti i paesi membri, nonché stretto alleato di alcuni di essi (Cambogia e Laos). Altri invece, come le Filippine, auspicherebbero una risposta più forte alle “provocazioni” cinesi, in linea con i tentativi favoriti da Washington di aprire un negoziato multilaterale per la risoluzione delle contese territoriali.
Nonostante la posizione neutrale ufficialmente sostenuta dall’amministrazione Obama, gli USA hanno più volte segnalato la loro intenzione di appoggiare tutti i rivali di Pechino nelle varie dispute. Ciò è stato confermato anche in questa occasione, visto che in una telefonata avvenuta lunedì, il segretario di Stato John Kerry ha comunicato alla sua controparte cinese che il posizionamento della piattaforma petrolifera in acque contese con il Vietnam è stata una mossa “provocatoria”, ribadendo poi che lo scontro dovrebbe essere risolto “con mezzi pacifici e in accordo con il diritto internazionale”.
Il ministero degli Esteri di Pechino ha replicato che nel Mar Cinese Meridionale ci sono state indubbiamente delle operazioni provocatorie ma non da parte cinese, per poi puntare il dito contro gli Stati Uniti per avere nuovamente incitato comportamenti di questo genere.
Dal momento che il governo cinese non poteva non aspettarsi una qualche reazione da parte del Vietnam e degli stessi USA, è probabile che la decisione di collocare una piattaforma petrolifera in uno dei punti caldi nel Mar Cinese Meridionale sia stata una risposta studiata alla recente trasferta asiatica del presidente Obama.
L’inquilino della Casa Bianca, pur cercando di smorzare i toni della rivalità con Pechino, aveva di fatto appoggiato tutte le rivendicazioni territoriali dei paesi visitati (Giappone, Filippine), promettendo a Tokyo di intervenire anche militarmente in caso di “aggressione” cinese nelle isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale e siglando a Manila un trattato che garantisce la presenza nell’arcipelago di un contingente militare americano per almeno dieci anni.
Quest’ultimo accordo e altre iniziative statunitensi in Asia Orientale in concerto con i propri alleati possono avere anche spinto la Cina a mettere in atto una manovra - come quella in corso al largo delle isole Paracel - volta a spezzare l’accerchiamento e a ribadire agli occhi della comunità internazionale la volontà di non rendere conto a nessuno in merito alle decisioni su territori considerati sotto la propria sovranità, sia pure rivendicati da altri paesi.
La fermezza della risposta di Hanoi potrebbe però avere relativamente sorpreso le autorità cinesi, visto che i due paesi negli ultimi anni avevano fatto passi importanti sulla via della risoluzione delle dispute territoriali. Nel 2011 e ancora nel 2013, ad esempio, Cina e Vietnam avevano sottoscritto bozze di accordo per avviare colloqui distensivi ed evitare pericolosi scontri.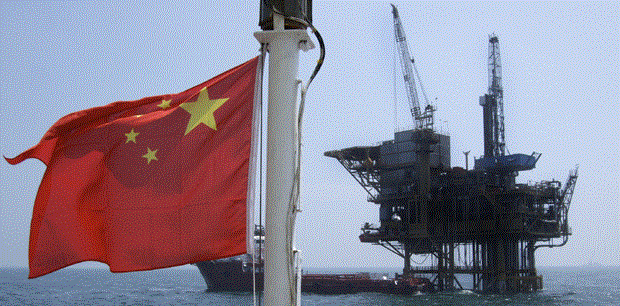 Più in generale, i due vicini avevano visto migliorare i rapporti bilaterali, come aveva confermato un’intesa sulla fissazione dei confini e dei diritti marittimi nel Golfo del Tonchino, ma anche la decisione di studiare modalità per sfruttare congiuntamente le risorse energetiche della regione in seguito alla visita in Vietnam a fine 2013 del premier cinese, Li Keqiang.
Più in generale, i due vicini avevano visto migliorare i rapporti bilaterali, come aveva confermato un’intesa sulla fissazione dei confini e dei diritti marittimi nel Golfo del Tonchino, ma anche la decisione di studiare modalità per sfruttare congiuntamente le risorse energetiche della regione in seguito alla visita in Vietnam a fine 2013 del premier cinese, Li Keqiang.
Il confronto in corso con Hanoi assume comunque contorni ancora più allarmanti non solo perché è stato sfruttato nuovamente dagli Stati Uniti per esercitare pressioni su Pechino, ma anche perché si aggiunge ad un nuovo motivo di scontro con le Filippine. Sempre settimana scorsa, infatti, le autorità del paese-arcipelago avevano fermato un peschereccio cinese e arrestato il suo equipaggio nelle isole Spratly, rivendicate dalla Cina e dalle Filippine oltre che da Brunei, Malaysia, Taiwan e Vietnam.
L’imbarcazione cinese è stata sequestrata con la scusa che l’equipaggio aveva a bordo un certo numero di tartarughe protette, anche se a molti l’operazione del governo del presidente filippino Benigno Aquino è apparsa come l’ennesima provocazione di Manila nei confronti di Pechino, possibilmente orchestrata durante la recente visita di Obama.
Il differente approccio alle dispute territoriali in Estremo Oriente dei media occidentali, degli Stati Uniti e dei paesi alleati di questi ultimi risulta in ogni caso evidente dal fatto che azioni simili a quella intrapresa settimana scorsa dalla Cina nelle isole Paracel da parte di Giappone, Filippine o Vietnam passano puntualmente sotto silenzio e, come è ovvio, non vengono condannate se non da Pechino.
Così, infatti, nel 2012 il governo di Tokyo aveva “nazionalizzato” le isole Senkaku, rivendicate dalla Cina, dopo averle acquistate dai privati che ne detenevano la proprietà. Solo nel fine settimana scorso, poi, le Filippine hanno annunciato un’asta per la concessione di diritti per la trivellazione di una decina di pozzi petroliferi, tra cui uno situato in un’area del Mar Cinese Meridionale rivendicata da Pechino.
Ugualmente contese da Pechino sono infine le acque nelle quali proprio il Vietnam ai primi di maggio ha offerto alla compagnia petrolifera indiana ONGC Videsh (OVL) altre due aree da trivellare, in aggiunta alle cinque già proposte lo scorso mese di novembre.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il nuovo fronte della campagna selettiva dell’Occidente per la difesa dei diritti umani nei paesi del Terzo Mondo è diventato da qualche giorno la Nigeria, balzata sulle prime pagine dei giornali internazionali in seguito all’ormai noto rapimento di oltre duecento giovani studentesse da parte della formazione fondamentalista Boko Haram.
La risposta iniziale del governo nigeriano al rapimento, avvenuto il 14 aprile scorso in una scuola di Chibok, nel nord del più popoloso paese africano, era stata in realtà molto blanda, riflettendo lo scarso interesse delle autorità centrali per le impoverite regioni settentrionali a maggioranza musulmana, da tempo abituate a convivere con le atrocità dei guerriglieri islamisti e delle forze di sicurezza.
Gli stessi comandanti militari indigeni non avevano alzato un dito per difendere gli abitanti del villaggio in questione dai militanti islamici, nonostante fossero stati avvertiti con svariate ore di anticipo circa l’arrivo di questi ultimi.
Il rapimento, però, è sembrato avere da subito le caratteristiche necessarie per trasformarsi in un’occasione d’oro per la propaganda dei governi occidentali, i quali non hanno perso tempo ad orchestrare l’ennesima campagna “umanitaria” in un paese di grande importanza strategica in una regione del continente africano segnata dalla crescente competizione internazionale.
In ogni caso, gli ultimi sviluppi della vicenda includono la pubblicazione lunedì di un video da parte dell’agenzia di stampa AFP, nel quale il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, sostiene di essere disposto a liberare le giovani rapite in cambio della scarcerazione di prigionieri appartenenti alla sua organizzazione. In precedenza, Shekau aveva invece minacciato di volere vendere come schiave le oltre 200 ragazze rapite.
Dietro le pressioni internazionali, il presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, ha finito per allinearsi alla campagna contro Boko Haram, promettendo di mobilitare le forze dello stato per individuare i reponsabili del rapimento. Lo stesso governo della Nigeria ha fatto sapere nei giorni scorsi di avere già inviato due divisioni dell’esercito nel nord del paese.
Annusando la possibilità di avere una presenza militare sul territorio della prima economia africana, paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia non hanno esitato a inviare vari contingenti di “consiglieri” ed “esperti” di anti-terrorismo nel paese. Più recentemente, anche Israele ha offerto l’assistenza dei propri “esperti”, accettati formalmente da Jonathan nella giornata di domenica.
Il presidente francese Hollande, da parte sua, ha annunciato che sabato prossimo si terrà a Parigi un summit speciale per discutere del rapimento e delle misure da mettere in atto per contrastare il dilagare di Boko Haram in Nigeria. Al vertice dovrebbero prendere parte, oltre ai padroni di casa e al governo nigeriano, i leader di paesi vicini come Benin, Camerun, Ciad e Niger, così come - ovviamente - Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea.
L’accordo per l’invio di personale americano in Nigeria era stato raggiunto già la settimana scorsa tra Obama e Jonathan ed è stato da allora propagandato dai principali media e da personalità politiche occidentali di spicco, tutti uniti nel promuovere l’ennesimo intervento “umanitario”, ufficialmente motivato soltanto dagli scrupoli per la sorte delle ragazze rapite e dalla più che giustificata angoscia delle loro famiglie.
I falchi dell’intervento “umanitario” si sono messi dunque in moto, come il senatore repubblicano John McCain, già protagonista di varie apparizioni nei mesi scorsi a fianco degli “eroi” neo-fascisti del golpe anti-Yanukovich in Ucraina. L’ex candidato alla Casa Bianca ha già assicurato che il governo nigeriano non dispone delle capacità per liberare le studentesse rapite e, di conseguenza, ciò che serve è l’invio di personale USA, la cui generosità dovrebbe essere manifestata con l’impiego di soldati e velivoli senza pilota (droni). Il presunto disinteresse di Washington - così come di Londra o Parigi - nel soccorrere il governo nigeriano potrebbe essere però messo in dubbio anche solo da alcuni dati fondamentali relativi al paese dell’Africa occidentale. La Nigeria, come già ricordato, è infatti il primo paese africano per popolazione e dimensioni dell’economia, oltre ad essere il primo produttore di petrolio del continente. Inoltre, la Nigeria - dalla quale gli Stati Uniti ricevono il 5% delle proprie importazioni di petrolio - è l’ottavo esportatore di greggio del pianeta e il quarto di gas naturale.
Il presunto disinteresse di Washington - così come di Londra o Parigi - nel soccorrere il governo nigeriano potrebbe essere però messo in dubbio anche solo da alcuni dati fondamentali relativi al paese dell’Africa occidentale. La Nigeria, come già ricordato, è infatti il primo paese africano per popolazione e dimensioni dell’economia, oltre ad essere il primo produttore di petrolio del continente. Inoltre, la Nigeria - dalla quale gli Stati Uniti ricevono il 5% delle proprie importazioni di petrolio - è l’ottavo esportatore di greggio del pianeta e il quarto di gas naturale.
Più in generale, la nuova campagna dei governi occidentali in Nigeria rientra nella strategia avviata da qualche anno per aumentare la loro presenza in un continente che sta assumendo sempre maggiore importanza strategica, soprattutto per le enormi risorse del sottosuolo in gran parte non ancora sfruttate di cui dispone.
L’accelerazione di queste manovre è legata alla necessità di Washington e alleati di contrastare la crescente influenza di paesi emergenti - a cominciare dalla Cina, il cui governo in questi giorni ha anch’esso offerto assistenza alla Nigeria - in molte regioni del continente africano, dove hanno stabilito importanti partnership strategiche e investito decine di miliardi di dollari. A fornire poi la giustificazione del rinnovato impegno africano dell’Occidente è quasi sempre la necessità di combattere instabilità e terrorismo, allo stesso modo quasi sempre causati proprio dalle politiche occidentali.
La storia delle studentesse nigeriane, inoltre, offre per l’opinione pubblica internazionale un appeal irresistibile e difficilmente uguagliabile dalle vicende di altri paesi interessati dagli interventi occidentali. I fatti di queste settimane hanno anche un evidente parallelo con la campagna organizzata nel 2012 contro il signore della guerra ugandese Joseph Kony e sostenuta da svariate celebrità americane e non solo.
In quell’occasione, a suscitare l’indignazione selettiva dell’Occidente era stato l’impiego di bambini-soldato rapiti in vari paesi dell’Africa centrale dall’organizzazione di Kony (Esercito di Resistenza del Signore), per combattere il quale gli Stati Uniti avevano inviato in Uganda centinaia di militari delle forze speciali e velivoli da guerra.
Tutte queste battaglie sono perciò selezionate con cura dai governi occidentali, mentre i media “mainstream” sono complici nell’occultare sia le complesse realtà politiche e sociali che si nascondono dietro alle varie crisi, sia il fatto che altre atrocità - in Africa, come altrove, frequentemente causate proprio dagli Stati Uniti o dai loro alleati - non sembrano meritare lo stesso livello di attenzione e mobilitazione.
In relazione alla Nigeria, ad esempio, il governo nigeriano ha più di una responsabilità nell’esplosione della violenza per mano di Boko Haram. Innanzitutto, le diversità etniche e religiose del paese sono state spesso alimentate con conseguenze disastrose per dividere una popolazione in larghissima parte costretta in condizioni di miseria estrema nonostante le ricchezze petrolifere a disposizione.
Nella battaglia contro i militanti del gruppo integralista, inoltre, Abuja continua a utilizzare metodi repressivi, ricorrendo a torture, detenzioni illegali e omicidi deliberati di migliaia di innocenti, facendo aumentare il risentimento verso le autorità centrali soprattutto tra la popolazione di fede islamica. Il governo della Nigeria non è però il solo responsabile di una situazione di crescente precarietà che si estende a tutta la regione del Sahel. Boko Haram, infatti, come altre formazioni islamiste è sembrata beneficiare della destabilizzazione di tutta l’area in seguito ad un’altra impresa “umanitaria” occidentale, il rovesciamento del regime di Gheddafi in Libia nel 2011.
Il governo della Nigeria non è però il solo responsabile di una situazione di crescente precarietà che si estende a tutta la regione del Sahel. Boko Haram, infatti, come altre formazioni islamiste è sembrata beneficiare della destabilizzazione di tutta l’area in seguito ad un’altra impresa “umanitaria” occidentale, il rovesciamento del regime di Gheddafi in Libia nel 2011.
Gli effetti di questa campagna si erano fatti sentire inizialmente in Mali, dove un’organizzazione legata ad Al-Qaeda e gli indipendentisti Tuareg avevano preso il controllo del nord dello sterminato paese, richiedendo un altro intervento esterno, questa volta condotto dalla Francia.
La suddivisione del lavoro svolto dai governi occidentali nel gettare le basi della rioccupazione dell’Africa sta vedendo proprio Parigi in prima fila, essendo la ex potenza coloniale di vari paesi nei quali è stato deciso l’invio di truppe straniere.
Come ora in Nigeria, così era stato in Costa d’Avorio e più recentemente nella Repubblica Centrafricana, gettata nel caos guarda caso proprio da un colpo di stato favorito almeno tacitamente dalla Francia contro un presidente già protetto da Parigi e successivamente macchiatosi, tra l’altro, di eccessive aperture economiche e diplomatiche verso la Cina.
Gli Stati Uniti, com’è ovvio, rimangono però la forza trainante del riallineamento strategico occidentale in Africa, come dimostra l’impegno assunto in questi giorni in Nigeria con il pretesto delle studentesse rapite. Solo di qualche giorno fa è ad esempio l’annuncio di un accordo tra Washington e il governo di Gibuti per il prolungamento decennale della concessione alle forze USA di una gigantesca base nel piccolo paese affacciato sul Golfo di Aden, nel Corno d’Africa.
Lo strumento della politica statunitense in questo continente è il Comando Africano (AFRICOM), attivato ufficialmente dall’amministrazione Bush nell’ottobre del 2008, attraverso il quale Washington ha aumentato enormemente il proprio impegno militare e non solo, fino ad avere oggi almeno 5 mila uomini stanziati in maniera più o meno permanente in oltre trenta paesi.
A livello formale, i contingenti americani assumono spesso il ruolo di “consiglieri” dei vari governi ospitanti o svolgono incarichi “umanitari”, principalmente per evitare l’opposizione popolare all’impiego di forze armate degli Stati Uniti entro i confini dei propri paesi, come conferma il fatto che, a quasi sei anni dall’inaugurazione, il quartier generale di AFRICOM continua a rimanere in una base nella lontana Stoccarda.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il più recente atto di repressione contro il movimento Occupy Wall Street che aveva scosso gli Stati Uniti tra il 2011 e il 2012 è andato in scena questa settimana in un’aula di tribunale di New York, dove la studentessa 25enne Cecily McMillan è stata ritenuta colpevole dell’aggressione ad un poliziotto che la stava arrestando durante una protesta organizzata nel marzo del 2012.
Il procedimento legale ai danni della giovane attivista è durato incredibilmente due anni e si è concluso ancora più incredibilmente con un verdetto di condanna, nonostante le prove schiaccianti non solo della sua innocenza in relazione ai fatti addebitati, ma anche delle violenze da lei stessa subite e dell’abituale brutalità dell’agente di polizia, indicato come “vittima” nel processo.
I fatti in questione risalgono al 17 marzo di due anni fa, quando, al termine di una manifestazione nel parco Zuccotti, a Manhattan, per celebrare i sei mesi dalla nascita del movimento Occupy Wall Street, Cecily McMillan venne arrestata assieme ad una settantina di altri attivisti.
Il “crimine” commesso da quest’ultima sarebbe stato un colpo inferto con il gomito contro il viso dell’agente della polizia di New York, Grantley Bovell, il quale era però intento ad afferrarla in modo estremamente brusco da dietro la schiena. La ragazza ha sempre sostenuto di avere reagito istintivamente a quella che essa stessa riteneva un’aggressione, senza nemmeno accorgersi che la persona alle sue spalle fosse un poliziotto.
La versione della McMillan è stata supportata da numerose testimonianze, così come da filmati e immagini scattate durante l’arresto. Inoltre, in seguito all’assalto della polizia, l’accusata fu vittima di un malore che rese necessario il ricovero in ospedale. A causa delle percosse subite, la presunta assalitrice avrebbe poi presentato ematomi e ferite varie a schiena, spalle, testa e seno, tutte puntualmente documentate da immagini fotografiche. Come in un processo in uno stato di polizia, queste prove sono state tuttavia bollate come altamente sospette dall’accusa, quando non escluse del tutto, mentre la deposizione dell’agente Bovell - il quale, secondo alcuni reporter presenti in aula, si sarebbe addirittura sbagliato nell’indicare l’occhio colpito dal gomito di Cecily McMillan - è stata giudicata inattaccabile.
Come in un processo in uno stato di polizia, queste prove sono state tuttavia bollate come altamente sospette dall’accusa, quando non escluse del tutto, mentre la deposizione dell’agente Bovell - il quale, secondo alcuni reporter presenti in aula, si sarebbe addirittura sbagliato nell’indicare l’occhio colpito dal gomito di Cecily McMillan - è stata giudicata inattaccabile.
L’altra prova presentata dalla procuratrice Erin Choi è risultata poi essere un filmato di meno di un minuto e di pessima qualità apparso in maniera anonima su YouTube che avrebbe mostrato il momento in cui l’accusata ha colpito l’agente Bovell, tralasciando ciò che aveva causato la reazione istintiva della giovane e le stesse operazioni in corso delle forze di polizia, impegnate a percuotere e arrestare in maniera indiscriminata i manifestanti.
Come se non bastasse, il giudice scelto a presiedere il processo, Ronald Zweibel, si è anche rifiutato di ammettere come prova a discolpa della McMillan i referti medici sulle sue condizioni dopo le percosse ricevute per mano della presunta vittima. Il giudice Zweibel ha infine giudicato irrilevanti le testimonianze di altri attivisti che quella stessa sera del 17 marzo 2012 erano finiti ugualmente vittime dello stesso agente Bovell, tra cui un giovane al quale il poliziotto avrebbe sbattuto ripetutamente la testa contro i sedili dell’autobus utilizzato per trasportare gli arrestati.
Fuori dagli atti sono rimasti infine anche i file relativi ad almeno due procedimenti disciplinari subiti da Bovell durante la sua carriera nella polizia, il primo dopo che aveva investito un 17enne nel corso di un inseguimento e l’altro per avere colpito ripetutamente un sospettato steso sul pavimento di un negozio del Bronx.
Cecily McMillan, in ogni caso, dopo la condanna è stata subito trasferita nel famigerato carcere di Rikers Island, nell’East River di New York, dove attenderà il verdetto relativo alla pena da scontare, previsto per il 19 maggio, che potrebbe arrivare fino a sette anni.
Secondo l’avvocato della difesa, la decisione del giudice di escludere la possibilità di cauzione nel caso della sua assistita risulta alquanto insolita e conferma il carattere vendicatorio dell’intero procedimento. L’imputata, secondo il suo legale, sconterebbe in particolare il rifiuto del patteggiamento proposto dalla procura, secondo il quale la McMillan avrebbe dovuto accettare un capo d’accusa minore e in cambio sarebbero stati lasciati cadere quelli più gravi. L’attivista americana ha invece coraggiosamente insitito sulla sua innocenza, anche se accettando il patteggiamento non avrebbe fatto un solo giorno di carcere.
Viste le “anomalie” del processo di primo grado appena concluso, sembrano esserci ora ampi spazi per un ribaltamento della sentenza in appello. In molti mettono però in guardia dal clima intimidatorio nei confronti dei movimenti di protesta negli Stati Uniti e il crescente utilizzo dei tribunali per scoraggiare qualsiasi forma di dissenso contro il sistema. Le stesse modalità con cui il movimento Occupy Wall Street era stato represso durante il mandato dell’ex sindaco multi-miliardario di New York, Michael Bloomberg, testimoniano a sufficienza sia dei timori della classe dirigente USA per una rivolta sociale strisciante contro le enormi disuguaglianze che caratterizzano questo paese sia la mancanza di scrupoli nell’utilizzare metodi di polizia anti-democratici, spesso condannati dal governo di Washington quando vengono messi in atto da paesi nemici.
Le stesse modalità con cui il movimento Occupy Wall Street era stato represso durante il mandato dell’ex sindaco multi-miliardario di New York, Michael Bloomberg, testimoniano a sufficienza sia dei timori della classe dirigente USA per una rivolta sociale strisciante contro le enormi disuguaglianze che caratterizzano questo paese sia la mancanza di scrupoli nell’utilizzare metodi di polizia anti-democratici, spesso condannati dal governo di Washington quando vengono messi in atto da paesi nemici.
Occupy Wall Street, d’altra parte, pur non offrendo una chiara prospettiva politica ed economica alternativa, aveva per la prima volta da molti anni portato al centro del dibattito le esplosive questioni di classe esistenti negli Stati Uniti, mettendo l’accento sull’accentramento del potere politico ed economico nelle mani di una ristrettissima cerchia, identificata con lo slogan dell’1%.
Ciò aveva incontrato un certo sostegno tra la popolazione, così che le autorità hanno ben presto proceduto con la repressione dei vari centri di protesta che erano sorti nelle principali città americane, quasi sempre con la giustificazione di dover fare rispettare l’ordine pubblico o, quando sono stati smantellati gli accampamenti pacifici nei parchi cittadini, le norme sanitarie.
Tra i sostenitori di Occupy Wall Street gli arresti sono stati alla fine migliaia, anche se la grande maggioranza dei fermati sarebbero stati successivamente rilasciati senza essere incriminati, soprattutto dopo che il movimento ha iniziato a perdere energia. La vicenda di Cecily McMillan, perciò, risulta emblematica e la giovane attivista potrebbe essere stata presa di mira come esempio, visto che era stata una degli organizzatori del movimento ed era apparsa in molte cronache sui principali giornali nazionali.
Il suo caso, inoltre, spicca per la ferocia e la determinazione con cui l’ufficio del procuratore distrettuale di New York, il democratico Cyrus Vance jr., ha perseguito la condanna in aula. Determinazione che il figlio dell’ex segretario di Stato americano ai tempi di Jimmy Carter ha invece mancato di dimostrare nei confronti di reali associazioni a delinquere come le principali banche di Wall Street, le cui attività criminali rientrerebbero interamente nelle competenze della procura della Grande Mela.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
Dopo sei mesi di scontri e proteste di piazza, l’opposizione anti-governativa e i tradizionali centri di poteri thailandesi hanno ottenuto uno dei loro obiettivi principali nella giornata di mercoledì grazie ad una sentenza tutta politica del più altro tribunale del paese del sud-est asiatico. Quello che è avvenuto a Bangkok è stato nulla di meno di un golpe giudiziario, portato a termine dalla Corte Costituzionale contro il primo ministro, Yingluck Shinawatra, rimossa dal suo incarico con l’accusa di “abuso di potere”.
Il procedimento contro il capo del governo era stato avviato da alcuni senatori dell’opposizione ed era legato al trasferimento ad altro incarico del numero uno del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Thawil Pliensri, nel settembre del 2011 subito dopo la vittoria elettorale del partito Pheu Thai. Secondo l’accusa, Thawil era stato messo da parte per fare spazio ad un membro di quest’ultimo partito, nonché parente di Yingluck, Priewpan Damapong, con modalità che, appunto, avrebbero indicato un “abuso di potere”.
La decisione rischia ora di aggravare ulteriormente la situazione già tesa in Thailandia, soprattutto in vista delle annunciate iniziative dei sostenitori del governo nelle strade della capitale, Bangkok. Inoltre, la Corte Costituzionale ha declinato la nomina di un nuovo premier, così che un esecutivo già notevolmente indebolito e con un incarico ad interim dallo scorso dicembre si troverà a dover gestire una difficile uscita dalla crisi e a provare ad evitare il completamento di un colpo di stato sempre più probabile.
I nove giudici della Corte Costituzionale thailandese hanno dunque votato all’unanimità per condannare Yingluck e rendere nullo il suo status di primo ministro. Contemporaneamente, anche una decina di ministri in carica ora e durante i fatti incriminati sono stati sollevati dai loro incarichi, tra cui quelli delle Finanze, degli Esteri e del Lavoro.
Secondo la Corte, la rimozione di Thawil dalla guida del Consiglio per la Sicurezza Nazionale rientrava in realtà tra i poteri del premier, ma la decisione sarebbe stata presa in maniera precipitosa e, soprattutto, allo scopo unico di liberare l’incarico per un suo parente. La natura quanto meno bizzarra del procedimento contro Yingluck e le ragioni puramente politiche dietro ad esso sono confermate poi dal fatto che lo stesso Thawil era stato reintegrato lo scorso marzo al suo posto da un tribunale amministrativo thailandese, mentre egli stesso aveva più volte affermato le sue simpatie per il movimento di opposizione anti-governativo.
Anche se la sentenza di mercoledì incoraggerà le forze anti-governative a dare la spallata decisiva a quello che viene definito come il “regime degli Shinawatra”, alla maggioranza del Pheu Thai è stata riconosciuta la possibilità di scegliere un nuovo premier provvisorio per traghettare il paese verso nuove elezioni. Poche ore dopo il verdetto, così, un vertice del partito ha nominato il ministro del Commercio, Niwatthamrong Boonsongpaisarn, alla carica di premier ad interim al posto di Yingluck. L’opposizione politica dominata dal Partito Democratico e quella attiva nelle piazze, organizzata nel cosiddetto Comitato Popolare per la Riforma Democratica (PDRC), intendono invece rimandare la data del voto, così da creare un esecutivo di transizione non eletto che operi una serie di “riforme” volte a sradicare l’influenza della famiglia di Yingluck e dell’ex premier in esilio Thaksin.
L’opposizione politica dominata dal Partito Democratico e quella attiva nelle piazze, organizzata nel cosiddetto Comitato Popolare per la Riforma Democratica (PDRC), intendono invece rimandare la data del voto, così da creare un esecutivo di transizione non eletto che operi una serie di “riforme” volte a sradicare l’influenza della famiglia di Yingluck e dell’ex premier in esilio Thaksin.
Proprio settimana scorsa, l’ex primo ministro Democratico, Abhisit Vejjajiva, aveva incontrato i vertici supremi delle forze armate thailandesi - finora ufficialmente neutrali anche se con chiare simpatie per l’opposizione - proponendo una sorta di “road map” per superare lo stallo, con contenuti virtualmente simili a quelli avanzati da mesi dai leader del PDRC.
La data del voto era stata in ogni caso stabilita recentemente per il 20 luglio prossimo tra il governo e la Commissione Elettorale. Ciò si è reso necessario dopo che sempre la Corte Costituzionale aveva invalidato l’elezione dello scorso febbraio vinta dal Pheu Thai, poiché non si era potuta tenere in un unico giorno in tutto il paese a causa proprio delle manifestazioni di protesta messe in atto dai gruppi di opposizione.
Dopo la sentenza di mercoledì, la premier Yingluck ha respinto le accuse di abuso di potere, mentre molto dura è stata la reazione del numero due del partito Pheu Thai, Phokin Palakul, il quale ha definito il parere della Corte Costituzionale come un tentativo di distruggere la sua formazione politica. Phokin ha poi invitato tutti i thailandesi “che amano la democrazia ad esprimere la loro opposizione alla sentenza in modi pacifici”, mentre ha affermato che il voto di luglio servirà a “risolvere la crisi politica in maniera democratica”.
L’appello alla mobilitazione del leader del partito Pheu Thai fa eco alle minacce dei vertici delle cosiddette “Camicie rosse” filo-governative di portare centinaia di migliaia di thailandesi nelle strade di Bangkok. Alcuni giorni fa, in previsione della decisione della Corte su Yingluck, il numero uno delle “Camicie rosse”, Jatuporn Prompan, aveva annunciato una manifestazione nella capitale per sabato prossimo, anche se già giovedì potrebbero esserci i primi cortei a sostegno della deposta premier.
I simpatizzanti del governo in carica vengono in larga misura dalle aree rurali della Thailandia tradizionalmente emarginati dalla borghesia della capitale e delle provincie meridionali del paese, da dove il Partito Democratico, la casa regnante, le Forze Armate e la burocrazia statale traggono il proprio sostegno.
Queste ultime forze si sentono da tempo minacciate dall’irruzione sulla scena politica thailandese del clan Shinawatra, a cominciare dal successo elettorale nel 2001 di Thaksin che lo portò per la prima volta alla guida del governo. Il magnate delle telecomunicazioni ha da allora coltivato una solida base elettorale tra i ceti più disagiati del suo paese, soprattutto attraverso limitate politiche di riforma sociale.
Avendo perso ogni elezione da due decenni a questa parte, il Partito Democratico, con l’appoggio dei centri di potere ad esso vicini, ha allora utilizzato i militari e i tribunali per cercare di liquidare dapprima lo stesso Thaksin e in seguito i governi e i partiti che lo hanno succeduto.
Un ruolo di primo piano in questo senso lo ha giocato proprio la Corte Costituzionale, le cui prerogative erano state ampliate dalla nuova Costituzione redatta nel 2007 da una commissione nominata dalla giunta militare dopo il colpo di stato dell’anno precedenti ai danni di Thaksin. Sempre nel 2007, poi, per via giudiziaria venne sciolto il partito di Thaksin - Thai Rak Thai - con l’accusa di violazione della legge elettorale e più di 100 suoi membri furono banditi dall’attività politica per cinque anni. Nel 2008, la Corte Costituzionale avrebbe messo fuori legge anche il successore del Thai Rak Thai, il Partito del Potere Popolare, e rimosso contestualmente dalla carica di primo ministro Somchai Wongsawat, cognato di Thaksin. Poche settimane prima, la stessa sorte di quest’ultimo era toccata al suo predecessore, il defunto Samak Sundaravej, colpevole di non avere abbandonato la conduzione di un programma culinario in televisione dopo la nomina a primo ministro.
Sempre nel 2007, poi, per via giudiziaria venne sciolto il partito di Thaksin - Thai Rak Thai - con l’accusa di violazione della legge elettorale e più di 100 suoi membri furono banditi dall’attività politica per cinque anni. Nel 2008, la Corte Costituzionale avrebbe messo fuori legge anche il successore del Thai Rak Thai, il Partito del Potere Popolare, e rimosso contestualmente dalla carica di primo ministro Somchai Wongsawat, cognato di Thaksin. Poche settimane prima, la stessa sorte di quest’ultimo era toccata al suo predecessore, il defunto Samak Sundaravej, colpevole di non avere abbandonato la conduzione di un programma culinario in televisione dopo la nomina a primo ministro.
Queste iniziative giudiziarie si sono risolte infine nell’ascesa al potere senza passare attraverso il voto popolare del Partito Democratico sotto la guida di Abhisit, responsabile assieme al suo vice e all’attuale leader del PDRC, Suthep Thaugsuban, della durissima repressione avvenuta a Bangkok nel 2010 delle “Camicie Rosse”, tra i cui sostenitori si contarono un centinaio di morti.
Se, ad esempio, Suthep rimane oggi in libertà nonostante un mandato di arresto per avere ordinato il massacro, i tribunali thailandesi sono tornati a perseguire i vertici del nuovo governo a partire dall’autunno scorso, quando sono riesplose le proteste di piazza in seguito ad un fallito tentativo da parte del partito di maggioranza di modificare la Costituzione e di fare approvare un’amnistia che avrebbe permesso a Thaksin di rientare in patria nonostante una condanna per abuso di potere.
Oltre al procedimento che ha portato mercoledì alla destituzione di Yingluck, la ormai ex premier e vari parlamentari del suo partito erano finiti al centro di altri procedimenti motivati politicamente, usati come strumento per operare un cambio di governo.
Yingluck è accusata anche di avere gestito in maniera sconsiderata un piano di acquisto di riso dai coltivatori indigeni a prezzi superiori a quelli di mercato, mentre decine di parlamentari del Pheu Thai erano stati indagati sostanzialmente per avere fatto il loro dovere, presentando cioè la già citata proposta di modifica costituzionale per rendere interamente elettivo il Senato thailandese.
La situazione nel paese dell’Asia sud-orientale rischia dunque di precipitare nei prossimi giorni, oltretutto con gli indicatori economici continuamente ritoccati verso il basso a causa del persistere delle tensioni interne.
Nelle ultime settimane erano perciò aumentate le voci preoccupate per lo stallo a Bangkok, con gli ambienti politici e finanziari internazionali sempre più orientati a tollerare - almeno tacitamente - un colpo di mano per togliere di mezzo il governo di Yingluck e favorire uno sblocco della situazione che, contestualmente, potrebbe portare alla fine definitiva delle politiche populiste favorite dal Pheu Thai e incanalare anche la Thailandia sulla strada dell’austerity.
