- Dettagli
- Scritto da Bianca Cerri
 Bernie Maddoff gestiva il più grande schema Ponzi della storia degli Stati Uniti. Per chi non è pratico di finanza, si tratta di un sistema che promette forti guadagni a vittime delle truffe a patto che queste reclutino nuovi investitori. In sintesi Madoff era un truffatore. Nel 2008 era stato arrestato e incriminato per frode in titoli per un totale di 65 miliardi di dollari. Danny Chin, il giudice del tribunale di New York chiamato a decidere la sorte di Madoff, gli aveva inflitto 150 anni di carcere, sottolineando che si era trattato di un uomo straordinariamente diabolico. Madoff ammise la sua colpevolezza chiedendo scusa alle vittime.
Bernie Maddoff gestiva il più grande schema Ponzi della storia degli Stati Uniti. Per chi non è pratico di finanza, si tratta di un sistema che promette forti guadagni a vittime delle truffe a patto che queste reclutino nuovi investitori. In sintesi Madoff era un truffatore. Nel 2008 era stato arrestato e incriminato per frode in titoli per un totale di 65 miliardi di dollari. Danny Chin, il giudice del tribunale di New York chiamato a decidere la sorte di Madoff, gli aveva inflitto 150 anni di carcere, sottolineando che si era trattato di un uomo straordinariamente diabolico. Madoff ammise la sua colpevolezza chiedendo scusa alle vittime.
- Dettagli
- Scritto da Bianca Cerri
 Il 30 aprile del 1975, gli accordi di Parigi mettevano fine alla criminale avventura statunitense in Vietnam. Il Paese di Ho-Chi-Minh e Nyguen Von Giap era libero, Washinton si arrese, aveva perso. Tra il 1955 ed il 1975 l'esercito degli Stati Uniti che aveva invaso il sud asiatico perse circa 59 mila soldati. 47.435 caddero ufficialmente in battaglia. Continuarono a vivere in decine di libri e di films che li rappresentarono come la più grande generazione della storia del loro paese. Nel 1981, a Washington, fu eretto un bellissimo muro in lucido granito nero con il nome di ciascun caduto inciso in oro. Sui reduci di quella guerra si scatenò invece un'aspra battaglia che divise gli Stati Uniti. Gli eroi non tornano mai a casa vivi e difficilmente trovano un centro di gravità in una società che li vedeva come falliti.
Il 30 aprile del 1975, gli accordi di Parigi mettevano fine alla criminale avventura statunitense in Vietnam. Il Paese di Ho-Chi-Minh e Nyguen Von Giap era libero, Washinton si arrese, aveva perso. Tra il 1955 ed il 1975 l'esercito degli Stati Uniti che aveva invaso il sud asiatico perse circa 59 mila soldati. 47.435 caddero ufficialmente in battaglia. Continuarono a vivere in decine di libri e di films che li rappresentarono come la più grande generazione della storia del loro paese. Nel 1981, a Washington, fu eretto un bellissimo muro in lucido granito nero con il nome di ciascun caduto inciso in oro. Sui reduci di quella guerra si scatenò invece un'aspra battaglia che divise gli Stati Uniti. Gli eroi non tornano mai a casa vivi e difficilmente trovano un centro di gravità in una società che li vedeva come falliti.
Poi arrivarono le Torri Gemelle con tremila morti e il paese indietreggiò per l'orrore. Il tragico evento ha avuto le sue ombre e fu manipolato da doppiogiochisti, ma in termini di vite umane ebbe un costo altissimo e in un certo senso diede origine a nuove forme di eccezionalismo americano.
- Dettagli
- Scritto da Bianca Cerri
 A Hollywood in questi giorni si fa un gran parlare di una storia che presto potrebbe diventare un film. E' il racconto della vita di Giorgia Tann, che nel 1924 fondò un'agenzia per le adozioni completamente illegale allo scopo di procurarsi neonati o piccoli di pochi anni da vendere a famiglie danarose. La gente comune ignorava che la Tennessean Children Home Association, con sede a Memphis, in Tennessee, non era un ente benefico ma una vera e propria associazione a delinquere che si appropriava di bambini sottraendoli a famiglie poverissime o rubandoli dai reparti maternità degli ospedali. Nessuno avrebbe mai sospettato che si potesse far sparire un neonato o un piccolo di pochi mesi in un attimo. Tann non era tenuta a fornire la benché minima informazione sui minori accolti nel suo istituto.
A Hollywood in questi giorni si fa un gran parlare di una storia che presto potrebbe diventare un film. E' il racconto della vita di Giorgia Tann, che nel 1924 fondò un'agenzia per le adozioni completamente illegale allo scopo di procurarsi neonati o piccoli di pochi anni da vendere a famiglie danarose. La gente comune ignorava che la Tennessean Children Home Association, con sede a Memphis, in Tennessee, non era un ente benefico ma una vera e propria associazione a delinquere che si appropriava di bambini sottraendoli a famiglie poverissime o rubandoli dai reparti maternità degli ospedali. Nessuno avrebbe mai sospettato che si potesse far sparire un neonato o un piccolo di pochi mesi in un attimo. Tann non era tenuta a fornire la benché minima informazione sui minori accolti nel suo istituto.
Eppure attrici dal nome famoso, come Joan Crawford, Lana Turner e June Allyson, che non erano riuscite a concepire figli biologici, si rivolsero alla Tennessean Children Home Association per soddisfare il loro desiderio di maternità. Tann era una donna scaltra che operava con grande cautela. Le vittime più vulnerabili erano naturalmente i neonati.
Tann ricorreva a qualunque mezzo, compreso il più bieco, per impadronirsi dei bambini, sapendo che nessuno delle sue vittime sarebbe mai tornata indietro. Si ritiene che almeno cinquanta delle sfortunate creature siano morte durante l'epidemia di dissenteria del 1945. E centinaia di altri innocenti morirono per cause legate alle infami pratiche alle quali furono sottoposte.
La gente immagina che un serial killer sia in genere un uomo che uccide le donne, ma Tann, che tolse la vita volontariamente o “incidentalmente”, a centinaia di minori può essere considerata a buon diritto una delle serial killer più feroci della storia degli Stati Uniti. Esistono evidentemente miti duri a morire, tanto è vero che raramente ci si accorge che nelle fiabe dei fratelli Grimm, ad esempio, che dovrebbero conciliare il sonno ai bambini, abbondano personaggi truci e violenti che invece li terrorizzano. Ma l'horror generato da Georgia Tann nella realtà avrebbe superato ogni immaginazione se solo la gente ne fosse venuta a conoscenza. I bambini troppo rozzi e non “commercialmente appetibili” secondo la sua scala di valori, non andavano bene per il mercato delle adozioni e furono venduti come ragazzi nelle fattorie a soli cinque o sei anni. Tutte le circa cinquemila vittime finite nelle mani della donna venivano da famiglie povere e rivendute ai ricchi.
Tann aveva studiato musica da piccola e da grande avrebbe voluto fare l'avvocato ma il padre giudice le vietò di iscriversi alla facoltà di legge convinto che la carriera giuridica fosse troppo “mascolina” per la sua unica figlia. Sperava di trovarle prima o poi un marito ed avere dei nipoti. Ma Tann era già impegnata sentimentale con l'ex-cameriera della casa paterna e con lei si trasferì dal nativo Mississippi al Tennessee decisa a fondare un istituto per trovatelli ben sapendo che a Memphis le adozioni erano molto più semplici.
Nel 1924 aprì un grande ufficio nella centralissima Goldwyn Street che divenne la sede centrale della “Children Association” destinata a durare quasi 30 anni. Tann aveva già lavorato brevemente presso la Mississippi Children Home Society e imparato che dai bambini si potevano trarre profitti. Il periodo della Grande Depressione lasciò molte donne in miseria che, a suo modo di vedere, erano soltanto delle “vacche” tout court.
Riusciva a falsificare i quaderni dei conti grazie all'aiuto del sindaco di Memphis e di Camilla Kelley, giudice per i minori, che la sostenevano anche nelle attività più losche. Neonati e bambini piccolissimi furono rapiti anche da prigioni e manicomi, altri terreni di caccia dove Tann sapeva come procurarsi nuove prede, tanto più che in quei luoghi le madri non avevano diritti. Detenute e malate di mente erano nell'assoluto ritenute inadatte a mettere al mondo dei figli. Ma si poteva guadagnare bene vendendoli.
Tann si era auto-nominata Segretario Generale dell'Istituto e maneggiava migliaia di dollari. All'epoca non si parlava ancora di business ma i profitti erano comune luculliani.
Giorgia Tann frequentava l'alta società di Memphis e conduceva uno stile di vita sfarzoso grazie all'abbondanza di bambini e ragazzi malnutriti in tutto il Tennessee. Nel 1941, tuttavia, la Children Home Association perse l'appoggio dell'Ente Nazionale per l'Infanzia Abbandonata.
 Tann ebbe però vita facile difendendosi dall'accusa di aver violato la legge per non aver mai presentato i documenti richiesti per ogni singola adozione, ricusandola come sediziosa dal momento che lo stesso codice penale degli Stati Uniti vieta di rendere pubbliche notizie relativi ai minori. Avendo amici in tutti gli uffici distrettuali continuò beatamente a speculare sulle tragedie infantili. La pifferaia magica senza scrupoli riuscì anche ad allargare il proprio giro d'affari. Da sempre considerava i neri e le altre minoranze inaccettabili commercialmente e si procurava soprattutto piccoli biondi con gli occhi azzurri. Aveva agenti ovunque pronti ad afferrare bambini e portarli lontano. Per incentivare la sua fama di benefattrice Tann fece pubblicare annunci a lettere cubitali sui giornali con titoli come “Perché non fare un regalo vivente il prossimo Natale”?
Tann ebbe però vita facile difendendosi dall'accusa di aver violato la legge per non aver mai presentato i documenti richiesti per ogni singola adozione, ricusandola come sediziosa dal momento che lo stesso codice penale degli Stati Uniti vieta di rendere pubbliche notizie relativi ai minori. Avendo amici in tutti gli uffici distrettuali continuò beatamente a speculare sulle tragedie infantili. La pifferaia magica senza scrupoli riuscì anche ad allargare il proprio giro d'affari. Da sempre considerava i neri e le altre minoranze inaccettabili commercialmente e si procurava soprattutto piccoli biondi con gli occhi azzurri. Aveva agenti ovunque pronti ad afferrare bambini e portarli lontano. Per incentivare la sua fama di benefattrice Tann fece pubblicare annunci a lettere cubitali sui giornali con titoli come “Perché non fare un regalo vivente il prossimo Natale”?
Quasi tutti nel Tennessee si convinsero che la donna fosse motivata solo dall'altruismo. Per sua stessa ammissione Georgia Tann non provava alcun rimorso neppure nei confronti delle madri che cedevano i figli stremate dalla miseria. Quei bambini li definiva semplicemente “vuoti a perdere”. In California e a New York c'erano tante persone facoltose incapaci di procreare che si rivolgevano alla Children Home Association che esaudiva i loro desideri dietro pagamenti iperbolici. Si procurò una limousine per portare i bambini vestiti in modo inappuntabile fino a destinazione.
Ai bambini non idonei all'adozione non mancarono fame e abusi. Basti dire che all'epoca di Tann il tasso di mortalità infantile in Tennessee superò ogni limite. All'Elmwood Cemetery di Memphis 20 tombe senza nome racchiudono i corpi di bambini morti a cause delle pratiche criminali della “benefattrice”. Solo nomi di fantasia compaiono sulle lapidi:“Baby Estelle” o “Baby Joseph” ecc. E' stato cancellato qualunque indizio riconducibile ad un'identità. Dai taccuini di Tann venuti a galla dopo la sua morte si parla di sepolture avvenute in altri luoghi di neonati morti poco ore dopo la nascita per negligenza.
Il 15 settembre del 1950 la ladra di bambini morì, tre giorni prima che scattasse un'indagine nei suoi confronti. Nessuno ha mai saputo a quanto ammontassero i profitti di Tann ma le politiche adottive disoneste hanno continuato a proliferare. I trovatelli nelle strade oggi non si raccolgono più ma nel frattempo sono sorte migliaia di agenzie che, in accordo con il dipartimento per la Protezione dell'Infanzia, macinano migliaia e migliaia di dollari.
Si resta basiti scoprendo che negli Stati Uniti le adozioni avvengono sulla falsariga del modello inventato da Giorgia Tann. Nel terzo millennio i minori sono diventati una cornucopia che si divide in varie ramificazioni basate sempre sulla nozione capitalistica di domanda-offerta. Da quanto afferma l'autorevole Economist esiste un vero e proprio tariffario che discrimina bambini e ragazzi in stato di adozione a seconda dal colore della pelle. I bianchi danarosi chiedono prevalentemente minori dello stesso colore.
Persino John Roberts, giudice capo della Corte Suprema USA, ha espressamente chiesto ad un agenzia incaricata due bambini caucasici con gli occhi chiari. Non ha avuto nessun problema a trovarli. Solo chi ha pochi mezzi fatica ad adottare ma le agenzie sono disposte a trattare. Adottando un bambino nero si possono risparmiare migliaia di dollari. L'Associazione Nazionale per le Adozioni è una lobby privata che raggruppa ventotto grandi filiali e riceve dal ministero del Tesoro USA dieci milioni di dollari l'anno per incentivare donne in stato interessante a cedere i figli dopo la nascita se non in grado di mantenerli.
Ahimè non è detto che i funzionari lavorino a favore dei bambini ma sicuramente considerano le madri nubili delle poche di buono senza eccezioni. Si dice che il grande cuore degli americani batta per i piccoli in cerca di una famiglia ma la stessa NPR ha scritto a chiare lettere che i battiti dipendono dal colore della pelle e i neri valgono meno. Per questo hanno dato il via al Race Card Project dal quale risulta appunto che se i bianchi si “accontentano” di un bambino nero il processo adottivo diventa molto più veloce.
L'ipotesi di aiutare le madri povere in modo che possano tenersi il figlio non è stata valutata ed è chiaro che un mercato da due miliardi di dollari l'anno non ammette sentimentalismi. Le agenzie trovano sempre un modo grazioso per ricordare che i piccoli caucasici non sono alla portata di tutti. D'altra parte, qualche anno fa molti i bianchi non acquistavano neppure bambole di colore per le bambine se non in offerta speciale.
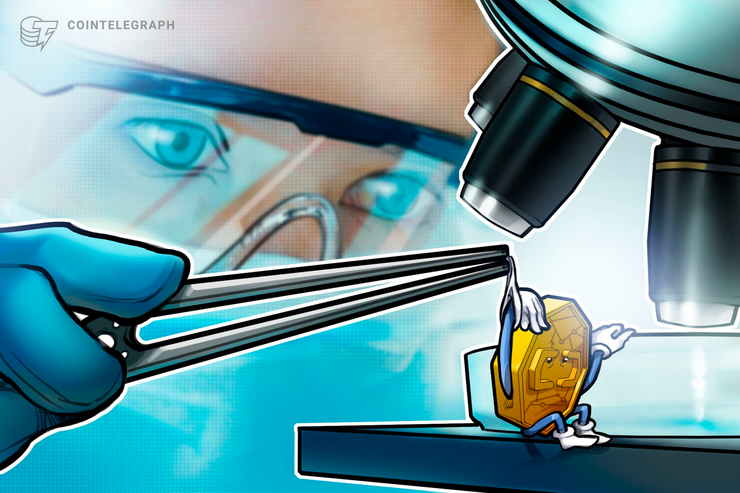 Oggi, sulle pagine delle riviste di settore, capita di trovare annunci in cui si legge: “Maschietto afro-americano, nascita prevista per ottobre, 17 mila dollari, oppure “Fermminuccia afro madre single non fumatrice prevista per agosto, 15 mila dollari”. Più spese legali ovviamente. Sono quasi 150 anni che in America la legge vieta le discriminazioni razziali ma le agenzie per le adozioni pare non ne abbiano preso nota. E' richiesta anche una perizia psicologica per gli aspiranti genitori ma sono soprattutto i bianchi a potersela permettere. Tutto l'iter adottivo può infatti rivelarsi emotivamente tortuoso e soprattutto costoso. Uno psicologo esperto costa circa tra 400 e mille dollari a seduta. Conti alla mano, solo il 32% degli americani che vogliono adottare un figlio possono permetterselo. Aprire la propria casa ad un bambino è un gesto amorevole che non dovrebbe tener conto delle difficoltà finanziarie ma a volte si è costretti a fare i conti con la realtà.
Oggi, sulle pagine delle riviste di settore, capita di trovare annunci in cui si legge: “Maschietto afro-americano, nascita prevista per ottobre, 17 mila dollari, oppure “Fermminuccia afro madre single non fumatrice prevista per agosto, 15 mila dollari”. Più spese legali ovviamente. Sono quasi 150 anni che in America la legge vieta le discriminazioni razziali ma le agenzie per le adozioni pare non ne abbiano preso nota. E' richiesta anche una perizia psicologica per gli aspiranti genitori ma sono soprattutto i bianchi a potersela permettere. Tutto l'iter adottivo può infatti rivelarsi emotivamente tortuoso e soprattutto costoso. Uno psicologo esperto costa circa tra 400 e mille dollari a seduta. Conti alla mano, solo il 32% degli americani che vogliono adottare un figlio possono permetterselo. Aprire la propria casa ad un bambino è un gesto amorevole che non dovrebbe tener conto delle difficoltà finanziarie ma a volte si è costretti a fare i conti con la realtà.
Davanti alla frustrante prospettiva della cosiddetta “sindrome da culla vuota” molti si rivolgono all'affido. L'affido familiare è una misura a carattere temporaneo. L'America ha un imponente sistema a questo riguardo. La grande domanda è: quanti genitori affidatari sono mossi dall'affetto e quanti speculano sul disagio minorile? Difficile dare una risposta semplice e diretta. Una cosa è certa: nulla assicura che la forza motrice delle adozioni sia l'altruismo. Bisogna ricordare che se in dieci anni bambini e ragazzi in stato d'abbandono negli Stati Uniti sono passati da 100 e 400 mila un motivo ci sarà ed è triste pensare che sia il denaro. Tuttavia vale pena di ricordare che i genitori affidatari ricevono circa 30-35 dollari al giorno per ciascun minore accolto. Esistono poi rimborsi per costi di alloggio, vestiario, indennità personali, cure mediche,attività sportive, ecc. Alcuni genitori hanno ottenuto in affido fino a sei bambini. Se il minore ha dei bisogni speciali la cifra sale.
Una mega-agenzia conosciuta come National Mentor Holdings, in 30 anni ha trasformato l'assistenza minorile in una mucca da mungere. Molti ex-dipendenti hanno rivelato che l'agenzia sfrutta centinaia di bambini e ragazzi vulnerabili a scopo di lucro. Ci sono stati 98 morti nelle famiglie affidatarie nel solo 2019. Ogni minore dato in affidamento frutta alla Mentor o a qualunque altra agenzia circa seimila dollari l'anno. La gente comune pensa che i fondi federali destinati ai minori negli Stati Uniti servano a migliorare la qualità di vita ma il vero problema è che molte coppie o single affidatari sono in realtà avvoltoi che vogliono solo spartirsi il malloppo. Qualunque assistente sociale riceve un bonus in denaro per un minore sottratto ad un ambiente percepito come “non idoneo”.
Si sa che nelle case dove regna la miseria l'armonia familiare è assai precaria ma questo non giustifica togliere i figli a chi non può pagare le bollette. Tolti alla famiglia, i minori vengono presi da forme d'ansia e depressione che li condizioneranno tutta la vita. Un'industria farmaceutica cinica e famelica si servirà di loro come cavie da laboratorio. Vuoti a perdere, come aveva detto tanti anni fa una strega malefica.
- Dettagli
- Scritto da Bianca Cerri
 Sarebbe stata una bella festa di nozze quella di Beatrice di York con l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi organizzata a Buckingham Palace per il 29 maggio. Ma è intervenuto il destino sotto forma di COVID-19, un virus che sta flagellando il mondo, e la festa avverrà in data da destinarsi, se mai si farà. Fino agli anni '80 ci si sposava a seconda delle proprie possibilità, poi il matrimonio di Carlo e Diana infiammò la fantasia della gente e tutti gli sposi volevano cerimonie fiabesche che richiedevano un'organizzazione meticolosa. Per chi ha un budget ridotto la festa di nozze può diventare una croce prima ancora che sia celebrata ma anche i cosiddetti “happy few” potrebbero ritrovarsi nei guai nel tentativo di abbinare glamour e solennità. Per fortuna in questi ultimi anni c'è stato l'avvento di una nuova figura professionale che riesce a realizzare cerimonie da favola on demand rispettando gusti e gender degli sposi: il wedding-planner.
Sarebbe stata una bella festa di nozze quella di Beatrice di York con l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi organizzata a Buckingham Palace per il 29 maggio. Ma è intervenuto il destino sotto forma di COVID-19, un virus che sta flagellando il mondo, e la festa avverrà in data da destinarsi, se mai si farà. Fino agli anni '80 ci si sposava a seconda delle proprie possibilità, poi il matrimonio di Carlo e Diana infiammò la fantasia della gente e tutti gli sposi volevano cerimonie fiabesche che richiedevano un'organizzazione meticolosa. Per chi ha un budget ridotto la festa di nozze può diventare una croce prima ancora che sia celebrata ma anche i cosiddetti “happy few” potrebbero ritrovarsi nei guai nel tentativo di abbinare glamour e solennità. Per fortuna in questi ultimi anni c'è stato l'avvento di una nuova figura professionale che riesce a realizzare cerimonie da favola on demand rispettando gusti e gender degli sposi: il wedding-planner.
- Dettagli
- Scritto da Bianca Cerri
 Per chi non era ancora nato il nome My Lai può significare molto poco. Ben poco è stato scritto sui libri di scuola su quel genocidio. My Lai fu coperta a lungo da silenzio. Mentre tutto il mondo sta lottando contro una devastante pandemia cosa possiamo imparare da quel massacro? Tonnellate e tonnellate di bombe caddero sul sud est-asiatico alterando per sempre una natura rigogliosa. Morirono circa sei milioni di persone e migliaia di uomini di giovani soldati di leva tornarono con la mente sconvolta. My Lai ha rappresentato la pietra miliare di una guerra atroce. E la storia di My Lai resta una ferita ancora aperta
Per chi non era ancora nato il nome My Lai può significare molto poco. Ben poco è stato scritto sui libri di scuola su quel genocidio. My Lai fu coperta a lungo da silenzio. Mentre tutto il mondo sta lottando contro una devastante pandemia cosa possiamo imparare da quel massacro? Tonnellate e tonnellate di bombe caddero sul sud est-asiatico alterando per sempre una natura rigogliosa. Morirono circa sei milioni di persone e migliaia di uomini di giovani soldati di leva tornarono con la mente sconvolta. My Lai ha rappresentato la pietra miliare di una guerra atroce. E la storia di My Lai resta una ferita ancora aperta
Il sedici marzo del 1968, alle prime ore del mattino, un battaglione di soldati americani che avevano occupato il Vietnam, massacrò in un fossato 507 vecchi, donne e bambini. Gli uomini in divisa verde avrebbero dovuto dare la caccia a bande di vietcong ma si accontentarono di sterminare civili inermi disarmati. Nel giro di poche ore il villaggio di My Lai fu cancellato.
Quel massacro pesa ancora sulla coscienza di un'intera nazione. Non è facile capire come un gruppo di giovani americani, che probabilmente non avrebbero mai ucciso se non fossero stati costretti ad andare nel sud est asiatico, arrivò a commettere atrocità tali da rimanere impresse in modo indelebile nella storia del loro stesso paese. D'altra parte, è ovvio che quando i leaders decidono di immolare migliaia di ragazzi per incrementare i loro profitti la ferocia si scatenerà necessariamente,come è avvenuto prima e dopo il Vietnam. Può accadere però che anche chi crede che la guerra possa essere una risorsa si renda conto che le malvagità sono andate oltre ogni limite e decida di ribellarsi contro il suo stesso esercito. Questo è quanto accadde ai pochi eroi presenti il giorno della strage di My Lai.
Le eccezioni sono il sale della terra e tre uomini in elicottero, Glenn Andreotta, Lawrence Colburn e Hugh Thompson, erano soldati come tutti gli altri ma con un senso della rettitudine che mancava ai commilitoni. I tre s'infuriarono vedendo dall'alto centinaia di corpi senza vita in un fosso dove c'erano solo vecchi, donne e bambini probabilmente perchè gli uomini erano al lavoro nei campi. I ragazzini più grandicelli cercavano inutilmente di mettersi in salvo inseguiti dai militari americani.
Thompson , tornato alla base, aveva detto ai superiori che probabilmente i soldati stavano facendo un vero e proprio eccidio: c'era qualcosa che non andava e i morti si stavano accatastando. Nessuno gli diede retta.
Allora Thompson decise di ammutinarsi pronto a sparare su chiunque avrebbe continuato ad accanirsi sui civili. Tutti i tre gli uomini dell'equipaggio furono d'accordo che quella frenesia assassina andasse fermata a ogni costo. Thompson volò di nuovo nei pressi del fossato dove aveva visto i corpi ammassati. Glenn Andreotta e Larry Colburn si calarono all'interno scavalcando i cadaveri, sguazzando tra la melma scivolosa impregnata di sangue videro che c'erano dei bambini attaccati al seno delle madri o che piangevano disperatamente accanto alle donne e riuscirono a portarne fuori undici. Andreotta tirò fuori il primo bambino e lo mise nelle braccia di Colburn. Ci vollero più viaggi per portare i superstiti all'ospedale militare. Verso le 23 Thompson tornò alla base e informò le autorità militari degli Stati Uniti sulla strage di My Lai che nel suo rapportò definì eccidio. A due anni esatti da allora le alte sfere dell'esercito incriminarono il tenente William Calley per aver nascosto le informazioni legate ai fatti. Calley, che si era difeso dicendo di aver eseguito solo gli ordini, fu condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Ma già il giorno dopo la sentenza l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon gli concesse il beneficio dei domiciliari.
Tre anni e mezzo dopo Calley ottenne la libertà completa. Ci sarebbe voluto molto tempo prima che si arrivasse a convocare una conferenza stampa durante la quale il criminale di guerra (ma non l'unico) chiese platealmente perdono per ripulirsi un po' la reputazione.
Cao era solo una bambina il 16 marzo 1968 e non sapeva chi fosse Calley e se anche lo avesse saputo non le sarebbe parso giusto che gli altri colpevoli non fossero stati incriminati. Di quel giorno Cao ricorda solo gli uomini che la presero in braccio per portarla sull'elicottero. Cong Hu non lavora più ma fino all'anno scorso era direttore del My Lai Massacre Museum, Anche lui era piccolo il giorno della strage e certo non avrebbe saputo come difendersi dagli assassini armati. Non ricorda molto la gente e le case di My Lai che non esistono più. Sa di essere vivo grazie all'intervento di tre americani e è molto felice di aver incontrato Hugh Thompson. Non riesce a credere che in America non sia considerato un eroe. E che addirittura ricevette messaggi di odio e minacce di morte per aver salvato piccoli vietnamiti. Cong Hu si meraviglia anche per la condanna clemente inflitta all'assassino di sua madre e di due suoi fratelli anche perchè in fondo fu l'unica. A Colburn e Thompson, a quasi trenta anni dalla strage fu conferita una medaglia per aver fermato un massacro di civili. Entrambi gli ufficiali erano tornati molte volte in Vietnam e incontrato i piccoli diventati uomini. La stessa medaglia è andata ad Andreotta. Ma per lui era tardi. Un mese dopo My Lai era rimasto ucciso in uno scontro a fuoco. Non aveva voluto quella guerra ma era stato costretto dalla leva obbligatoria a parteciparvi suo malgrado.
William Calley avrebbe desiderato rendersi invisibile dopo la guerra e magari tornare nella comoda casa di famiglia nella nativa Miami alla ricerca di una collocazione senza dare troppo nell'occhio. Basso di statura e rozzo di modo in città non aveva mai goduto di grande popolarità con le ragazze e, dopo My Lai, le sue quotazioni erano al minimo storico. Gli sarebbe piaciuto far perdere le proprie tracce accontentandosi di frequentare donne a pagamento.
Ma anche chi ha un ego smisurato e nessun talento speciale deve piegarsi davanti al volere della Corte Marziale. In gioventù William Calley aveva fatto il fattorino e il venditore porta-a-porta. L'esercito lo aveva rifiutato per via della statura troppo bassa ma nel 1967 grazie ai buoni uffici del padre, riuscì ad arruolarsi in fanteria.
I suoi modi altezzosi lo avevano reso da subito odioso ai commilitoni e ai superiori. Nel 1968, con in atto una guerra persa in partenza, non si poteva guardare troppo per il sottile. Dopo otto settimane di formazione Calley fu spedito nel sud-est asiatico. Con un cappello più alto rispetto a quanto previsto dal regolamento per sopperire alla bassa statura e una enfasi esagerata nel dare ordini sembrava la caricatura di Hitler resa celebre dal “Dittatore” magistralmente interpretato da Charlie Chaplin.
 Calley era in Vietnam da un anno quando ordinò al suo plotone di massacrare tutti i civili presenti a My Lai la mattina del 16 marzo 1968. Solo nel dicembre del 1969, con la pubblicazione di un'agghiacciante foto scattata pubblicata sul Washington Post la strage divenne dominio pubblico.
Calley era in Vietnam da un anno quando ordinò al suo plotone di massacrare tutti i civili presenti a My Lai la mattina del 16 marzo 1968. Solo nel dicembre del 1969, con la pubblicazione di un'agghiacciante foto scattata pubblicata sul Washington Post la strage divenne dominio pubblico.
Alcuni soldati americani avevano già tentato di denunciare i “massacri personali” messi in atto da Calley e da altri ufficiali senza essere ascoltati. Accusato di omicidio premeditato Calley fu processato da un tribunale militare a Fort Benning, in Georgia, e condannato all'ergastolo. Era stato chiamato a testimoniare anche Hugh Thompson.
Calley si era difeso davanti ai giudici dicendo di aver fatto solo il suo dovere. A rivelare la storia di My Lay era stato il giornalista Sy Hersh che in seguito sarebbe stato oggetto di indagine da parte del servizi segreti. Ma in America molti s'indignarono per una condanna ritenuta troppo dura. Per la verità solo un anno dopo l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon risolse la questione assegnando Calley agli arresti domiciliari. Se la Casa Bianca era stata clemente altrettanto lo furono i tribunali militari che ridussero la condanna a 20 anni.
Tra rinvii, incertezze e voglia di oblio si arrivò al 1974 e Calley fu libero su cauzione. L'esercito non l'avrebbe certamente rivoluto e in Florida sarebbe stato presso a calci così rimase in Georgia dove invece la gente, almeno secondo la rivista Time, lo considerava un eroe.
Si dice che il destino abbia una sua logica. Calley era arrivato in Georgia scortato da una squadra militare e in carcere parecchie donne lo avevano sostenuto con lettere affettuose. Tra queste c'era la giovane figlia di un prestigioso di gioiellerie di Columbus. Qualcuno ha detto che in America più vai a nord più scopri il sud e in effetti “Rusty”, come Calley veniva chiamato da piccolo, a Columbus veniva visto come un soldato inesperto ed erano stati gli odiosi pacifisti a dipingerlo come un mostro. E Hugh Thompson aveva sbagliato a denunciarlo distruggendogli il futuro. Ad ogni modo Calley in Georgia conobbe Penny Vick , la figlia del gioielliere, che sposò con una sontuosa cerimonia allietata da un baritono.
La coppia si stabilì a Columbus, una città di circa duecentomila abitanti dall'economia consolidata poco distante da Fort Benning. Tra monili preziosi l'ex-luogotenente autore di un massacro storico viveva tranquillo fino a quando in Vietnam qualcuno lo riconobbe e lo invito a venire nel paese asiatico pronto a concedergli il perdono. Purtroppo Calley riteneva di non avere nessuna colpa da espiare e nessun desiderio di fare pace con i vietnamiti. Era quasi impossibile collegare all'epoca (1989) gli eventi raccapriccianti di My Lai con un commerciante prospero e tranquillo se non per chi aveva conosciuto la sofferenza di quei giorni lontani.
Calley era riuscito a diventare una figura rispettata e non aveva nessuna intenzione di mettersi in luce. Aveva trovato una moglie devota, possedeva una casa imponente, un'azienda in attivo ed era iscritto a tutti i club giusti. In garage aveva due Mercedes e un Rolex Mariner al polso. Voleva rimanere nell'anonimato a tutti i costi. A meno che non ci fosse qualcuno disposto a offrire una cifra adeguata. Ormai alcuni dei soldati di My Lay erano morti senza un tetto e col fegato bruciato dall'alcol. Altri si erano sparati e i pochi eroi come Thompson dimessi dall'esercito.
 Lui era stato più fortunato ma solo per migliaia di dollaro avrebbe rilasciato un'intervista. Finalmente fu trovato un giornalista disposto a combinare un incontro con Calley nella hall di un grande albergo. I patti prevedevano un assegno di venticinquemila dollari in cambio di una versione della storia di My Lai. Maa all'appuntamento i venticinque mila dollari non c'erano e Calley fece dietro front e se ne andò senza dire una parola....
Lui era stato più fortunato ma solo per migliaia di dollaro avrebbe rilasciato un'intervista. Finalmente fu trovato un giornalista disposto a combinare un incontro con Calley nella hall di un grande albergo. I patti prevedevano un assegno di venticinquemila dollari in cambio di una versione della storia di My Lai. Maa all'appuntamento i venticinque mila dollari non c'erano e Calley fece dietro front e se ne andò senza dire una parola....
Nel 2004 la moglie di Calley chiese il divorzio. Penny Vick gli diede una buona uscite di duecentomila dollari e un uccello di porcellana al quale il veterano era affezionato. Nel 2009 l'età avanzava e i soldi diminuivano. I giornalisti non erano più molto interessati a eventuali interviste. Nel 2006 Hugh Thompson era morto senza fanfare mediatiche. Calley aveva problemi di prostata ma in qualche modo sperava di guadagnare offrendo un perdono plateale. La confessione fu organizzata al Kiwanis Greater Club di Columbus. Calley disse che non c'era mai stato un giorno senza che avesse provato rimorso per quello che accadde a My Lai. Ma non ci fu alcun cambiamento del cuore dissero i presenti. Ovviamente Calley aveva ripetuto che aveva solo eseguito gli ordini. Per i vietnamiti quel perdono non vale nulla. Per la loro cultura dovrebbe andare in Vietnam e pregare gli spiriti sul luogo della strage. Difficilmente Calley riuscirebbe mai a fare quel viaggio. Se anche vivrà a lungo dovrà tenersi il rimorso. A meno che il disagio non valga la candela.
