- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Se le tendenze climatiche in atto saranno confermate, i sistemi ecologici, forestali e ambientali naturali del Mediterraneo si sposteranno verso l’Europa centro-occidentale e settentrionale, trasformandolo in una regione arida e più vulnerabile alla siccità. D’altronde, secondo quanto riporta il dossier “Per un’ecologia umana integrale. Salvare il pianeta, salvare i poveri, salvare l’umanità”, redatto dalla Caritas, analizzando i dati sulle temperature, si nota che la l’Italia si sta scaldando più velocemente della media globale e di altre terre emerse del pianeta.
Al punto che, nel 2014, è stato raggiunto un nuovo record, pari a 1,45 gradi centigradi, rispetto al trentennio 1971-2001. E se sale la temperatura aumenta pure l’incidenza dei fenomeni meteorologici estremi: nubifragi, alluvioni, distruzioni, morti e danni materiali.
Le precipitazioni molto intense sono state causa immediata di disastri su territori gestiti a lungo in maniera approssimativa e centrata sul tornaconto economico diretto a beneficio di pochi: Genova, Modena, Senigallia e Chiavari, gli esempi più eclatanti dove la produzione agricola, nel 2014, è stata duramente colpita con i produttori di olio d’oliva, miele e castagne in ginocchio.
Non solo si intensificano i fenomeni temporaleschi ma si modifica anche la distribuzione delle precipitazioni, provocando, per effetto dell’aumento dell’evapotraspirazione e dei prelievi idrici, una diminuzione, nelle prossime decadi, delle risorse idriche. E laddove già sussistono condizioni di stress idrici, vedi il Sud della penisola, il cambiamento avrà profonde ripercussioni, non solo sull’agricoltura, ma pure sul turismo, la produzione industriale, l’urbanizzazione e la salute.
La diffusione smodata di agenti patogeni, collegata al cambiamento climatico, peserà sul settore agro-forestale; l’innalzamento del livello del mare e l’acuirsi delle mareggiate aggraveranno i problemi già esistenti negli ambienti marini, tipo quelli di erosione delle zone costiere basse e sabbiose, le infiltrazioni di acqua salata nelle falde di acqua dolce e le modificazioni nella biodiversità delle zone umide. Per non parlare dei danni sul patrimonio storico, culturale e artistico come dimostrano i fatti di Ravenna, Ferrara e Venezia. Il cambiamento climatico, in tutte le sue facce, si interseca inesorabilmente con il fattore economico così tanto direttamente da costringere, dal 2008 al 2014, oltre centocinquantasette milioni di persone a spostarsi per eventi meteorologici estremi. Tempeste e alluvioni in primis, rappresentando l’85 per cento delle cause, seguite dai terremoti.
Il cambiamento climatico, in tutte le sue facce, si interseca inesorabilmente con il fattore economico così tanto direttamente da costringere, dal 2008 al 2014, oltre centocinquantasette milioni di persone a spostarsi per eventi meteorologici estremi. Tempeste e alluvioni in primis, rappresentando l’85 per cento delle cause, seguite dai terremoti.
Solo nel 2015 sono stati oltre diciannove milioni gli sfollati per disastri naturali in centotredici Paesi. Per sfuggire anche ai conflitti interni (conseguenti) per il controllo delle risorse, vedi l’uso del suolo e la gestione delle risorse idriche, per l’accaparramento delle terre e la cementificazione selvaggia.
Di questo passo, se già il ventunesimo si può definire il secolo dei ‘rifugiati ambientali’, nel 2050, gli esperti stimano che se ne conterà un miliardo. A causa di uno sfruttamento antropocentrico generatore di ingiustizia climatica.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
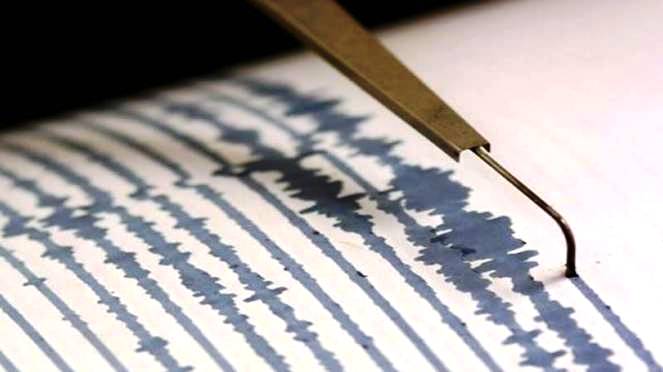 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Un centinaio di terremoti all’anno, percepibili ma non distruttivi. Cosi dice il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel dossier elaborato qualche giorno prima del sisma che ha colpito le Marche e il Lazio, “Nota del rischio sismico in Italia: stima del numero di abitazioni interessate (e popolazione di riferimento) e costi per la loro messa in sicurezza”.
In media, c’è un sisma ogni cinque anni di quelli di grave e media entità. Il che espone al rischio oltre ventuno milioni di persone di cui tre milioni abitanti in aree del territorio italiano di massima esposizione. Altri diciannove milioni risiedono in zone non propriamente soggette al rischio sismico di grave portata ma nemmeno troppo sicure: prova ne siano i comuni emiliani, appartenenti a questa categoria, colpiti dal terremoto nel maggio del 2012. Certamente più preoccupanti le posizioni della Calabria, della Basilicata e della Sicilia.
Prendendo per evento di media intensità l’impatto del terremoto che ha devastato L’Aquila, i costi complessivi per la messa in sicurezza del patrimonio abitativo italiano ammonterebbero a circa novantatre miliardi di euro. Intervenendo su circa dodici milioni di immobili che dovrebbero essere destinatari di opere di risanamento e messa in sicurezza statica, coinvolgendo suppergiù ventitre milioni di cittadini.
Che abitano in case particolarmente vetuste: circa quindici milioni di abitazioni, pari a più del 50 per cento del totale, sono state edificate prima del 1974, in completa assenza, quindi, di qualsivoglia normativa antisismica. Per non parlare di quei quattro milioni di immobili costruiti prima del 1920 e altri quasi tre milioni ante 1945 e, purtroppo, versanti in pessimo stato di conservazione.
In Molise, Piemonte e Liguria, il quadro è più critico che altrove, considerando che un quarto delle abitazioni conta oltre cento anni di vita; sono solo il 43,8 per cento quelle antecedenti il 1961 che versa in ottimo stato, mentre fra quelle costruite dopo il 2000 sono solo duecentomila quelle interessate a investimenti per la messa in sicurezza. Dal 1968 al 2014, sono stati spesi più di centoventuno miliardi di euro per la ricostruzione: i fondi destinati all’Irpinia per il terremoto del 1980 saranno erogati fino al 2023, quelli per la Valle del Belice fino al 2028, fino al 2023 quelli per le zone del Molise e della Puglia colpite nel 2002, fino al 2024 per Marche e Umbria danneggiate nel 1997e fino al 2029 per l’Abruzzo.
Dal 1968 al 2014, sono stati spesi più di centoventuno miliardi di euro per la ricostruzione: i fondi destinati all’Irpinia per il terremoto del 1980 saranno erogati fino al 2023, quelli per la Valle del Belice fino al 2028, fino al 2023 quelli per le zone del Molise e della Puglia colpite nel 2002, fino al 2024 per Marche e Umbria danneggiate nel 1997e fino al 2029 per l’Abruzzo.
Sarebbe opportuno, fanno sapere dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili, “un piano di investimenti pubblici mirati per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture esistenti e l’uso intelligente della leva fiscale con l’estensione del bonus antisismico del 65 per cento per i lavori di prevenzione e messa in sicurezza statica, indipendentemente dalle condizioni poste ora dalla legge, permetterebbe di salvaguardare le vite umane e tutelare il nostro fragile territorio”. Anche perché il costo della mancata prevenzione è altissimo, circa tre miliardi e mezzo di euro all’anno. E troppe vite umane.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di redazione
di redazione
Il caso è di quelli che riempiono le pagine giusto di Ferragosto: la vignetta incriminata di Riccardo Mannelli pubblicata su Il fatto quotidiano il 10 agosto che ritrae la procace Ministro Boschi (anche Ministro è sessista, sarebbe il caso di dire Ministra secondo la Crusca e la fuffa del bon ton), in un'evidente caricatura. La satira questo è: caricare e distorcere il reale senza freni né limiti per poterlo irridere, dissacrare, coglierne nell'estremizzazione letteraria o figurativa i limiti e gli orrori. E' un genere letterario con un suo codice di regole e di non regole. Bisogna conoscerlo e tornare ai classici. A scuola insomma.
Eppure la vignetta scomoda addirittura l'accusa di sessismo, sebbene riproducesse proprio una foto della Boschi. In primis c'è la Presidente Boldrini che da un po' ha a cura la concordanza dei nomi al femminile come vaccino per l'eguaglianza di genere. Il linguaggio ha un suo potere evocativo non c'è dubbio, ma pare che la semantica sia diventata l'unica arma per l'eguaglianza dei diritti delle donne. Tanto che solo in questo Paese fa titolo la rivoluzione del dire sindaca o assessora e la cronaca delle donne uccise dagli ex con numeri da mattanza. Beffarda sincronia del “Paese delle meraviglie” direbbe Crozza.
Molte le proteste di parlamentari del Pd. La vignetta sarebbe offensiva verso il Ministro. Non si capisce se per le cosce scoperte e non troppo magre o per il titolo sullo “stato delle cos(c)e”. Purtroppo per i suoi detrattori Mannelli con questa vignetta riesce davvero a fare un capolavoro di satira: a ricordare tutte le gaffe istituzionali del Ministro alla prova su fronti istituzionali di supremo valore, a ridicolizzarne una certa inadeguatezza (dai partigiani fino al SI al referendum) e lo fa estremizzando il dato incontrovertibile del Ministro: la sua beltà. Che non è certo una colpa s'intende, anche quando l'avvenenza viene esibita con l'intento di catturare attenzione e consenso.
Se si accetta il principio di mettere dei limiti alla satira forse bisogna rivedere tutte quelle posizioni filosofiche liberali e laiche su cui tanta sinistra si è battuta. Torniamo ai giornalisti di Charlie Ebdo e alla loro satira per scoprire che quella è legittima e questa no? Condanniamo, per coerenza, il lavoro di chi ritrae e per giunta lo fa in modo forte, sacrilego e irreverente, Allah. E' il Dio di milioni di persone, della loro fede e della loro morale. Se accettiamo di dare dei limiti alla satira, non possiamo accettarla satira su Dio, perché offende il credo e la vita di popoli e anche di Stati confessionali creandoci pure, in aggiunta, qualche problemino di sicurezza. Potremmo imboccare questa strada e tornare allo Statuto Albertino e al vilipendio della religione.
Se accettiamo di dare dei limiti alla satira, non possiamo accettarla satira su Dio, perché offende il credo e la vita di popoli e anche di Stati confessionali creandoci pure, in aggiunta, qualche problemino di sicurezza. Potremmo imboccare questa strada e tornare allo Statuto Albertino e al vilipendio della religione.
Potremmo proseguire sanzionando giornalisti e vignettisti. Potremmo renderci ancor più ridicoli per la legislazione europea che già ci striglia per come siamo messi sui criteri e i limiti della libertà d'informazione.
La satira, val la pena ricordarlo, non è cronaca. E' commento. E, proprio perché tale, non può avere quei limiti deontologici che la cronaca è obbligata ad avere. Si può discutere della satira sulla morte, sulla malattia e su tutte quelle frontiere delicate della vita umana che muovono dolore e pietà. Tutto fuorchè mobilitare giuristi e Parlamento per due belle, procaci cosce. Non è stato fatto tanto nemmeno per Dio.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giovanni Gnazzi
di Giovanni Gnazzi
Le epurazioni in RAI non sono una novità. In qualche modo l’idea che i ruoli di direzione si avvicendino di per sé non è mai una cattiva notizia, se corrisponde ad un rilancio editoriale o variazioni significative d’impostazione dei palinsesti tali da giustificare una diversa direzione. Purtroppo, alle porte girevoli dei direttori e capi struttura provvedono invece le collocazioni politiche dei consiglieri d’amministrazione.
Nel caso della RAI di Renzi il fenomeno è particolarmente acuito. A maggior ragione dall’aver imposto una gabella agli utenti che consegnerà 400 milioni di Euro annui ad un Consiglio di Amministrazione che ben sa come, dove e per chi impiegarli.
E’ vero, il Premier aveva promesso di cacciare i partiti dalla RAI, ma si era dimenticato di dire che l’occupava lui. Infatti non solo Renzi pone e dispone della RAI a piacimento, ma dimostra una pervicace insofferenza per chiunque non s’inginocchi al suo verbo.
La collocazione di Campo Dell’Orto, la cui competenza in materia televisiva sfugge ai più e risulta comunque inversamente proporzionale al suo faraonico stipendio, risponde alla logica che viene dispiegandosi in questi mesi:conduttori e giornalisti vengono rimossi manu militari ove non arruolatisi per tempo nelle truppe cammellate del "giglio magico" che sostiene Renzi e la sua ministra delle Riforme.
Non è prevista la figura del giornalista, che viene sostituita con quella del propagandista. Per carità, non è che i leoni abbondino nelle redazioni, ma la caccia grossa non è certamente uno stimolo a camminare in autonomia. Non si vuol certo sostenere che la direzione del TG3 a Bianca Berlinguer sia lo spartiacque della democrazia, né che l’Italia stia con il fiato sospeso per le sue magnifiche e progressive sorti, ma che la motivazione della sua rimozione si debba ad una “anzianità” di direzione, somiglia ad una presa per i fondelli vera e propria, nel perfetto stile dell’inquilino di Palazzo Chigi. Si deve invece alla necessità di liberarsi di una giornalista non reniana, di accertata autorevolezza e cognome importante per la base del PD.
Non solo giornalisti, il cannone spara al alzo zero. L’ultima bordata è toccata ai comici come la Fornario, cui è stato ordinato di cessare le imitazioni di Renzi, o al programma del climatologo Mercalli, chiuso perché colpevole di aver affrontato temi quali la legge sul consumo dei suoli, le grandi opere o le trivelle in forma sgradita al Premier. Certo non è questione di budget, visto che il climatologo guadagnava 57.000 euro lordi all’anno, poco più di 30.000 netti.
Assunzioni e rimozioni in RAI vengono effettuate con la disinvoltura di un Ceaucescu qualunque, mentre di progetto editoriale non si parla, eccezion fatta che per la destinazione della massima quota di spazio informativo alla propaganda del Premier. Che si sente giustamente accerchiato, dal momento che le sue politiche hanno avuto come nemico giurato lavoratori e sindacati, studenti e pensionati, calamitando così un’avversione generalizzata ormai non più occultabile.
E’ tendenza inevitabile, per le mezze figure, quella di edificare bunker quando si teme il divenire dello scontro politico. In questo senso le mani di Renzi su tutto ciò che si pubblica, compreso quanto di spettanza del Patto del Nazareno (vedi avvicendamento di Feltri e sorti di Belpietro) sono da due anni rumorosamente operose.
 Ma quelli più avvertiti, i cavalli di razza come li chiamava l’aretino Fanfani, sanno come al giorno d’oggi controllare militarmente l’informazione serve relativamente rispetto al passato; sono invece le politiche effettuate, i risultati ottenuti, le alleanza costruite, a rendere una proposta politica e il suo leader obiettivo impossibile o soggetto da tiro al bersaglio.
Ma quelli più avvertiti, i cavalli di razza come li chiamava l’aretino Fanfani, sanno come al giorno d’oggi controllare militarmente l’informazione serve relativamente rispetto al passato; sono invece le politiche effettuate, i risultati ottenuti, le alleanza costruite, a rendere una proposta politica e il suo leader obiettivo impossibile o soggetto da tiro al bersaglio.
Ai fini del referendum costituzionale non basterà blindare i media di regime o cacciare i dubbiosi, pompare le parole e rimuovere i fatti. Serve a poco rafforzare le truppe, schierare ogni arma, assumere su di sé il comando assoluto. Nell’epoca del rifiuto, del disincanto, dello smascheramento e dell’informazione trasversale, le angherie, come le bugie, hanno le gambe corte.
Ormai, come nel meteo, quel che conta è ciò che si avverte. E quello che spira, per Renzi, è un vento gelido. Novembre si avvicina e, con lui, il Generale Inverno. Che si presenterà con una scheda referendaria con inciso un NO e, in allegato, la data di scadenza per l’arroganza.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tania Careddu
di Tania Careddu
Sono i più ricchi del mondo, contribuiscono per metà all’economia globale ma ospitano meno del 9 per cento dei rifugiati e richiedenti asilo. Che, invece, trovano riparo, assistenza sanitaria, lavoro e istruzione nei Paesi più poveri del pianeta, minandone la già precaria stabilità interna. Giordania, Turchia, Territori Occupati Palestinesi, Pakistan, Libano e Sud Africa, che contano meno del 2 per cento sull’economia globale, si fanno carico di circa dodici milioni di migranti, circa la metà del totale.
Di contro, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Cina e Giappone, tutte insieme, ne ospitano suppergiù un milione e quattrocento mila. Cavandosela piuttosto, nel 2015, con la donazione a favore dell’UNHCR di una somma pari più o meno a due miliardi di dollari, ma continuando a esternalizzare il controllo delle frontiere.
Non solo un uso distorto degli aiuti, dunque, ma anche incoerente vista la fornitura di armi (che ha provocato un aumento del 10 per cento nella vendita globale), da parte di Stati Uniti e Regno Unito soprattutto, ai Paesi che guidano coalizioni belliche, vedi Arabia Saudita, responsabili delle crisi umanitarie e della fuga delle popolazioni. Di più: spesso, gli accordi politici fra le grandi potenze contravvengono allo spirito della Convenzione sui rifugiati del 1951. Tanto per citarne uno, a marzo quello fra Unione Europea e Turchia, che scambia rifugiati con concessioni politiche ed esternalizza alla Turchia il controllo dei propri confini, per l’Europa ha scatenato un effetto domino.
Perchè se l’Europa può respingere i siriani, il Kenya, per esempio, può fare lo stesso con i somali. Senza dimenticare la solerzia dei governi europei a collaborare con i regimi del Sudan e dell’Eritrea per fermare i flussi migratori, ricorrendo alle ‘leve necessarie’, secondo quanto emerso dal Consiglio dell’Unione Europea riunitosi lo scorso giugno, e riportato nel dossier “La misera accoglienza dei ricchi del mondo”, redatto da Oxfam. Rispetto ai palestinesi, poi, degli oltre cinque milioni di rifugiati, le sei potenze mondiali ne accolgono solo due milioni.
Una sproporzione che fa il paio con le opportunità di reinsediamento, cioè la pratica che consentirebbe ai rifugiati di ricostruirsi una vita: nel 2015, il totale di questi era di circa cinquantasette mila persone, vale a dire meno del 6 per cento di coloro che avrebbero avuto bisogno di ricorrere a questa procedura. E però, ciò che fanno i governi non sempre trova corrispondenza nell’opinione della popolazione: stando a quanto riportato da una recente ricerca di Amnesty International, dalla Cina agli Stati Uniti, la maggior parte delle persone è favorevole all’accoglienza dei profughi che scappano da guerre e persecuzioni e chiede interventi più cospicui ai propri rappresentanti politici.
E però, ciò che fanno i governi non sempre trova corrispondenza nell’opinione della popolazione: stando a quanto riportato da una recente ricerca di Amnesty International, dalla Cina agli Stati Uniti, la maggior parte delle persone è favorevole all’accoglienza dei profughi che scappano da guerre e persecuzioni e chiede interventi più cospicui ai propri rappresentanti politici.
E nemmeno l’Italia eccelle: quest’anno ne ha accolto solo lo 0,6 per cento del totale, quasi centotrentacinque mila rispetto agli oltre settecentotrentacinque mila della Germania. E invece “sarebbe prioritario - afferma la presidente di Oxfam Italia, Maurizia Iachino - che i governi con economie più forti si impegnassero a portare cambiamenti sostanziali nei Paesi in via di sviluppo, dove la maggior parte dei profughi di tutto il mondo sta vivendo in una provvisorietà senza prospettive”. Che paese, l’America!, scriveva Frank McCourt. E gli altri?
