- Dettagli
- Scritto da Michele Paris
 Mentre il governo del Regno Unito è ufficialmente impegnato nello sforzo epocale di difendere la “democrazia” ucraina contro l’aggressione del dittatore Vladimir Putin, un tribunale di Londra ha dato il via libera formale all’estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. L’ultima parola su quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una condanna a morte per il giornalista australiano spetterà a Priti Patel, ministro degli Interni dell’esecutivo autoproclamatosi paladino dei diritti democratici in Ucraina. Un’estrema possibilità di appello resta ora ai legali di Assange, ma le speranze non sono maggiori di quelle nutrite durante tutti i processi-farsa di questi anni. La lunga detenzione illegale, le torture e la puntuale negazione dei suoi diritti fondamentali fanno del caso Assange un esempio macroscopico sia della duplicità della retorica democratica anglo-americana sia della deriva repressiva e autoritaria di quei governi che inveiscono con cadenza quotidiana contro la barbarie russa.
Mentre il governo del Regno Unito è ufficialmente impegnato nello sforzo epocale di difendere la “democrazia” ucraina contro l’aggressione del dittatore Vladimir Putin, un tribunale di Londra ha dato il via libera formale all’estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. L’ultima parola su quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una condanna a morte per il giornalista australiano spetterà a Priti Patel, ministro degli Interni dell’esecutivo autoproclamatosi paladino dei diritti democratici in Ucraina. Un’estrema possibilità di appello resta ora ai legali di Assange, ma le speranze non sono maggiori di quelle nutrite durante tutti i processi-farsa di questi anni. La lunga detenzione illegale, le torture e la puntuale negazione dei suoi diritti fondamentali fanno del caso Assange un esempio macroscopico sia della duplicità della retorica democratica anglo-americana sia della deriva repressiva e autoritaria di quei governi che inveiscono con cadenza quotidiana contro la barbarie russa.
La richiesta di estradizione era stata presentata alla giustizia britannica dopo il rapimento di Assange dalla sede dell’ambasciata ecuadoriana nell’aprile del 2019 per essere trasferito nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. L’aspetto più incredibile di tutto il procedimento che ne è seguito fino alla decisione di mercoledì della corte di Westminster è che la sorte di Assange sarà alla fine quella prevista fin dall’inizio, nonostante in questi tre anni siano diventati di dominio pubblico, grazie soprattutto alla stampa indipendente, tutti i dettagli degli abusi e della campagna persecutoria orchestrata nei suoi confronti.
Assange aveva ottenuto un verdetto relativamente favorevole nel gennaio del 2021, quando la stessa corte che ha deliberato mercoledì aveva respinto l’estradizione basandosi su considerazioni relative al suo stato di salute mentale. Il soggiorno in un carcere americano con l’applicazione di misure ultra-restrittive avrebbe cioè fatto aumentare sensibilmente il rischio di suicidio. Gli sviluppi successivi hanno avuto però tutti i contorni di una messa in scena, nella quale i governi di Washington e Londra si sono coordinati per arrivare al ribaltamento della sentenza contraria agli Stati Uniti.
Il dipartimento di Giustizia USA aveva “rassicurato” che Assange non sarebbe stato sottoposto alle cosiddette “Misure Amministrative Speciali” (SAMs), ovvero al carcere duro, una volta detenuto in territorio americano. Il processo di appello aveva visto sfilare un lungo elenco di autorevoli testimoni della difesa che, in qualsiasi tribunale democratico, avrebbero portato all’immediata archiviazione del caso Assange. Nel corso dei dibattimenti erano anche emerse, da un lato, le pessime condizioni detentive del fondatore di WikiLeaks e, dall’altro, la gigantesca cospirazione ai suoi danni organizzata dai governi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Ecuador e Svezia, nonché dai rispettivi servizi segreti.
L’Alta Corte britannica aveva così cassato la sentenza contraria all’estradizione, rimandando il caso al tribunale di Westminster. Le “rassicurazioni” americane su cui si è basato tutto il procedimento di appello erano sembrate fin dall’inizio inconsistenti. Oltre al fatto che tutti gli organi del governo americano violano regolarmente gli impegni presi in qualsiasi ambito, anche a livello formale la garanzia che Assange non venga sottoposto alle “Misure Amministrative Speciali” è estremamente esile. Infatti, questi provvedimenti potranno essere applicati se Assange dovesse tenere un comportamento tale da giustificarne l’adozione. È evidente quindi che ci si trovi in presenza di una questione interpretabile a piacimento da Washington e una circostanza qualsiasi, come un “tweet” o una semplice dichiarazione pubblica di Assange, farebbe scattare il regime di detenzione più rigido.
C’è un altro elemento che la giustizia britannica ha scartato completamente e su cui, come sembra, i legali di Assange cercheranno di insistere nell’ultimo appello contro l’estradizione. La decisione dell’Alta Corte di rovesciare il verdetto favorevole ad Assange perché le sue condizioni mentali, dopo le rassicurazioni USA, non erano più incompatibili con la detenzione in America era stata presa il 10 dicembre 2021, cioè poco dopo che il 50enne giornalista era stato colpito da un “mini-ictus”. Questa notizia era trapelata solo dopo la sentenza dell’Alta Corte e, secondo molti esperti di diritto, le nuove condizioni di Assange non sarebbero state tenute in considerazione, visto che la possibile incompatibilità con il sistema detentivo americano era stata valutata solo per l’aspetto psicologico e non per quello fisico.
 Nel nuovo processo-farsa con esito già scritto che Assange dovrà sostenere una volta negli Stati Uniti si prospetta una condanna fino a un massimo di 175 anni. Le accuse sono state formulate in base all’ultra-reazionario “Espionage Act” del 1917, assurdamente applicato in questo caso a un giornalista, la cui attività risulta protetta anche dalla Costituzione USA, oltretutto operante al di fuori della giurisdizione americana. Secondo il dipartimento di Giustizia, Assange avrebbe cospirato nell’hackeraggio dei sistemi informatici del Pentagono per ottenere documenti riservati.
Nel nuovo processo-farsa con esito già scritto che Assange dovrà sostenere una volta negli Stati Uniti si prospetta una condanna fino a un massimo di 175 anni. Le accuse sono state formulate in base all’ultra-reazionario “Espionage Act” del 1917, assurdamente applicato in questo caso a un giornalista, la cui attività risulta protetta anche dalla Costituzione USA, oltretutto operante al di fuori della giurisdizione americana. Secondo il dipartimento di Giustizia, Assange avrebbe cospirato nell’hackeraggio dei sistemi informatici del Pentagono per ottenere documenti riservati.
WikiLeaks, tuttavia, ha semplicemente agito da testata giornalistica ricevendo il materiale sui crimini USA da fonti di cui, spesso, non conosceva nemmeno l’identità. In merito a queste accuse, inoltre, qualche tempo fa c’era stata una confessione pubblica del presunto “co-cospiratore” nei crimini di Assange, l’islandese Sigurdur Thordarson, nella quale smentiva categoricamente di avere subito pressioni dal numero uno di WikiLeaks per penetrare i computer del Pentagono. Anche se le accuse americane si basavano in larga misura sulla testimonianza di Thordarson, noto informatore dell’FBI con varie condanne sulle spalle, i nuovi sviluppi favorevoli ad Assange non sono mai stati presi in considerazione dai tribunali britannici.
Come detto all’inizio, toccherà ora al ministro degli Interni di Londra, Priti Patel, mettere la firma sul provvedimento di estradizione. I legali di Assange potrebbero sottoporre una richiesta di sospensione alla stessa Patel o presentare un nuovo appello all’Alta Corte dopo che il ministro avrà dato il via libera al trasferimento negli USA, come appare ormai certo. Come già rilevato per un giudice coinvolto nei procedimenti di questi anni, anche per il membro del governo Johnson che decreterà la sorte di Assange sono documentati preoccupanti conflitti di interesse che, anche tralasciando il merito dei processi-farsa subiti finora, dovrebbero quanto meno sollevare sospetti sulla legittimità della sua decisione.
Secondo documenti esaminati dal sito Declassified UK, Priti Patel per alcuni anni aveva ricoperto l’incarico di “consigliere” della Henry Jackson Society (HJS), un “think tank” londinese con legami documentati alla CIA e molte prese di posizione pubbliche contro Assange e WikiLeaks. Nella lunga analisi del ruolo della HJS, pubblicata a fine marzo da Declassified UK, emergevano alcuni elementi che rendono il ministro degli Interni britannico ancora meno neutrale nel caso Assange di quanto già non lo sia in qualità di esponente di un governo che ha cospirato con Washington per la sua eliminazione.
La società di cui la Patel ha fatto parte includeva per cominciare anche Lord Arbuthnot, membro del Partito Conservatore e marito della giudice Emma Arbuthnot, incredibilmente responsabile di due sentenze nel caso Assange. Negli anni scorsi, la HJS aveva poi ospitato conferenze di alcuni direttori della CIA e nell’estate del 2020 dell’ex numero uno dell’agenzia di Langley, l’allora segretario di Stato Mike Pompeo, noto per avere definito WikiLeaks “un servizio di intelligence ostile” agli Stati Uniti. Ancora più compromettenti sono state le dichiarazioni contro Assange e WikiLeaks di numerosi esponenti di spicco della Henry Jackson Society, come quella particolarmente minacciosa del 2011 dell’allora “direttore associato”, Douglas Murray.
La feroce persecuzione contro Assange ad opera delle “democrazie” anglo-sassoni è direttamente collegata alla pubblicazione su WikiLeaks delle prove dei crimini americani in Iraq e in Afghanistan, così come dell’utilizzo da parte della CIA e della NSA di strumenti di sorveglianza da regime totalitario. La liquidazione di Assange è diventata inoltre ancora più necessaria con l’esplosione del conflitto in Ucraina e il lancio di una massiccia campagna di disinformazione in Occidente. Se uno degli obiettivi è quello di fare di Putin un criminale di guerra agli occhi dell’opinione pubblica, non è tollerabile che un giornalista possa esercitare liberamente la propria professione mettendo a nudo i crimini di gran lunga più gravi di cui si sono macchiati gli Stati Uniti e i loro alleati.
 In questo senso, il tempismo della decisione finale di estradare Julian Assange appare emblematico, dal momento che coincide con la durissima repressione di qualsiasi voce di opposizione operata proprio dal regime ucraino. Di questi giorni è ad esempio la notizia del probabile assassinio per mano degli uomini del battaglione neo-nazista Azov del giornalista cileno-americano, Gonzalo Lira, impegnato a raccontare sul campo e in totale libertà la guerra in corso. Nel silenzio delle “democrazie” occidentali, sempre mercoledì si è diffusa anche la notizia dell’uccisione a Kherson con una raffica sparata a distanza ravvicinata del blogger “filo-russo” Valery Kuleshov.
In questo senso, il tempismo della decisione finale di estradare Julian Assange appare emblematico, dal momento che coincide con la durissima repressione di qualsiasi voce di opposizione operata proprio dal regime ucraino. Di questi giorni è ad esempio la notizia del probabile assassinio per mano degli uomini del battaglione neo-nazista Azov del giornalista cileno-americano, Gonzalo Lira, impegnato a raccontare sul campo e in totale libertà la guerra in corso. Nel silenzio delle “democrazie” occidentali, sempre mercoledì si è diffusa anche la notizia dell’uccisione a Kherson con una raffica sparata a distanza ravvicinata del blogger “filo-russo” Valery Kuleshov.
L’eliminazione anche fisica di blogger, giornalisti e politici di opposizione da parte di Zelensky e delle milizie neo-naziste appoggiate dall’Occidente ha in fin dei conti lo stesso scopo della persecuzione decennale di Assange: occultare i crimini delle forze “democratiche” e denunciare, con una colossale operazione di propaganda e disinformazione, nemici e rivali non allineati agli interessi dell’impero e dei suoi docili alleati.
- Dettagli
- Scritto da Luis Varese
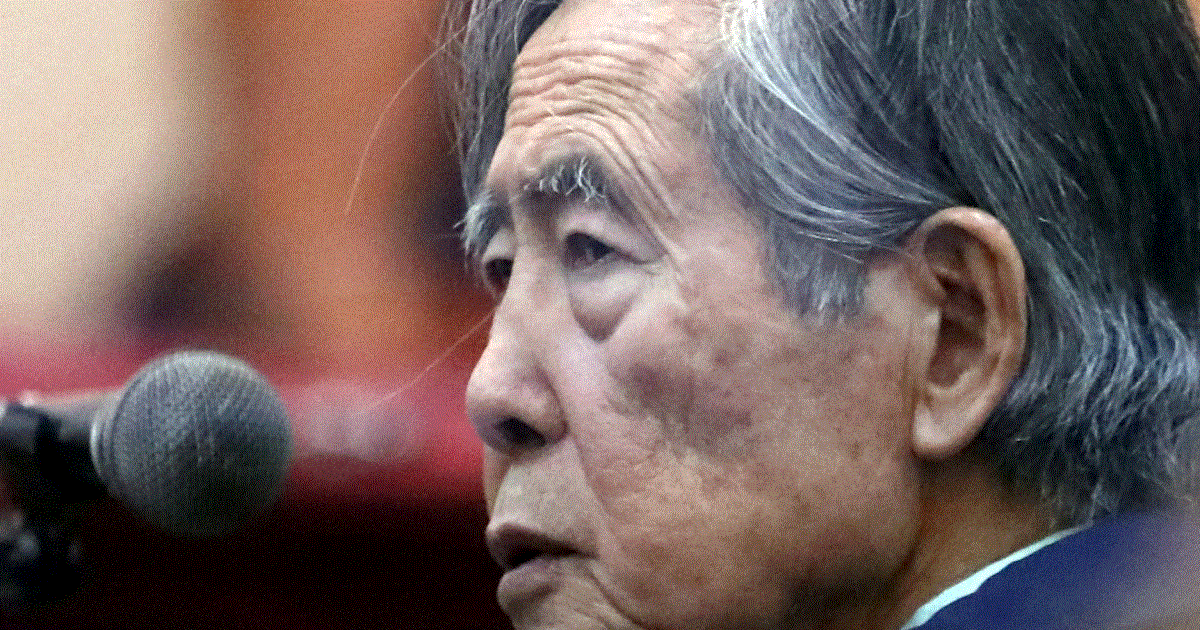 Il perdono è un insulto! È lo slogan che viene gridato nelle strade di Lima e nelle principali città del Perù. In una nuova manovra destabilizzante, il fujimorismo cerca di salvare il boss mafioso dalla prigione d'oro, questa volta usando la Corte Costituzionale.
Il perdono è un insulto! È lo slogan che viene gridato nelle strade di Lima e nelle principali città del Perù. In una nuova manovra destabilizzante, il fujimorismo cerca di salvare il boss mafioso dalla prigione d'oro, questa volta usando la Corte Costituzionale.
Il perdono del criminale Fujimori è un insulto a tutti i peruviani che hanno amore per il proprio Paese. È un insulto alla democrazia così duramente conquistata, un insulto agli eroi delle guerre del Perù, un insulto ai rivoluzionari che hanno dato la vita per una Patria migliore, un insulto ai peruviani mutilati dalla barbarie genocida delle sterilizzazioni di massa. Un insulto a tutta la Nostra America, che ha superato l'era delle dittature condannando i dittatori. Non c'è dimenticanza o perdono, perché il dittatore non se ne pente minimamente.
I crimini contro l'umanità non sono prescritti e non hanno diritto alla grazia. Lo Stato peruviano è firmatario e membro della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo, quindi le sue decisioni sono vincolanti. E già In precedenza, la Corte si era pronunciata contro la grazia all'imputato Alberto Fujimori.
"È necessario che, oltre alla situazione sanitaria della persona condannata, si tenga conto di altri fattori o criteri, come il fatto che una parte considerevole della pena detentiva è stata scontata e che è stata pagata la riparazione civile inflitta alla pena; il comportamento della persona condannata per quanto riguarda il chiarimento della verità; il riconoscimento della gravità dei reati commessi e loro riabilitazione; gli effetti che il loro rilascio anticipato avrebbe a livello sociale e sulle vittime e sulle loro famiglie". Nessuno di essi è stato rispettato dall'ex dittatore.
Non solo non è stato scontato, ma dalla sua prigione ha continuato a dirigere il gruppo mafioso che a volte è guidato da sua figlia Keiko o a volte da suo figlio Kenji. Cioè, non c'è stato un solo atto di riflessione autocritica, o scopo di pentimento. Non vi è alcun riconoscimento della gravità dei crimini perpetrati. Né c'è una decisione di rimpatriare i milioni rubati allo Stato peruviano, il cui importo reale è sconosciuto, tanto meno la riparazione civile che le vittime meritano. Cioè, i tre giudici della Corte costituzionale che hanno votato a favore della grazia hanno deciso, chissà per quale motivo non santo, di perdonare questo dittatore criminale, che ha fatto così tanti danni ai peruviani.
Fujimori non è condannato per processi politici. Fujimori è condannato per crimini contro l'umanità in due casi specifici di omicidio di studenti dell'Universidad de la Cantuta e di cittadini in una casa a Barrios Altos, giustiziato da un gruppo di sterminio chiamato Gruppo Colina, che era sotto il suo comando. Ha altri casi e condanne per corruzione, appropriazione indebita e rapina contro lo Stato peruviano. Uno dei più gravi e che non ha ancora completato il suo processo, è la sterilizzazione forzata di quasi trecentomila donne, da parte dello Stato peruviano attraverso il Ministero della Salute, in una pratica tipica del nazismo, diretta dallo stesso Fujimori.
Il presidente Castillo deve guidare la lotta per un nuovo ordine costituzionale.
Non c'era, infine, nessun posto vacante. Era noto prima dell'inizio della sessione del Congresso, perché l'estrema destra non aveva abbastanza voti. E' stato un trionfo della democrazia e delle fragili istituzioni del Perù. Ciò che è necessario riprendere è il programma iniziale per il quale è stato eletto, almeno sui temi che hanno a che fare con l'agricoltura, il gas e la difesa della Sovranità. Inoltre, oggi è necessaria una ferma dichiarazione del presidente Pedro Castillo contro la corruzione, l'impunità e i crimini contro l'umanità commessi da Fujimori contro il popolo peruviano.
Il presidente Castillo ha una nuova opportunità offerta dalla storia, per aderire alla volontà popolare e consegnare nel Bicentenario un Perù rinnovato con profonde riforme strutturali, indispensabili per la sopravvivenza del Paese che lo ha eletto. Ha l'opportunità di difendere la sovranità nazionale occupandosi delle esigenze dei peruviani e di tutti i fronti che possono essere curati anche da uno Stato il cui potere legislativo non facilita questo compito.
 Bisogna dimostrare a chi lo accusa irresponsabilmente di essere un traditore della Patria, per aver parlato di un'uscita in mare per la Bolivia, che la Patria si difende dalle multinazionali, dai mercanti di salute, da chi sfrutta brutalmente i peruviani nelle miniere, nella pesca e nell'agricoltura. Contro gli irresponsabili dell'estrazione mineraria illegale o contro coloro che trafficano le nostre risorse naturali e soprattutto umane. La Patria si difende pagando le tasse e riscuotendo le tasse per la costruzione e la ricostruzione di scuole e ospedali distrutti proprio dalle vende la patria, che costituiscono la lumpen oligarchy che governa il paese.
Bisogna dimostrare a chi lo accusa irresponsabilmente di essere un traditore della Patria, per aver parlato di un'uscita in mare per la Bolivia, che la Patria si difende dalle multinazionali, dai mercanti di salute, da chi sfrutta brutalmente i peruviani nelle miniere, nella pesca e nell'agricoltura. Contro gli irresponsabili dell'estrazione mineraria illegale o contro coloro che trafficano le nostre risorse naturali e soprattutto umane. La Patria si difende pagando le tasse e riscuotendo le tasse per la costruzione e la ricostruzione di scuole e ospedali distrutti proprio dalle vende la patria, che costituiscono la lumpen oligarchy che governa il paese.
Il presidente Castillo ha l'opportunità di schierarsi con la storia componendo una squadra di consiglieri di persone capaci e oneste destinate a dare al governo una direzione in difesa della sovranità nazionale e della redistribuzione della ricchezza nazionale. Chiaramente, richiede supporto. Deve accettare l'Unità della Sinistra e capire che ci sono donne e uomini con grandi capacità e vero amore per il paese. E' tempo che smetta di cercare la conciliazione con un diritto che lo ripudia, lo discrimina e lo insulta, non solo lui, ma la stragrande maggioranza del popolo peruviano.
- Dettagli
- Scritto da Michele Paris
 Migliaia di migranti provenienti in gran parte da Medio Oriente e Afghanistan continuano a fare le spese di un’escalation di tensioni tra Polonia e Bielorussia che rischia di sfociare in uno scontro armato in grado di trascinare nel conflitto la NATO da una parte e la Russia dall’altra. Dopo l’accordo in sede UE di lunedì per l’imposizione di nuove sanzioni punitive contro il regime di Lukashenko, Minsk ha dato in parte seguito alla minaccia di interrompere le forniture di petrolio destinate all’Europa, chiudendo “temporaneamente” l’oleodotto che dalla Russia transita attraverso il proprio territorio. Le forze di sicurezza polacche, intanto, hanno intensificato drasticamente le operazioni per tenere i migranti al di là del confine. Questa strategia incontra il pieno appoggio di Bruxelles, nonostante l’oggettiva violazione del diritto internazionale che sta caratterizzando le decisioni del governo ultra-nazionalista di Varsavia.
Migliaia di migranti provenienti in gran parte da Medio Oriente e Afghanistan continuano a fare le spese di un’escalation di tensioni tra Polonia e Bielorussia che rischia di sfociare in uno scontro armato in grado di trascinare nel conflitto la NATO da una parte e la Russia dall’altra. Dopo l’accordo in sede UE di lunedì per l’imposizione di nuove sanzioni punitive contro il regime di Lukashenko, Minsk ha dato in parte seguito alla minaccia di interrompere le forniture di petrolio destinate all’Europa, chiudendo “temporaneamente” l’oleodotto che dalla Russia transita attraverso il proprio territorio. Le forze di sicurezza polacche, intanto, hanno intensificato drasticamente le operazioni per tenere i migranti al di là del confine. Questa strategia incontra il pieno appoggio di Bruxelles, nonostante l’oggettiva violazione del diritto internazionale che sta caratterizzando le decisioni del governo ultra-nazionalista di Varsavia.
- Dettagli
- Scritto da Maura Cossutta
 Il 23 dicembre è stata presentata dal Governo al Parlamento la “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)”, che “dà conto – come afferma Draghi nella premessa - dell’utilizzo delle risorse, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti”. Si tratta dell’utilizzo della prima rata di rimborso (pari a 24,1 miliardi di euro) del finanziamento complessivo del PNRR previsto dalla Commissione Europea per il nostro paese, pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 in sovvenzioni e 122,5 in prestiti). Una cifra senza precedenti, mai neppure immaginata. Un atto importante che dovrebbe essere conosciuto, discusso, non solo dagli staff tecnici dei Ministeri ma dall’opinione pubblica, dalle cittadine e dai cittadini. Ma che non è così.
Il 23 dicembre è stata presentata dal Governo al Parlamento la “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)”, che “dà conto – come afferma Draghi nella premessa - dell’utilizzo delle risorse, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti”. Si tratta dell’utilizzo della prima rata di rimborso (pari a 24,1 miliardi di euro) del finanziamento complessivo del PNRR previsto dalla Commissione Europea per il nostro paese, pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 in sovvenzioni e 122,5 in prestiti). Una cifra senza precedenti, mai neppure immaginata. Un atto importante che dovrebbe essere conosciuto, discusso, non solo dagli staff tecnici dei Ministeri ma dall’opinione pubblica, dalle cittadine e dai cittadini. Ma che non è così.
La relazione giunge a dicembre, nello stesso periodo in cui la pandemia presenta una nuova ondata, con la nuova variante Omicron, quando riprendono drammaticamente i contagi, i ricoveri, i morti. Gli ospedali si trasformano, saltano tutti gli standard di qualità e appropriatezza, vengono accettati solo malati covid e tutti gli altri sono costretti a rimandare o sospendere tutte le prestazioni, le cure, gli interventi chirurgici. Malati oncologici vengono rimandati a casa, saltano i tempi stabiliti dagli screening oncologici, causando effetti che si manifesteranno negli anni a venire. Gli interventi di sanità pubblica si riducono ai soli programmi di vaccinazione, i programmi di umanizzazione delle cure sembrano ormai solo capitoli di fantascienza, l’affettività e la dignità della vita dei malati diventano variabili non pervenute. Gli operatori sono esausti ma non possono essere sostituiti perché le assunzioni non sono arrivate né arriveranno.
Lo spaesamento è forte. Sofferenza, paura, vulnerabilità, solitudine, rabbia. E la crisi morde. Non si intravvede la fine del tunnel.
Anche i dati pubblicati a dicembre dall’ISTAT sull’occupazione per l’anno 2021 confermano la drammaticità della realtà, nonostante qualche pretesa di miglioramento. Sono stati infatti recuperati 650.000 posti di lavoro, ma per il 60% sono precari. E ne mancano ancora 286.000 rispetto al periodo pre-covid. Siamo 22,7 milioni di occupati ma nel 2019 eravamo 23 milioni. In due anni è stato perso quasi mezzo milione di posti di lavoro e soltanto tra novembre e dicembre di quest’anno si sono perse 24.000 unità di lavoro stabile. Il lavoro a tempo determinato è il 13,5% degli occupati, mentre era il 10%. Siamo arrivati al record storico per i lavori precari: 3 milioni e 77.000, aumentati di 384.000. Come dice la CGIL – e come aveva già detto insieme alla UIL nello sciopero generale dei mesi scorsi, tanto giusto quanto deriso o comunque non difeso dai partiti della maggioranza di governo – “mentre il PIL cresce più del 6%, il lavoro cresce tre volte meno”. Per i giovani l’occupazione sta diventando solo un auspicio: sono solo il 23% degli occupati, erano il 30%. E poi il capitolo “genere” è iscritto nelle vergogne della politica: una donna su due non lavora, il tasso di occupazione è 50,5%, quello nella fascia tra 25-34 anni è il più basso d’Europa, mancano 61.000 occupate e cresce il numero delle lavoratrici che abbandonano o perdono il lavoro una volta diventate madri, 96.000 donne, quattro su dieci con figli che hanno meno di cinque anni. Cinque donne su dieci dichiarano che le loro entrate sono diminuite e che quindi sono ancora dipendenti dalla famiglia, dal partner. Il part time, come lo smart working, è diventato per le donne obbligatorio.
Il tema dell’occupazione denuncia non le smagliature, bensì le profonde storture di questo sistema. E’ una gigantesca emergenza, che bisogna rendere visibile, quella del lavoro, della qualità, della dignità, della sicurezza del lavoro. Ormai gli omicidi sul lavoro (perché di questo si tratta, non di incidenti) sono diventati una mattanza. Muoiono in fabbrica anche gli studenti, come Lorenzo Parelli, nell’ultimo giorno del periodo di alternanza scuola- lavoro.
E’ tempo di aggiornare la narrazione e la relazione di Draghi, la discussione sul PNRR, è in questo contesto che va collocata, di fronte a quello che la lezione del covid ha dimostrato ma che viene dimenticata.
 Il covid ci ha dato ragione- abbiamo detto in tante e in tanti, femministe, movimenti ambientalisti, associazionismo di realtà sociali. Il covid ha svelato l’incapacità delle nostre società, delle nostre istituzioni, dei nostri sistemi di protezione sociale e dei diritti del lavoro ad affrontare quella che era l’emergenza vera, oltre l’emergenza sanitaria, cioè i bisogni della vita, della concretezza della vita, della cura della vita. Ha svelato evidenze fino ad allora colpevolmente rimosse, considerate come ideologia, faziosità. Che le politiche liberiste dei tagli, della precarizzazione, dello smantellamento del welfare, sono state un fallimento, che le politiche liberiste e il paradigma del profitto sono incompatibili con la vita.
Il covid ci ha dato ragione- abbiamo detto in tante e in tanti, femministe, movimenti ambientalisti, associazionismo di realtà sociali. Il covid ha svelato l’incapacità delle nostre società, delle nostre istituzioni, dei nostri sistemi di protezione sociale e dei diritti del lavoro ad affrontare quella che era l’emergenza vera, oltre l’emergenza sanitaria, cioè i bisogni della vita, della concretezza della vita, della cura della vita. Ha svelato evidenze fino ad allora colpevolmente rimosse, considerate come ideologia, faziosità. Che le politiche liberiste dei tagli, della precarizzazione, dello smantellamento del welfare, sono state un fallimento, che le politiche liberiste e il paradigma del profitto sono incompatibili con la vita.
Il covid ha rimesso al centro il tema delle disuguaglianze, il tema della crisi climatica, drammatica, che resta senza critica coerente con questo modello di produzione e di consumo che distrugge gli ecosistemi e produce sfruttamento degli animali e delle persone. Il covid ha fatto tornare prioritario il tema del genere, come categoria politica, il tema antico ma sempre accantonato del rapporto tra produzione e riproduzione, della divisione sessuale del lavoro. Ha messo in evidenza il nesso tra liberismo e patriarcato, il nesso strettissimo tra politiche liberiste che hanno smantellato il welfare e la cultura patriarcale, che condanna le donne al destino biologico, al ruolo naturale all’interno della famiglia tradizionale dentro il welfare sempre più familistico.
Ma la lezione del covid non è stata ascoltata e continua a non essere ascoltata. Tornano le solite ricette, non cambiano i paradigmi. E tutto questo nel PNRR è evidente. Avrebbe potuto e dovuto essere una grande straordinaria occasione, per correggere le cause di questa crisi, per aggredire le criticità strutturali, per un cambiamento. Invece il Piano è senza visione, manca un’idea strategica, manca anche la consapevolezza delle cause dei questa crisi. Non è occasione di cambiamento, bensì di conservazione. Mentre si evoca la promozione dell’occupazione femminile, si investe di più proprio nei settori dove l’occupazione femminile è più scarsa e non viceversa nei settori dove è più alta, come i servizi, o la scuola. Il capitolo delle infrastrutture è considerato solo quello delle grandi opere e non invece quello delle infrastrutture sociali, intese come servizi alla persona, per i bambini, per gli anziani, che sono le vere azioni per liberare le donne dall’obbligo del lavoro di cura. E in generale, rispetto ai numerosissimi progetti, oltre due terzi degli investimenti previsti (107 su 162) sono sotto il miliardo di euro. Come è stato detto, “è uno sgocciolìo di risorse”, un po’ qua, un po’ là, senz’anima.
Ma vediamo più precisamente cosa prevede il PNRR. Per ricevere le risorse complessive di 191 miliardi (che arrivano a 235 miliardi con altri fondi europei), l’Italia deve presentare, così come ogni altro stato membro, un piano di investimenti e riforme alla Commissione Europea e ricevere da quest’ultima un parere positivo. Il giudizio della Commissione dipende da diversi elementi, tra cui i vincoli di destinazione delle risorse, che richiedono ai paesi membri di destinare rispettivamente il 37% e il 20% delle risorse a misure che contribuiscono alla transizione verde e alla transizione digitale. Altro elemento da rispettare è il principio del “do not significat harm”, che richiede agli stati membri di non inserire nei propri piani progetti che possano arrecare un danno significativo all’ambiente.
I progetti per i 191,5 miliardi di euro sono 142. I ministeri con più progetti e risorse sono quelli delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e della Transizione ecologica. Le risorse sono distribuite in 10 rate fino al 2026.
La Commissione valuta due volte ogni anno (a giugno e a dicembre) quanto realizzato, pena la sospensione dell’erogazione. Le missioni del PNRR sono 6 (digitalizzazione e innovazione; transizione verde ed ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile; istruzione e ricerca, inclusione e coesione; salute) e 3 sono gli “assi strategici”: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica, inclusione sociale. Le “priorità trasversali” (aggiunte solo dopo proteste e critiche) sono tre: parità di genere; giovani; sud. Nel PNRR sono fissate 527 “condizioni” da realizzare, suddivise in traguardi qualitativi (“milestones”) e obiettivi quantitativi (“targets”) da rispettare: questi “paletti” risultano importanti, perché l’erogazione delle rate semestrali è condizionato al soddisfacimento di tali condizioni.
Da subito sono state evidenziate alcune fondamentali criticità, prima fra tutte quella che, sebbene i finanziamenti per il PNRR siano disponibili solo temporaneamente, molti degli interventi previsti comporteranno un aumento permanente delle spese di gestione (ad esempio, per l’assunzione di personale). Ma nulla in questo senso viene garantito. Nessuna previsione di aumento della spesa corrente è prevista. Si prevedono insomma ferrovie ma non treni. Si prevedono ospedali ma non infermieri. Si prevedono asili ma senza educatori. Si prevede la riforma per gli anziani non autosufficienti, ma nella finanziaria il fondo è soltanto di 100 milioni.
Inoltre per alcuni ambiti le risorse previste sono del tutto al di sotto delle necessità o delle attese, come per la Ricerca. In Italia la spesa per ricerca e sviluppo è molto bassa. Per raggiungere il livello francese, l’Italia avrebbe bisogno di 5 miliardi addizionali annui. Se per i prossimi sei anni (2021-2026) si volesse finanziare questa somma con il PNRR, la ricerca dovrebbe ricevere 30 miliardi. Per raggiungere il livello tedesco servirebbero 10 miliardi addizionali ogni anno. Il PNRR del governo Draghi prevede invece uno stanziamento complessivo di 12,9 miliardi su sei anni.
Il “piano asili nido” è uno degli interventi più importanti del PNRR: con 4,6 miliardi previsti è il settimo investimento per importo stanziato. Il piano ha subito diverse modifiche nel corso del 2021, sotto la spinta e la critica soprattutto di associazioni femministe. Prevedeva la creazione di 228.000 posti, di cui 152.000 per asili nido (bambini con età tra 0-3 anni) e 76.000 per le scuole d’infanzia (3-6 anni).
Nella versione definitiva si prevede invece la creazione (entro il 2026) di 264.480 posti. Ma resta una criticità forte, quella di non distinguere tra posti in asili nido e scuole d’infanzia. Ma mentre il tasso di partecipazione scolastica nelle scuole d’infanzia e 91%, superiore alla media europea, quello di partecipazione agli asili nido è al di sotto dell’obiettivo del 33% stabilito dal Consiglio Europeo nel 2002. Inoltre esistono importanti divari territoriali tra le regioni del nostro paese, il Sud presenta tassi di copertura ben inferiori a quelle del Centro-Nord. Ma il PNRR non permette di stabilire se tali disuguaglianze verranno attenuate, perché le condizioni da rispettare riguardano l’intero territorio nazionale senza differenziazioni regionali.
Come indicato nella relazione al Parlamento, rispetto all’anno 2021 l’Italia ha rispettato l’impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi, ha presentato quindi la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.
Nel 2022 l’Italia dovrà invece rispettare 100 condizioni, di cui 83 traguardi qualitativi e 17 obiettivi. Tra le principali condizioni vi sono l’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, il passaggio parlamentare della legge sulla concorrenza, la riforma dell’istruzione primaria e secondaria, l’istituzione di un sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese, le disposizioni per combattere l’evasione fiscale e pianificare la spending review nel triennio 2023-2025.
 Ed è il capitolo delle “riforme” previste quello che più palesemente svela l’approccio ideologico del PNRR, tecnocratico e liberista. Il provvedimento sulla concorrenza, che ha la prima scadenza fissata a fine 2022, ne è l’esempio più eclatante. Si tratta di un’idea molto ben strutturata fin dal 2011 dall’allora Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, quando insieme al Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet scrisse la famosa lettera al governo italiano indicando come ineludibili le "privatizzazioni su larga scala" in particolare della "fornitura di servizi pubblici locali".
Ed è il capitolo delle “riforme” previste quello che più palesemente svela l’approccio ideologico del PNRR, tecnocratico e liberista. Il provvedimento sulla concorrenza, che ha la prima scadenza fissata a fine 2022, ne è l’esempio più eclatante. Si tratta di un’idea molto ben strutturata fin dal 2011 dall’allora Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, quando insieme al Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet scrisse la famosa lettera al governo italiano indicando come ineludibili le "privatizzazioni su larga scala" in particolare della "fornitura di servizi pubblici locali".
Oggi Draghi è il Presidente del Consiglio e può decidere di scrivere nel PNRR esattamente la stessa ricetta. Infatti l’articolo 6 del provvedimento sulla concorrenza, previsto dal PNRR, toglie espressamente la titolarità degli enti locali rispetto ai servizi pubblici locali, affidandoli al mercato. Nonostante il fallimento delle privatizzazioni, nonostante la palese diminuzione della qualità del servizio con la gestione privatistica, gli enti locali dovranno “giustificare” (è scritto esattamente così) il mancato ricorso al mercato. E dovranno persino dimostrare il perchè di altra scelta, sottoponendola al giudizio dell’Antitrust.
Il paradosso è che, in nome della concorrenza, il modello è quello delle grandi società multiservizi, quelle quotate in Borsa e che diventeranno i soggetti monopolisti praticamente per sempre. Gli enti locali - a cui sono affidati investimenti del PNRR con risorse pari a un terzo del totale, di 66 miliardi di euro- diventeranno di fatto esecutori della spoliazione della ricchezza pubblica.
Il ddl sulla concorrenza va letto poi insieme al provvedimento sull’autonomia differenziata, voluto anch’esso da Draghi. E’ il combinato disposto tra questi provvedimenti e il PNRR che delinea un passaggio di fase, di eccezionale portata. Si tratta non più solo di aumentare la privatizzazione dei servizi, ma di un vero e sostanziale cambio di modello. Salta il modello pubblico universalistico e si spalancano le porte ai mercati assicurativi. Il PNRR diventa il grimaldello per politiche costituzionalmente eversive.
Di questo credo che si debba discutere. Una relazione al Parlamento sull’attuazione del PNRR non è una discussione che riguarda i tecnici, ma chiama in causa la responsabilità della politica e la mobilitazione, anzi il conflitto, delle parti sociali. Non c’è neutralità nelle scelte tecniche e Draghi è infatti il rappresentante più autorevole della tecnocrazia liberista.
- Dettagli
- Scritto da Mario Lombardo
 Le maglie dell’indagine sull’assalto al Congresso di Washington del 6 gennaio scorso si stanno stringendo sempre più attorno alla cerchia di consiglieri e collaboratori dell’ex presidente Trump, coinvolti nel tentato colpo di stato che avrebbe dovuto impedire la ratifica del successo elettorale di Joe Biden. La speciale commissione della Camera dei Rappresentanti sugli eventi di “Capitol Hill” ha infatti emesso nei giorni scorsi 16 citazioni nei confronti di uomini con incarichi importanti nella precedente amministrazione. Tutti i convocati, salvo rifiuti o ritardi per via di possibili cause legali, saranno chiamati a testimoniare davanti alla stessa commissione nelle prossime settimane, nonché a consegnare documenti rilevanti ai fini dell’indagine in corso.
Le maglie dell’indagine sull’assalto al Congresso di Washington del 6 gennaio scorso si stanno stringendo sempre più attorno alla cerchia di consiglieri e collaboratori dell’ex presidente Trump, coinvolti nel tentato colpo di stato che avrebbe dovuto impedire la ratifica del successo elettorale di Joe Biden. La speciale commissione della Camera dei Rappresentanti sugli eventi di “Capitol Hill” ha infatti emesso nei giorni scorsi 16 citazioni nei confronti di uomini con incarichi importanti nella precedente amministrazione. Tutti i convocati, salvo rifiuti o ritardi per via di possibili cause legali, saranno chiamati a testimoniare davanti alla stessa commissione nelle prossime settimane, nonché a consegnare documenti rilevanti ai fini dell’indagine in corso.
I nuovi mandati di comparizione o “subpoena” sono stati annunciati tra lunedì e martedì dal presidente della commissione, il deputato democratico del Mississippi Bennie Thompson. Nell’atto ufficiale scritto da quest’ultimo si leggono gli elementi sui quali i membri della commissione intendono far luce con i più recenti provvedimenti. In particolare, l’attenzione si sta concentrando sulla campagna di disinformazione che aveva preceduto i fatti del 6 gennaio, volta ad alimentare la tesi dei brogli elettorali nelle presidenziali del novembre precedente, e sui piani concreti che l’entourage di Trump avrebbe studiato e implementato per fermare il conteggio dei voti dei cosiddetti “collegi elettorali” inviati dai singoli stati al Congresso.
Ognuna delle personalità di primo piano coinvolte nell’indagine sembra avere avuto un ruolo specifico nel progetto che avrebbe dovuto garantire illegalmente la permanenza di Trump alla Casa Bianca nonostante la sconfitta alle urne. Soprattutto il docente di diritto ed ex consigliere di Trump, John Eastman, è oggetto di grande intereresse, in quanto autore di un memorandum che avrebbe dovuto fornire il quadro pseudo-legale per ribaltare l’esito del voto. Eastman sosteneva in sostanza che il vice-presidente, Mike Pence, aveva la facoltà di rifiutare la certificazione della vittoria di Biden, cosa invece non prevista dalla Costituzione americana.
Lo stesso Eastman aveva tenuto un discorso durante il comizio di Trump di fronte alla Casa Bianca nelle ore che avevano preceduto l’assalto all’edificio che ospita il Congresso. Non solo, Eastman aveva preso parte alle riunioni organizzate il giorno precedente presso l’hotel Willard Intercontinental di Washington, dove era stato creato un vero e proprio “centro di comando” per pianificare i dettagli dell’operazione golpista.
Le discussioni andate in scena e le iniziative decise all’hotel Willard sono al centro dell’interesse della commissione di indagine e altri ex collaboratori di Trump sono stati appunto convocati a questo scopo, così come per chiarire i loro legami con i partecipanti all’assalto del 6 gennaio. Uno dei nomi di maggiore rilievo è quello di Jason Miller, alle dipendenze dal giugno 2020 dell’organizzazione per la campagna elettorale di Trump. Miller, secondo le conclusioni preliminari della commissione, aveva tenuto i contatti con Trump nella giornata del 6 gennaio, discutendo con ogni probabilità delle azioni da attuare in base a quanto stabilito il giorno precedente all’hotel Willard.
Qui erano presenti, tra gli altri, anche Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump, e il neo-fascista Stephen Bannon, ex consigliere del presidente. Entrambi questi ultimi erano già stati oggetto di mandati emessi dalla commissione e tuttora oggetto di cause legali visto il loro rifiuto a comparire. Un altro ancora, coinvolto invece ufficialmente questa settimana nell’indagine, è l’ex consigliere per la Sicurezza Nazionale di Trump, Michael Flynn.
 L’ex generale dell’intelligence militare, uscito precocemente dall’amministrazione Trump in seguito a una polemica legata al “Russiagate”, aveva svolto un ruolo di spicco nell’operazione di propaganda pianificata dalla Casa Bianca dopo il voto di novembre. Il 18 dicembre 2020 aveva inoltre partecipato a una riunione nello Studio Ovale durante la quale era stata valutata l’ipotesi di sequestrare le macchine per votare utilizzate nei seggi, assieme alla possibilità di dichiarare un’emergenza nazionale a causa dei presunti brogli e assegnare di conseguenza poteri speciali al presidente.
L’ex generale dell’intelligence militare, uscito precocemente dall’amministrazione Trump in seguito a una polemica legata al “Russiagate”, aveva svolto un ruolo di spicco nell’operazione di propaganda pianificata dalla Casa Bianca dopo il voto di novembre. Il 18 dicembre 2020 aveva inoltre partecipato a una riunione nello Studio Ovale durante la quale era stata valutata l’ipotesi di sequestrare le macchine per votare utilizzate nei seggi, assieme alla possibilità di dichiarare un’emergenza nazionale a causa dei presunti brogli e assegnare di conseguenza poteri speciali al presidente.
Il coinvolgimento dell’ex generale nei piani di Trump riguarda anche il fratello, l’ex vice comandante dello Stato Maggiore dell’Esercito Charles Flynn, il quale rispose il 6 gennaio a una drammatica telefonata del comandante della Guardia Nazione di Washington che richiedeva rinforzi immediati per fermare l’assalto a “Capitol Hill”. Il più giovane dei fratelli Flynn, assieme a un altro generale, ritardarono l’invio delle truppe a loro disposizione di ben tre ore e 19 minuti, evidentemente dopo essersi consultati sul da farsi con la Casa Bianca.
Gli altri nomi importanti oggetto di una “subpoena” della commissione di indagine includono la ex portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, l’ex consigliere vicino agli ambienti neo-fascisti, Stephen Miller, l’ex capo della Polizia di New York, Bernard Kerik, l’ex consigliere di Pence per la Sicurezza Nazionale, generale Keith Kellogg, l’ex direttore del personale della Casa Bianca, John McEntee, il direttore della campagna elettorale 2020, William Stepien, e l’ex assistente personale del presidente, Nicholas Luna.
Nelle parole del numero uno della commissione di indagine della Camera, deputato Bennie Thompson, l’obiettivo delle convocazioni finora ordinate sarebbe di “conoscere ogni dettaglio di ciò che accadde alla Casa Bianca il 6 gennaio e nei giorni precedenti”. Thompson spiega inoltre che sarà necessario “sapere esattamente che ruolo hanno avuto l’ex presidente i suoi consiglieri nel tentativo di fermare il conteggio dei ‘voti elettorali’ e se [questi ultimi] erano in contatto con chiunque, al di fuori della Casa Bianca, abbia partecipato ai piani per ribaltare il risultato delle elezioni”.
Come accennato in precedenza, alcuni protagonisti dell’ex amministrazione repubblicana hanno già respinto gli ordini di comparizione emessi dalla commissione di indagine nelle scorse settimane. Oltre a Bannon e all’ex capo di gabinetto del presidente, Mark Meadows, questa tattica difensiva è stata scelta anche dallo stesso Trump. Alla richiesta di presentare tutte le comunicazioni del suo ufficio nei giorni finali del mandato, Trump aveva risposto con una causa legale per cercare di tenere segreti i documenti in questione.
Martedì, però, un giudice federale del distretto della capitale ha respinto l’istanza dei legali di Trump, smontando la tesi del “privilegio presidenziale”, soprattutto perché questa facoltà, dalle fondamenta legali quanto meno dubbie, spetta se mai al presidente in carica. Biden, da parte sua, ha invece già dato il via libera alla pubblicazione dei documenti richiesti dalla commissione. Non è comunque da escludere che la vicenda legale sulle comunicazioni tra Trump e i suoi consiglieri possa finire alla Corte Suprema, ostacolando o rallentando significativamente l’indagine sui fatti del 6 gennaio. Lo stesso discorso vale per altri protagonisti del fallito golpe, dal momento che in molti sceglieranno di non collaborare all’indagine, innescando anche in questo caso lunghe cause legali.
 Tutto ciò rende decisamente incerte le prospettive dell’indagine in corso. Prospettive complicate peraltro anche da forti dubbi circa la volontà politica del Partito Democratico di fare realmente chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto il 6 gennaio scorso. Nonostante l’ostentazione di inflessibilità della commissione di indagine, infatti, le misure concrete adottate finora mostrano piuttosto una determinazione molto meno ferma, come dimostra ad esempio lo scarso numero di udienze pubbliche convocate finora.
Tutto ciò rende decisamente incerte le prospettive dell’indagine in corso. Prospettive complicate peraltro anche da forti dubbi circa la volontà politica del Partito Democratico di fare realmente chiarezza sulle responsabilità di quanto accaduto il 6 gennaio scorso. Nonostante l’ostentazione di inflessibilità della commissione di indagine, infatti, le misure concrete adottate finora mostrano piuttosto una determinazione molto meno ferma, come dimostra ad esempio lo scarso numero di udienze pubbliche convocate finora.
In linea con le tendenze all’insabbiamento di praticamente tutte le commissioni d’inchiesta sugli scandali del passato negli Stati Uniti, l’obiettivo primario anche di quella in corso sembra essere di evitare che emerga in maniera approfondita il coinvolgimento nel tentato golpe di elementi collegati ai grandi interessi economico-finanziari americani e del Partito Repubblicano nel suo insieme. Andare realmente a fondo di questi aspetti comporterebbe infatti la destabilizzazione dell’intero sistema politico americano, cosa che i democratici temono molto di più della minaccia di un nuovo rigurgito autoritario che incombe sugli Stati Uniti a meno di dodici mesi dall’invasione dell’edificio del Congresso da parte di un’orda di militanti di estrema destra.
