- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Michele Giorgio
di Michele Giorgio
Roma, 20 novembre 2011. Non era chiara ieri la posizione di Damasco alla vigilia della scadenza dell’ultimatum lanciato dalla Lega araba al regime di Bashar al-Assad chiamato ad accettare il «piano arabo» e in particolare ad accogliere osservatori per non vuole affrontare pesanti sanzioni economiche. Venerdì Damasco aveva chiesto la modifica di 18 clausole dell’accordo per l’arrivo degli osservatori, ma l’organizzazione panaraba ha opposto - stando alla stampa locale - un secco rifiuto. Come si concluderà il braccio di ferro ieri non era chiaro, in ogni caso il futuro della Siria sarà nero.
Le parole del Segretario di stato Usa Hillary Clinton sul pericolo di «una guerra civile» più che esprimere una preoccupazione rappresentano una minaccia. I recenti blitz dei disertori del cosiddetto «Esercito libero siriano» confermano che l’opposizione è sempre più armata e aiutata dall’esterno. Lo scenario libico perciò incombe sulla Siria. Stavolta però con la Russia (alleata di Damasco) nettamente contraria a un intervento militare della Nato, è la Lega araba che sta facendo il grosso del lavoro per tenere sotto pressione il regime siriano, preparare l’opposizione politica a diventare la futura classe dirigente, modello Cnt libico.
Il ruolo svolto nel 2010 dalla Lega Araba è stato straordinario per una organizzazione che negli ultimi venti anni non ha mai avuto una reale influenza, poteri concreti e, più di tutto, consenso popolare. Un risveglio che non può non sollevare interrogativi sulle finalità di tanto improvviso attivismo. Senza dubbio la situazione in Siria è gravissima e le responsabilità del regime sono enormi. Assad sostiene di avere il consenso della maggioranza dei siriani ma deve provarlo. E per farlo non ha scelta: deve indire elezioni libere e lasciare al suo popolo il diritto di esprimersi senza restrizioni e intimidazioni. In ogni caso nessun leader politico può varare misure repressive così pesanti, costate la vita a tanti cittadini, pur di rimanere al potere.
Il presidente siriano Bashar Assad
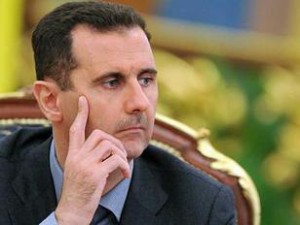 Allo stesso tempo dovrebbe ormai essere chiaro che quella in corso in Siria non è una rivolta simile a quelle di Egitto e Tunisia. Lo è stata all’inizio, con le proteste spontanee esplose a metà marzo e organizzate dai comitati popolari. Non lo è certo ora con le manifestazioni che si concentrano nelle città roccaforti del sunnismo militante (Hama, Homs), nemico del regime del partito Baath dominato dagli «apostati» alawiti, la setta sciita alla quale appartiene lo stesso Assad. Non ora con i disertori e civili armati che lanciano attacchi contro i servizi di sicurezza e l’Esercito. E forse non erano frutto della propaganda del regime le notizie di agguati ad unità della polizia e delle forze armate diffuse nei mesi scorsi dai media statali.
Allo stesso tempo dovrebbe ormai essere chiaro che quella in corso in Siria non è una rivolta simile a quelle di Egitto e Tunisia. Lo è stata all’inizio, con le proteste spontanee esplose a metà marzo e organizzate dai comitati popolari. Non lo è certo ora con le manifestazioni che si concentrano nelle città roccaforti del sunnismo militante (Hama, Homs), nemico del regime del partito Baath dominato dagli «apostati» alawiti, la setta sciita alla quale appartiene lo stesso Assad. Non ora con i disertori e civili armati che lanciano attacchi contro i servizi di sicurezza e l’Esercito. E forse non erano frutto della propaganda del regime le notizie di agguati ad unità della polizia e delle forze armate diffuse nei mesi scorsi dai media statali.
Alle redini della Lega araba (La) oggi c’è di fatto il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), guidato dall’Arabia saudita e composto dalle monarchie ed emirati del Golfo. La caduta del dittatore egiziano sotto l’urto della rivoluzione del 25 luglio e la dipendenza dell’Egitto dagli aiuti dei paesi arabi ricchi, ha catapultato alla testa della La il Consiglio che ha mosso subito i passi necessari per impedire che la «primavera araba» potesse mettere a rischio la stabilità delle petromonarchie.
La casa reale saudita, che ha inviato truppe in Bahrain a reprimere le manifestazioni popolari, ha compreso che le proteste in Siria possono essere «guidate» non tanto per abbattare Assad - peraltro un nemico solo a parole perché dipendente dagli aiuti arabi e garante della stabilità regionale - quanto per scardinare la trentennale alleanza tra Siria e Iran. Nella strategia saudita in Siria, la caduta di Assad non serve per dare la libertà ai siriani ma ad assicurare il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: l’isolamento totale di un potente nemico, l’Iran sciita.
Tagliente come sempre è il giudizio del noto commentatore arabo Asad AbuKhalil, che pure è un feroce critico del regime siriano: «I media occidentali descrivono la decisione della Lega araba di sospendere la Siria come un passo importante a favore della democrazia ma evitano di spiegare perché non è stata presa una decisione simile nei confronti del dittatore yemenita (Ali Abdullah Saleh) che pure usa i carri armati e gli elicotteri contro la sua gente. Se un dittatore gode del sostegno del Ccg, i suoi crimini verranno tollerati, a maggior ragione se è alleato degli Stati uniti».
L'autoproclamato Esercito libero siriano
 Sono considerazioni pregne di un vetero anti-americanismo quelle di Abu Khalil? Difficile sostenerlo quando gli danno ragione gli sviluppi sul terreno e le manovre in atto dietro le quinte. La Lega araba a trazione saudita prosegue il suo compito di surrogato del ruolo della Nato provando a mettere insieme le diverse anime dell’opposizione siriana per prepararla a prendere la guida della Siria quando Assad e il Baath verranno travolti.
Sono considerazioni pregne di un vetero anti-americanismo quelle di Abu Khalil? Difficile sostenerlo quando gli danno ragione gli sviluppi sul terreno e le manovre in atto dietro le quinte. La Lega araba a trazione saudita prosegue il suo compito di surrogato del ruolo della Nato provando a mettere insieme le diverse anime dell’opposizione siriana per prepararla a prendere la guida della Siria quando Assad e il Baath verranno travolti.
Riyadh con i suoi principali alleati - Giordania, Qatar e i sunniti libanesi (il governo di Beirut controllato dagli sciiti di Hezbollah invece è ancora dalla parte di Damasco) - lavorano alla costituzione di un fronte unito che, su modello del Cnt libico, dovrà diventare il «rappresentante legittimo del popolo siriano», come è stato stabilito nell’ultimo incontro al Cairo con alcuni oppositori di Assad. Nel frattempo si studiano tempi e modi del via libera che verrà dato alla Turchia (e forse anche alla Giordania) per la creazione in territorio siriano di «zone cuscinetto a protezione dei civili».
Ad intralciare, per il momento, i disegni della Lega Araba-Ccg sono le spaccature tra il Consiglio nazionale siriano (Cns) che si considera il solo rappresentante dell’opposizione siriana, e il Comitato di coordinamento nazionale (Ccn), con posizioni più moderate e favorevole al dialogo con Assad. Senza dimenticare le ambizioni della Commissione generale della rivoluzione siriana (Cgrs) e il ruolo svolto sin dalle prime proteste dai Comitati di coordinamento locali (Ccl).
Secondo il giornale libanese Al Akhbar, le prossime mosse della Lega araba saranno il riconoscimento del fronte unito delle opposizioni quale unico rappresentante legittimo del popolo siriano; la creazione delle «zone cuscinetto»; l’avvio della transizione dei poteri. Non sono contrari all’unità delle opposizioni ma sollevano obiezioni su vari punti Haytham Manna, leader del Ccn, e due intelletuali della «Dichiarazione di Damasco» (2005), Michel Kilo e Samir Aita, che temono che la Siria faccia la fine della Libia. Per i vertici della Lega, inoltre, non è facile capire il peso reale di Burhan Ghalioun, il leader del Cns. Questo storico oppositore (dall’estero) di Assad raccoglie davvero consenso? Oppure è un altro Ahmad Chalabi, l’ambizioso iracheno sponsorizzato da Washington che, fatto rientrare a Baghdad dopo la caduta di Saddam Hussein, dimostrò di rappresentare solo se stesso?
Fonte: Nena News
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Michele Giorgio
di Michele Giorgio
Sulle pagine degli esteri dei giornali di tutto il mondo ieri c’era il rilancio della colonizzazione israeliana come risposta del governo Netanyahu all’accettazione della Palestina tra i membri Unesco. Non sorprende. E’ un tema di eccezionale importanza. Ha però nascosto il clima di guerra imminente che ormai si respira nella regione. Netanyahu e il ministro della difesa Ehud Barak hanno deciso di attaccare militarmente l’Iran.
Lo scrivono da giorni i quotidiani locali che ieri hanno anche riferito una notizia che riguarda molto da vicino l’Italia. L’aviazione israeliana sta completando l’addestramento per un attacco da portare ad un obiettivo a grande distanza (le centrali iraniane?) usando anche la base Nato di Decimomannu (Sardegna). L’ultima fase dell’esercitazione in Italia, scriveva ieri Haaretz, si è svolta la scorsa settimana, con il convolgimento di sei squadroni di cacciabombardieri e ha riguardato il combattimento, il rifornimento in volo e il monitoraggio delle stazioni radar.
Notizie che non fanno altro che accreditare le indiscrezioni sulla preparazione dell’attacco alle centrali iraniane chiesto con forza da Netanyahu con l’appoggio di Barak. I due partner di guerra stanno facendo tutto il possibile per raggiungere la maggioranza in seno al gabinetto di sicurezza (sette ministri), necessaria per dare il via libera al raid aereo. Nei siti nucleari iraniani, secondo Israele e Stati Uniti, Tehran intenderebbe produrre non solo energia atomica ma anche quanto serve per assemblare ordigni atomici.
L’Iran ha sempre respinto questa accusa e ha esortato la comunità internazionale a svolgere indagini in Israele, l’unico paese della regione che possiede segretamente, secondo esperti internazionali, almeno 200 bombe atomiche. Tra i ministri che appoggiano Netanyahu c’è anche quello degli esteri e leader ultranazionalista Avigdor Lieberman che ieri ha denunciato l’Iran come «il principale pericolo per la stabilità dell’ordine mondiale». «Il mondo - ha aggiunto Lieberman - deve prendere decisioni e far rispettare le sanzioni contro la banca centrale iraniana. La comunità internazionale deve interrompere gli acquisti di petrolio dall’Iran».
Non siamo ancora all’ultimatum ma poco ci manca. Il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che verrà reso noto l’8 novembre, sarà decisivo per le scelte di Israele. Almeno questo è quanto lasciano capire gli stessi leader politici israeliani. Quanto gli Stati Uniti in questa fase siano sulla stessa lunghezza d’onda di Netanyahu e Barak è difficile decifrarlo. Barack Obama però non ha mai escluso l’opzione dell’uso della forza contro Tehran e il segretario alla difesa Leon Panetta sull’argomento è molto meno prudente del suo predecessore Robert Gates. Washington però non vuole attacchi a sorpresa e Panetta, durante il suo recente viaggio in Medio Oriente, ha ottenuto dal governo Netanyahu ampie assicurazioni. Vuol dire che i due paesi attaccheranno insieme, magari con la collaborazione di qualche alleato arabo? L’ipotesi non è infondata.
Che la guerra si sia fatta più vicina lo dice anche la resistenza più debole che oppongono all’attacco i comandanti delle Forze Armate e dei servizi segreti, ossia coloro che, secondo quanto aveva riferito venerdì scorso su Yediot Ahronot uno dei giornalisti israeliani più noti, Nahum Barnea, più di altri si sono schierati con forza contro le intenzioni di Netanyahu. Ora cominciano a cedere sotto le pressioni del premier dopo aver sottolineato per mesi le conseguenze devastanti che avrebbe il raid contro le centrali iraniane, peraltro inutile perché servirebbe a rinviare di poco i programmi di Tehran.
In Iran, naturalmente, seguono con attenzione ciò che si discute in Israele e nella Repubblica islamica non manca chi lancia avvertimenti pesanti come macigni. Il capo di stato maggiore, generale Hassan Firouzabadi, ieri ha minacciato di «far rimpiangere un simile errore» a Israele e messo in guardia anche Washington. «Se il regime sionista (Israele) ci attaccherà, saranno colpiti anche gli Stati Uniti», ha detto. L’Iran appare in grado di rispondere ad un blitz delle forze aeree israeliane con il lancio di decine, forse di centinaia di missili balistici verso il territorio dello Stato ebraico. Tehran inoltre potrebbe sferrare un’offensiva contro gli alleati arabi degli Stati Uniti mettendo a ferro e fuoco l’intero Medio Oriente. Ha anche la possibilità di bloccare lo Stretto di Hormuz paralizzando il trasporto marittimo del greggio con effetti devastanti per le economie occidentali.
Fonte: Nena news
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Marina Forti
di Marina Forti
L’amministrazione Usa ha moltiplicato gli sforzi per isolare Teheran, che nelle ultime settimane è dipinta come il nuovo «nemico principale», più pericoloso perfino della eterna al Qaeda. Un inviato del governo degli Stati uniti, il sottosegretario al tesoro David Cohen, ha girato le capitali europee per sostenere un’azione concertata per nuove sanzioni all’Iran. Da alcuni anni gli Usa trascinano i paesi alleati, Europa in testa, in sanzioni unilaterali che vanno molto oltre quelle decretate dal Consiglio di sicurezza dell’Onu.
Ora si avvicina un nuovo round. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sta per pubblicare il suo nuovo rapporto sull’Iran, e secondo alcune indiscrezione dirà che il programma di arricchimento dell’uranio ha fatto progressi e l’intero programma atomico iraniano ha finalità militari. Ormai però molti paesi rifiutano nuove sanzioni all’Iran: i sospetti non sono mai stati provati, l’Aiea continua ad avere accesso agli impianti atomici iraniani. L’Iran è inadempiente verso il Consiglio di sicurezza, che gli aveva intimato di sospendere l’arricchimento dell’uranio, ma non verso il Trattato di non proliferazione, cui aderisce.
Ecco però che da Washington arrivano altri argomenti a sostegno della sua campagna. L’Iran va contenuto perché non si infili nel vuoto che gli Usa lasciano in Iraq, da cui le ultime truppe americane si ritireranno entro fine anno (non rimarranno neppure i 3-5.000 soldati di «presidio» previsti in origine, poiché Baghdad non ha accettato la clausola dell’impunità che Washington chiede sempre per le sue truppe).
Soprattutto, c’è la storia del complotto: due settimane fa il Dipartimento alla giustizia ha annunciato di aver sventato un piano di uccidere l’ambasciatore dell’Arabia saudita a Washington, e il segretario alla giustizia Eric Holder ha dichiarato che il complotto porta dritto alle Forze Al Qods, corpo di élite delle Guardie della rivoluzione dell’Iran, e quindi al vertice della Repubblica islamica. Due settimane dopo, le prove restano molto vaghe. Tutto ruoterebbe attorno a un cittadino iraniano-americano, Mansur Arbabsiar, 56enne venditore di auto usate negli Usa, e a suo cugino Gholam Shakuri, ufficiale della Forza al Qods; il primo è agli arresti negli Usa (lunedì in tribunale si è dichiarato non colpevole), Shakuri si trova forse in Iran.
Mesi fa Arbabsiar avrebbe preso contatti con un cartello del narco-traffico messicano, gli Zeta, per vendergli tonnellate di oppio proveniente dall’Afghanistan. Arbabsiar è andato fino in Messico per trattare l’affare, ma il suo contatto era un informatore della Dea, l’agenzia anti-narco Usa: così a sostegno dell’accusa ci sono trascrizioni di telefonate e incontri dove si parla di attaccare sedi diplomatiche e di far fuori l’ambasciatore saudita.
Il giornalista americano Gareth Porter, esperto di questioni della difesa nazionale Usa, ha notato che in quelle trascrizioni è sempre l’uomo del cartello (l’informatore) a suggerire a Arbabsiar la possibilità di altre azioni - uccidere l’ambasciatore saudita - ma «non c’è una specifica conversazione da cui risulti che la proposta possa essere attribuita a Arbabsiar». Insomma: lo spiantato venditore di auto usate ha tentato di vendere oppio riconducibile all’Iran al cartello messicano, dove un agente-informatore Usa gli ha dato corda per costruire una trappola.
Nelle ultime due settimane esperti e studiosi di affari iraniani hanno espresso grande scetticismo sul complotto tex-mex. Cosa prova che l’iranian-americano agisse per conto dell’intelligence e con l’accordo dei vertici politici della Repubblica islamica? Perché le Guardie della rivoluzione si affiderebbero a un agente così improbabile? Nulla nel presunto complotto rientra nel modus operandi dell’intelligence iraniana; né pianificare un atto così rischioso in territorio Usa, né lasciare tracce indelebili, né chiamare in causa un’organizzazione esterna (gli Zeta), non musulmana e non politicamente vicina.
E poi, quale beneficio trarrebbe l’Iran da un assassinio politico che alzerebbe subito la tensione? Obiezioni espresse da voci diverse: perfino un consigliere del governo saudita ha detto che un complotto ci sarà, «ma siamo scettici su quanto sia reale». L’Iran ha smentito e protestato: dalla Guida suprema Ali Khamenei all’ex presidente Khatami, al ministro degli esteri Ali Akbar Salehi che ha anche offerto di cooperare alle indagini, se gli Usa presenteranno qualche prova.
Credibile o meno però, il «complotto» ha la sua funzione. Nelle ultime due settimane Fbi, Cia, e Dipartimenti di stato, giustizia e tesoro hanno informato il Congresso delle prove raccolte contro l’Iran. Hanno convocato diplomatici stranieri per fare lo stesso. L’ambasciatrice Usa presso l’Onu, Susan Rice, ha portato al Consiglio di sicurezza le prove. Mercoledì la Camera Usa ha dichiarato che l’Iran ha ormai superato una «linea rossa», ha compiuto un «atto di guerra», e chiede al presidente Obama di riconsiderare la politica Usa verso Tehran. Colpire l’Iran? Il clima è proprio quello.
Fonte: Nena News
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Tommaso Di Francesco
di Tommaso Di Francesco
Roma, 28 ottobre 2011. Nonostante gli sforzi dei media, dei governi e delle «opposizioni», resta difficile se non impossibile archiviare facilmente le foto pornografiche che arrivano dalla Libia. Difficile se non impossibile archiviare le immagini del corpo linciato, massacrato - pare addirittura stuprato - di Gheddafi sepolto dopo il dileggio in tutta fretta in un luogo misterioso, come se facesse ancora paura da morto. Ora in Libia la pornografia, la ripetizione all’infinito di scene di sangue, seriali e violente, dejà vu, ma per questo appetibili, non riesce a nascondere la strage di fondo che arriva da Sirte e dagli altri luoghi segnati dalle ultime ore dei vinti di turno.
Prima Amnesty International e Human Right Watch, poi le agenzie delle Nazioni unite a cominciare dalla Croce rossa denunciano in queste ore efferati massacri, con la scoperta di centinaia - secondo alcune fonti, migliaia - di corpi di esseri umani catturati, imprigionati ed assassinati in sbrigative esecuzioni. Su questo teatro di morte aleggia il silenzio assordante dell’Occidente, colto e raffinato, come di quel pacifismo che pure dovrebbe sapere che essere contro la guerra vuol dire indignarsi davvero e mettere tutti e due i piedi dentro i nodi della crisi del modello di sviluppo del cosiddetto finanz-capitalismo.
Tacciono per mestiere invece i governi che hanno promosso l’avventura bellica della Nato, pronti a ripararsi dietro l’ennesima formuletta «aprire un’inchiesta». Come fa l’Onu, che se era già data per morta stavolta è proprio seppellita. Tutti sbeffeggiati dall’ultima versione ufficiale del Cnt che, quasi a voler cancellare le immagini che tutto il mondo ha visto, insiste a dichiarare che «Gheddafi è morto nel trasporto a Misurata per le ferite riportate» ma «se risultasse che è stato ucciso, processeremo i responsabili, in modo equo». Ma che verità può venire dalla Nato che, oltre ad avere consegnato di fatto Gheddafi al linciaggio, è responsabile di avere bombardato quello sfortunato paese con più di cinquantamila bombe «intelligenti» e «precise», colpendo e devastando - con beneficio degli affari della ricostruzione - quelle aree urbane e quegli stessi civili che dichiarava di volere «proteggere»?
Ma la pornografia non si ferma a questo. Perché a poche ore dalla dichiarazione della liberazione della Libia, il Cnt chiede all’Alleanza atlantica di restare almeno fino alla fine dell’anno. Che cosa teme è presto detto: non l’ipotesi per ora debolissima di una resistenza «irachena» dei filo-gheddafiani, ma l’esplodere non solo verbale ma armato del conflitto latente tra le anime degli insorti, mentre cresce il peso e il ruolo centrale degli integralisti islamici e non solo in Libia. Oggi la Nato deciderà di non decidere. Concluderà la missione, come gli chiede il Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma in realtà aprirà alla nuova opzione che avanza. Quella di una nuova coalizione di volenterosi che si faccia carico di gestire l’insicurezza della nuova Libia. Guidata, ecco la morbosità, dal «democratico» Qatar, la petromonarchia protagonista del massacro delle primavere arabe.
Che prima ha acceso i riflettori di Al Jazeera, la tv diretta da agenti della Cia e di proprietà dell’illuminato Emiro d’ispirazione e sostegno islamo-americano, poi ha inviato armi agli insorti libici proprio mentre reprimeva nel sangue la rivolta popolare in Barhein. E infine, come del resto hanno fatto gli anglofrancesi, ha ammesso di avere inviato centinaia di soldati nei combattimenti della guerra civile libica. Una soluzione che diventa un modello e insieme una minaccia per le speranze sempre più negate delle rivolte tunisina ed egiziana, ma anche per le sorti delle crisi esplosive, siriana e yemenita. È insopportabile la puzza di nuova guerra e di petrolio che arriva da un’Europa «politica» divisa nel precipizio della crisi sul bottino bellico e comunque finita, al terminale delle sue ragioni, proprio nella - e a partire dalla - guerra libica. Tuttavia, complimenti per il set porno.
Fonte: Il manifesto
- Dettagli
- Scritto da Administrator
 di Giorgia Grifoni
di Giorgia Grifoni
Roma, 24 ottobre 2011. Continua la conti dei voti in Tunisia dopo le storiche elezioni che ieri hanno visto più di 4 milioni di persone ai seggi. I risultati, che erano previsti per questa sera, saranno annunciati domani, come ha dichiarato il capo della commissione elettorale Kamel Jandoubi. Il ritardo sarebbe dovuto alla grande affluenza registrata alle urne, una partecipazione superiore a qualsiasi previsione: circa il 70% degli aventi diritto registrati nelle liste elettorali ha votato -ovvero 4,1 milioni di cittadini su circa 7 milioni- e ci si attende una significativa partecipazione anche dal restante 30% non registrato.
I primi sondaggi, seppur parziali, danno la maggioranza relativa a Ennahdha. In alcune circoscrizioni, tra le quali Sfax e Kef, avrebbe per ora ottenuto la maggioranza assoluta, superando il 50% dei voti. Al secondo posto ci sarebbero per ora i laici del Partito Democratico Progressista guidato da Maya J’ribi. “Ci inchiniamo alla volontà popolare” ha commentato la segretaria del PDP dopo l’annuncio dei risultati parziali.
Se non otterrà la maggioranza assoluta in patria, Ennahdha potrebbe però ottenerla nelle 6 circoscrizioni estere: come in Italia, dove il partito islamista ha ottenuto il 51% dei voti : “Ennahdha è il primo partito tra i tunisini che vivono in Italia - ha annunciato Omar el-Saghir, il primo tra gli eletti nella circoscrizione italiana - e abbiamo ottenuto due delegati su tre all’Assemblea di Tunisi”. Comunque vada, la Tunisia vuole rispettare le decisioni del popolo. “La gente - ha dichiarato ad al-Jazeera Ahmed Najib Chebbi, fondatore del PDP - è qui per esercitare i propri doveri, e sta dimostrando che merita quei diritti che le sono stati negati per troppi decenni”.
Per molti dei cittadini che ieri si sono messi in fila ancor prima che io seggi aprissero, era la prima volta al voto. Alcuni hanno portato anche i bambini ad assistere allo storico momento che arriva nove mesi dopo la cacciata del presidente Zine el-Abidine Ben Ali durante la “rivoluzione dei gelsomini”. Gli osservatori, sia locali che internazionali, hanno confermato la sostanziale regolarità delle operazioni di voto, nonostante alcuni episodi verificatisi durante il giorno. Rachid Ghannouchi, leader di Ennahdha, è stato insultato da alcuni avversari politici davanti al seggio di Tunisi dove si era recato a votare con sua moglie e sua figlia, mentre un gruppo salafita avrebbe mandato messaggi minacciosi ad alcuni abitanti della periferia di Tunisi invitandoli a non votare, dichiarando la Costituzione contraria ai precetti del Corano.
Il voto di ieri sceglierà dei 217 membri che comporranno l’Assemblea Costituente, incaricata di redigere una nuova Costituzione e organizzare le prossime elezioni parlamentari e presidenziali. Fino ad allora, il governo continuerà ad essere guidato dal primo ministro ad interim Beji Caid Essebsi. Il sistema proporzionale è stato adottato perché garantisse la massima rappresentatività dei numerosissimi partiti che hanno concorso alle elezioni.
Grande soddisfazione anche all’estero per le prime elezioni libere tunisine. L’Unione Europea ha espresso il suo sostegno alle future autorità, qualunque esse siano. Il plauso alla giornata di ieri è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti Obama: “Come molti Tunisini hanno protestato pacificamente nelle strade per reclamare i loro diritti, oggi si sono messi in fila per decidere del proprio futuro. La rivoluzione tunisina ha cambiato il corso della storia”.
Fonte: - Nena News
