- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Due giorni fa, il gabinetto olandese di centro-destra è diventato l’ennesima vittima della crisi del debito in Europa, quando il primo ministro, Mark Rutte, ha rimesso il proprio incarico nelle mani della regina Beatrice. La crisi di governo nei Paesi Bassi è stata provocata dal mancato accordo raggiunto dall’esecutivo con il Partito per la Libertà (PVV) di estrema destra su un pacchetto di austerity richiesto dall’Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.
Il premier Rutte è alla guida di un governo di minoranza, sostenuto dal suo Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) e dai Cristiano Democratici (CDA), che finora ha dovuto fare affidamento sull’appoggio esterno del PVV di Geert Wilders. Rutte aveva messo assieme la sua coalizione nell’ottobre del 2010 dopo il crollo di quella precedente, formata dal CDA e dal Partito Laburista (PVDA), in seguito alla defezione di quest’ultimo, contrario alla decisione di prolungare la permanenza del contingente militare olandese in Afghanistan.
Come già anticipato, la rottura è avvenuta dopo che Wilders ha annunciato che il suo partito non avrebbe votato i nuovi tagli alla spesa pubblica voluti dal governo e che ammontano a 16 miliardi di euro. Il timore del leader populista olandese è quello di veder crollare i propri consensi appoggiando una serie di misure estremamente impopolari. Da qui la consueta accesa retorica di Wilders, il quale ha affermato che “non ha alcun senso infliggere sofferenze per compiacere i dittatori di Bruxelles”.
Secondo quanto concordato con l’Unione Europea, l’Olanda avrebbe dovuto sottoporre entro il 30 aprile il proprio piano di bilancio per riportate il deficit al di sotto del 3% del PIL entro la fine del 2013 dopo che per quest’anno dovrebbe salire al 4,7%.
La caduta di fatto del governo olandese e la mancata approvazione delle misure di austerity sono altamente significative. L’Olanda, oltre a essere uno dei pochi paesi europei a conservare il rating della tripla A per il proprio debito pubblico, è infatti schierata a fianco della Germania nel chiedere a tutti i governi dell’Unione il rispetto assoluto delle politiche di rigore. Il contagio dell’instabilità politica a questo paese appare dunque come il sintomo più evidente delle gravi tensioni sociali provocate dai diktat dei mercati finanziari e dei vertici europei ai governi sovrani per operare sempre più pesanti tagli alla spesa pubblica. Le dimissioni di Rutte giungono inoltre in un momento nel quale sembrano tornare ad addensarsi nubi minacciose sul futuro dell’Unione Europea, con i mercati già in agitazione per la vittoria al primo turno delle presidenziali francesi di François Hollande e per la diffusione dei dati preoccupanti sull’andamento dell’economia tedesca. Questo inizio di settimana è stato così segnato da una nuova impennata dei tassi di interesse sui bond di molti paesi in affanno, tra cui l’Italia e la Spagna, e da perdite sostanziali per le principali borse europee e a Wall Street.
Le dimissioni di Rutte giungono inoltre in un momento nel quale sembrano tornare ad addensarsi nubi minacciose sul futuro dell’Unione Europea, con i mercati già in agitazione per la vittoria al primo turno delle presidenziali francesi di François Hollande e per la diffusione dei dati preoccupanti sull’andamento dell’economia tedesca. Questo inizio di settimana è stato così segnato da una nuova impennata dei tassi di interesse sui bond di molti paesi in affanno, tra cui l’Italia e la Spagna, e da perdite sostanziali per le principali borse europee e a Wall Street.
Se l’opposizione olandese, pur avendo nei propri programmi la riduzione del debito, non ha voluto prendersi il rischio di appoggiare il piano di austerity del governo, qualunque esecutivo prenderà il posto di quello uscente si ritroverà a fronteggiare le pressioni degli ambienti finanziari internazionali per rispettare gli impegni presi e procedere in qualche modo con l’approvazione delle misure di rigore.
A confermalo è stato lunedì il ministro delle Finanze olandese, Jan Kees de Jager (CDA), di ritorno del vertice dell’FMI a Washington. Secondo quest’ultimo, il governo Rutte potrebbe rimanere al suo posto per alcuni mesi, così da cercare un nuovo accordo sui tagli e ottenerne l’approvazione in Parlamento. Ribadendo le uniche preoccupazioni della classe dirigente europea in questa fase storica, nonché la natura profondamente anti-democratica dei governi in carica, Kees de Jager ha affermato che “la cosa più importante, per lanciare un messaggio ai mercati finanziari, è che l’Olanda, in qualsiasi circostanza, faccia tutto il possibile per mantenere la disciplina di bilancio”.
Al momento non è ancora chiara la data delle elezioni anticipate. Alcuni partiti preferiscono rimandare il voto a dopo l’estate, così come l’Unione Europea, che vorrebbe l’approvazione immediata del pacchetto di austerity per evitare di lasciare la questione in mano ad una nuova coalizione di governo che, alla luce della frammentazione politica e dell’impopolarità di quasi tutti i partiti olandesi, potrebbe essere tutt’altro che stabile.
Secondo i sondaggi, nessun partito sarebbe in grado di ottenere una chiara maggioranza e, in particolare, l’ostilità diffusa verso le politiche di rigore finora adottate determinerebbe un calo evidente dei consensi per la coalizione di governo e, in misura minore, per lo stesso PVV di Geert Wilders. Meglio dovrebbero andare invece le opposizioni, in particolare il Partito Socialista (SP).
La crisi di governo in Olanda, intanto, ha visto il moltiplicarsi sui media occidentali del messaggio già uscito recentemente dal summit FMI e cioè che le misure di austerity da sole non sono in grado di risolvere la crisi del debito nell’eurozona e sono perciò necessarie iniziative per rilanciare la crescita economica. La nuova realtà appare tanto più preoccupante se si considera che solo poco più di un mese è passato dalla sottoscrizione da parte di 25 dei 27 paesi UE di un patto fiscale improntato al rigore che sembrava aver dissipato le principali inquietudini per il futuro dell’unione monetaria. Parallelamente, qualcosa come mille miliardi di euro in prestiti a bassissimo tasso di interesse, erogati tra dicembre e marzo dalla BCE al sistema bancario europeo, avevano ancor più fatto sperare che il peggio era ormai dietro le spalle. Ben presto tuttavia, i dati negativi provenienti da molte parti d’Europa hanno reso evidente che, con ogni probabilità, il fondo deve ancora essere toccato.
La nuova realtà appare tanto più preoccupante se si considera che solo poco più di un mese è passato dalla sottoscrizione da parte di 25 dei 27 paesi UE di un patto fiscale improntato al rigore che sembrava aver dissipato le principali inquietudini per il futuro dell’unione monetaria. Parallelamente, qualcosa come mille miliardi di euro in prestiti a bassissimo tasso di interesse, erogati tra dicembre e marzo dalla BCE al sistema bancario europeo, avevano ancor più fatto sperare che il peggio era ormai dietro le spalle. Ben presto tuttavia, i dati negativi provenienti da molte parti d’Europa hanno reso evidente che, con ogni probabilità, il fondo deve ancora essere toccato.
Mentre nelle stanze del potere e sui giornali si discute della necessità di misure che favoriscano la crescita, raramente si parla di iniziative concrete che, inevitabilmente, comporterebbero un maggiore livello di spesa, determinando un nuovo aumento dell’indebitamento di molti paesi e nuove pressioni dei mercati. Tra le idee che sembrano trovare maggiore consenso vi sono poi un eventuale ruolo più attivo della BCE nello stimolare la crescita e l’emissione di Eurobond, misure entrambe osteggiate dal governo di Berlino.
A ben vedere, in ogni caso, questa tardiva presa di coscienza del fatto che le politiche di rigore deprimono l’economia appare ben poco credibile. Come venne ripetuto fino alla nausea dopo lo scoppio della crisi globale nell’autunno del 2008, infatti, praticamente tutti i politici e gli economisti hanno assimilato la lezione della Grande Depressione degli anni Trenta del secolo scorso negli Stati Uniti, aggravata proprio quando il governo americano interruppe precocemente le politiche di deficit spending provocando un nuovo rallentamento dell’economia.
Anche per questo motivo, appare dunque chiaro che quella in corso si tratta di una strategia ben orchestrata da parte delle élite politiche e finanziarie internazionali, secondo la quale sono stati dapprima implementati tagli selvaggi alla spesa pubblica per ridimensionarla drasticamente nel medio e lungo periodo, senza scrupolo alcuno per le conseguenze sull’economia e sulle condizioni di vita della maggior parte della popolazione, mentre in questa nuova fase l’obiettivo principale è la deregolamentazione del mercato del lavoro, così da creare una vasta manodopera a basso costo e senza diritti. Il tutto, com’è ovvio, propagandato come manovra indispensabile per stimolare la crescita economica.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Dopo mesi di complicate trattative, il governo afgano e quello americano hanno raggiunto domenica un accordo preliminare sulla partnership strategica che dovrebbe legare i due paesi per i dieci anni successivi alla data del 31 dicembre 2014, quando cioè le truppe di occupazione NATO abbandoneranno definitivamente il paese centro-asiatico.
Secondo i resoconti giornalistici, l’intesa è però più simbolica che sostanziale. Per cominciare, non è stato reso pubblico il testo dell’accordo, né è stata annunciata l’entità degli aiuti economici che gli Stati Uniti garantiranno a Kabul. Soprattutto, non si è accennato alla questione più delicata, vale a dire la permanenza di un contingente militare americano in Afghanistan dopo il 2014.
Quest’ultima condizione risulta fondamentale per Washington, il cui interesse è quello di rimanere a lungo nel paese, così da mantenere il controllo su un’area del globo con ingenti ricchezze energetiche e dove è in corso un’aspra competizione con Russia e Cina.
Un accordo più specifico tra USA e Afghanistan dovrebbe essere siglato entro qualche mese o, al più tardi, il prossimo anno, dopo ulteriori round di negoziati. È possibile che di fronte ad una serie di questioni spinose ancora aperte, in particolare quelle relative alla sovranità del futuro Afghanistan, e alla sempre crescente ostilità popolare verso gli Stati Uniti, le due parti abbiano deciso di procedere in maniera cauta, annunciando per il momento un’intesa di massima e lasciando la risoluzione dei dettagli più complessi ad una fase successiva.
In quest’ottica, un accordo su due questioni importanti era stato raggiunto nelle ultime settimane, riguardo cioè al trasferimento dei detenuti in mano americana alle autorità afgane e ai raid notturni condotti dalle forze speciali a stelle e strisce, ai quali è stata data una parvenza di legittimità secondo la legge locale pur lasciandoli sostanzialmente sotto esclusivo controllo statunitense.
I più recenti episodi che hanno provocato frizioni tra USA e Afghanistan e scatenato l’odio popolare verso gli occupanti, da ultimo la pubblicazione da parte del Los Angeles Times di alcune immagini con soldati americani in posa con i corpi smembrati di militanti afgani, non sembra creare troppi problemi al regime di Hamid Karzai, il quale necessita di una partnership a lunga scadenza con Washington, da cui dipende interamente per la propria sopravvivenza. Parallelamente, un accordo di ampio respiro con il governo afgano è di primaria importanza anche per gli Stati Uniti, i quali dovendo fronteggiare una realtà sul campo in rapido deterioramento, nonostante le pretese di successo propagandate dai vertici militari, intendono assicurarsi una presenza stabile in quest’area del pianeta facendo affidamento su un governo fantoccio pronto ad assecondare i loro interessi strategici.
Parallelamente, un accordo di ampio respiro con il governo afgano è di primaria importanza anche per gli Stati Uniti, i quali dovendo fronteggiare una realtà sul campo in rapido deterioramento, nonostante le pretese di successo propagandate dai vertici militari, intendono assicurarsi una presenza stabile in quest’area del pianeta facendo affidamento su un governo fantoccio pronto ad assecondare i loro interessi strategici.
Questa realtà è come al solito ammantata dalla retorica della democrazia e della necessità di portare la libertà al popolo afgano. Così, nelle parole dell’ambasciatore americano a Kabul, Ryan C. Crocker, apparso domenica di fronte al Consiglio per la Sicurezza Nazionale dell’Afghanistan, “l’accordo testimonia dell’impegno americano per un Afghanistan unito, democratico, stabile e sicuro”.
In realtà, l’accordo e l’inevitabile prolungata presenza dei militari americani nel paese non porteranno ad una maggiore stabilità, ma produrranno al contrario nuove tensioni nella regione, dal momento che incontreranno l’ostilità di paesi come Iran, Pakistan e Cina. La finalizzazione della partnership, in ogni caso, rimane vincolata al ruolo che giocherà la resistenza talebana, soprattutto dopo il recente fallimento dei colloqui di pace con gli americani e il governo del presidente Karzai.
L’accordo annunciato domenica è stato redatto dall’ambasciatore Crocker e dal consigliere afgano per la sicurezza nazionale, Rangin Dadfar Spanta. Il testo passerà ora all’esame dello stesso Karzai, del parlamento afgano e della Casa Bianca, mentre diventerà effettivo solo con la firma dei due presidenti, verosimilmente in occasione del summit NATO in programma a Chicago per la fine del prossimo mese di maggio. La bozza di intesa giunge pochi giorni dopo un altro vertice del Patto Atlantico andato in scena a Bruxelles e che ha visto gli Stati Uniti impegnati a raccogliere consensi tra gli alleati per stanziare il denaro necessario a mantenere le forze di sicurezza afgane. Qualche giorno prima, Karzai aveva chiesto agli americani di garantire la somma annua di 2 miliardi di dollari per questo scopo.
La bozza di intesa giunge pochi giorni dopo un altro vertice del Patto Atlantico andato in scena a Bruxelles e che ha visto gli Stati Uniti impegnati a raccogliere consensi tra gli alleati per stanziare il denaro necessario a mantenere le forze di sicurezza afgane. Qualche giorno prima, Karzai aveva chiesto agli americani di garantire la somma annua di 2 miliardi di dollari per questo scopo.
Complessivamente, l’esercito e la polizia afgana dovrebbero costare circa 4 miliardi l’anno e, oltre alla quota promessa dagli USA e a 500 milioni di dollari a carico del governo di Kabul, il resto dovrà essere reperito tra gli altri governi della NATO, in gran parte alle prese tuttavia con la persistente crisi economica e del debito.
Come previsto, l’annuncio dell’accordo di domenica è stato subito accolto duramente dai talebani, i quali in un comunicato ufficiale hanno elencato dal loro punto di vista i veri scopi della partnership, spesso cogliendo perfettamente nel segno.
Secondo gli studenti del Corano, il primo obiettivo del trattato è quello di “assicurarsi l’accesso ai giacimenti petroliferi dell’Asia centrale e del Mar Caspio”; seguono l’ostacolo allo sviluppo di un “movimento in favore di un governo autenticamente islamico”, l’instaurazione di un regime “secolare e liberale in Afghanistan”, la “creazione di un esercito ostile all’Islam e a protezione degli interessi occidentali” e la “minaccia verso i paesi islamici della regione e l’impedimento alla creazione di legami politici e militari tra di essi e l’Afghanistan”.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Con il 28,63 dei voti a Hollande e il 27,12 a Sarkozy, si è chiuso il primo turno delle presidenziali francesi. Per Sarkozy la sconfitta era prevista ed è arrivata, anche se di dimensioni tutto sommato contenute, viste le premesse. Il presidente uscente non ha comunque passato indenne la prima delle forche caudine elettorali, a riprova che le sue politiche di assoluta dipendenza dai voleri della signora Merkel non sono risultate gradite ai francesi.
E a conferma di quanto le politiche recessive godano di grandi passioni nei salotti della finanza ma di pessimi giudizi nelle persone che di quelle politiche diventano le prime vittime ( e che prima o poi votano), arriva il dato principale emerso dall’apertura delle urne: il 18 per cento raggiunto dal Front National guidato da Le Pen figlia.
Non è un’affermazione del tutto nuova quella della destra xenofoba e fascistoide francese, basti ricordare Le Pen padre, che giunse del tutto inaspettatamente al ballottaggio, superando il partito Socialista guidato da Lionel Jospin al primo turno e provocando così la crisi verticale della sinistra light francese.
Ma stavolta l’affermazione xenofoba è quasi uno tsunami: Marine Le Pen ha raddoppiato i voti paterni del 2007 e questo racconta molto di come la crisi economica e del modello sociale vengano percepite dai settori più disagiati. Perché il voto a Le Pen non arriva dalla borghesia ricca e grassa o dalla media borghesia, magari scarsamente glamour; il voto arriva direttamente dalle banlieus, dagli indotti industriali messi a terra dalla crisi, dal sud del paese in estrema difficoltà. Dunque un successo personale e politico di tutto rilievo per Marine Le Pen, a testimoniare che non sempre padre e figli in politica producono Bossi e la sua trota.
Ottiene un buon risultato anche il Front de la Gauche di Melenchon, che con l’11,11 per cento dei voti si accredita come la quarta forza del paese. Alla vigilia i sondaggi lo accreditavano di un risultato migliore, ma la memoria francese di quando la sinistra trotzkysta svolse un ruolo preponderante nella sconfitta di Jospin deve aver spinto qualcuno dei suoi elettori a un cambio di voto all’ultimo momento.
L’affermazione di Hollande era stata ampiamente pronosticata, ma il margine di vantaggio ottenuto appare esiguo e potrebbe non essere sufficiente al secondo turno, dove al momento il candidato socialista può contare solo sull’appoggio esplicito della candidata dei Verdi, Eva Joly, che ha ottenuto il 2,31%, e che darà indicazione di appoggiare Hollande al secondo turno. I sondaggi indicano poi nel 77% degli elettori del Front de Gauche quelli disponibili a votare socialista al secondo turno e dividono esattamente in tre parti - Sarkozy, Hollande e astensione - la quota del 9% dei centristi. La partita tra il leader socialista e il marito di Carla Bruni è quindi decisamente aperta, anche in considerazione della quota non indifferente - stimata intorno al 17% dai sondaggisti - degli elettori che si dicono incerti sul voto al secondo turno. Tra quelli che hanno votato scheda bianca o nulla al primo turno, il 14% é per Hollande, il 13% per Sarkò e il 73% non ha scelto. Per le sorti di Sarkozy sarà comunque decisivo il comportamento degli elettori del Front National e dei centristi guidati da Francois Bayrou (9,13%). Marine Le Pen ha detto che non darà nessuna indicazione di voto, ritenendo i suoi elettori “adulti e in grado di decidere da soli”. Tutto da vedere cosa succederà tra l’Umpt e il FN.
Per le sorti di Sarkozy sarà comunque decisivo il comportamento degli elettori del Front National e dei centristi guidati da Francois Bayrou (9,13%). Marine Le Pen ha detto che non darà nessuna indicazione di voto, ritenendo i suoi elettori “adulti e in grado di decidere da soli”. Tutto da vedere cosa succederà tra l’Umpt e il FN.
In Francia, diversamente dal centro destra italiano, i gaullisti hanno sempre rifiutato l’appoggio dell’estrema destra per vincere; la tradizione politica antifascista e repubblicana dei conservatori francesi ha sempre mantenuto saldi alcuni principi repubblicani non negoziabili. Ma Sarkò è altra cosa da Giscard D’Estaing o Chirac; la sua spregiudicatezza politica e personale, la sua smodata passione per il potere e per il suo ruolo potrebbero far cadere il tabù democratico, pur tenendo in conto la disaffezione che produrrebbe nell’area moderata nel caso chiedesse apertamente il voto degli elettori del Front National (che poi, non è detto che glielo darebbero comunque).
E’ dunque probabile che il margine ristretto che lo separa da Hollande possa indurlo a pescare tra i centristi e sperare che il connubio tra socialisti ed estrema sinistra non funzioni. Hollande, infatti, stretto tra i mercati e le sue vittime potrebbe trovarsi con più problemi di quanto previsto.
Nelle dichiarazioni a caldo, dopo lo scrutinio, un dirigente socialista si è detto “relativamente preoccupato” del voto degli elettori della Le Pen, affermando che in molte situazioni i militanti socialisti hanno incontrato elettori che avrebbero confessato il voto certo al candidato socialista al secondo turno, ma che al primo, “per rabbia”, avrebbero votato Le Pen. Teoria bizzarra, davvero: si sarebbe capito il ragionamento se il voto “di rabbia” dell’elettore di sinistra fosse andato al Front de Gauche, ma davvero non si capisce come si possa votare tutto e il contrario di tutto nello spazio di quindici giorni. Se fosse vero, ci si dovrebbe chiedere se la spiegazione risiede nella natura dei francesi o in quella dei socialisti.
Secondo alcuni sondaggi, al ballottaggio Hollande appare comunque favorito, con il 54% delle intenzioni di voto contro il 46% del presidente in caric, ma il 18% di indecisi rende tutto molto ipotetico. In attesa però di definire gli schieramenti al secondo turno, i commenti e le reazioni al voto di Domenica hanno già offerto indicazioni circa il prossimo 6 Maggio. Da noi Bersani si dice contento perché “abbiamo le stesse idee di Hollande”. Mica tanto: Hollande si è dichiarato “indisponibile” all’inserimento in Costituzione della norma sul pareggio di bilancio, mentre Bersani l’ha appena votata. Hollande parla di una sinistra che rimette al centro “uguaglianza e laicità”, Bersani non usa questi termini da almeno quindici anni.
Passando a reazioni più sostanziose, la Cancelliera tedesca Merkel ha confermato il suo appoggio a Sarkò, pur dicendosi preoccupata del voto al primo turno. Tutta da stabilire l’efficacia dell’appoggio di Frau Merkel; al momento, infatti, visto l’orientamento dei francesi in relazione alle politiche europee in tema di bilancio, più che un sostegno tangibile rischia di divenire il classico bacio della morte. D’altra parte, l’orientamento dei mercati appare chiaro: i timori per la Spagna e le voci circa il declassamento dei Paesi Bassi, con le dimissioni del governo olandese, hanno certamente influito sul mercato degli scambi, ma la notizia del vantaggio elettorale di Hollande e i timori che possa essere lui il prossimo inquilino dell’Eliseo ha decisamente contribuito a mettere in agitazione gli speculatori. La Borsa francese ieri ha registrato pesanti perdite, trascinando con sé l’insieme delle piazze del Vecchio Continente e lo spread sui titoli si è avvicinato pericolosamente a quota 150. Insomma, Francois Hollande non piace ai mercati.
D’altra parte, l’orientamento dei mercati appare chiaro: i timori per la Spagna e le voci circa il declassamento dei Paesi Bassi, con le dimissioni del governo olandese, hanno certamente influito sul mercato degli scambi, ma la notizia del vantaggio elettorale di Hollande e i timori che possa essere lui il prossimo inquilino dell’Eliseo ha decisamente contribuito a mettere in agitazione gli speculatori. La Borsa francese ieri ha registrato pesanti perdite, trascinando con sé l’insieme delle piazze del Vecchio Continente e lo spread sui titoli si è avvicinato pericolosamente a quota 150. Insomma, Francois Hollande non piace ai mercati.
Non solo perché il leader socialista si è detto contrario all’approvazione del Fiscal Pack, ma anche perché l’affermazione limitata ottenuta al primo turno renderà obbligatorio l’appoggio del Front de Gauche e dei Verdi il prossimo 6 Maggio. E saranno certamente appoggi che la sinistra e gli ecologisti cercheranno di capitalizzare al meglio: vuoi con una presenza diretta nell’Esecutivo, vuoi con un programma di governo che renda maggiormente affidabile l’impegno di Hollande per una diversa politica economica, improntata sulla crescita e sul rilancio dei consumi interni, sulla maggiore partecipazione pubblica all’economia e sulla revisione netta delle politiche di austerità europea che, dagli Usa fino ai Brics, molti ritengono ormai quantomeno inadeguate se non addirittura suicide.
E non é detto che Hollande non diventi utile al resto dell'Europa, Germania esclusa: il 13 Giugno, quando dovrebbero entrare in vigore le misure draconiane europee, il rifiuto eventuale di Hollande e della Francia potrebbe trasformarsi nel traino per il resto dell'Europa verso il ripensamento delle politiche di bilancio imposte dalla Merkel e dalla BCE. Hollande, quindi, potrebbe rappresentare il primo passo di un cammino diverso, che respinge il passo dell'oca della Bundesbank e propone una ricetta di crescita per il vecchio continente.
Del resto per la Francia il dato politicamente più importante del primo turno, è proprio quello che vede il voto “anti-sistema” raggiungere la soglia del 33%. Fuori dall’arco del patto costituzionale classico, tra gollisti, repubblicani e socialisti, le cosiddette “ali estreme” - a destra e a sinistra - conquistano un elettore su tre. Si può gioire o dolersi, ma é difficile ignorare il segnale o, peggio, imputarlo a pigrizia politica, trattandosi con tutta evidenza di un voto di protesta contro la classe politica in generale, di una reazione rabbiosa dei rappresentati verso i rappresentanti. Continuare dunque a parlare di percentuali e di sfumature, di alleanze e apparentamenti di fatto, sembra come discutere di arredo a la page mentre dal tetto della casa piove acqua a catinelle.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
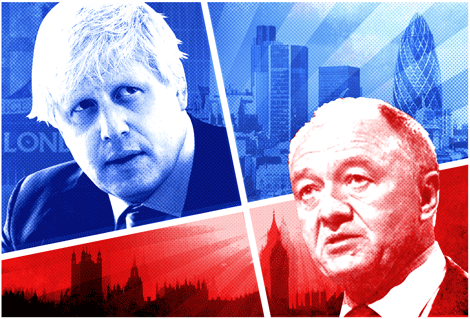 di Emanuela Pessina
di Emanuela Pessina
London’s burning, ma stavolta non sono gli incendi né i riots a farla bruciare. Una sola settimana separa la metropoli britannica dalle elezioni del suo primo cittadino e a infuocare è il dibattito elettorale dell’ultima ora. La posta in gioco è molto alta: oltre a gestire le Olimpiadi del 2012, evento d’interesse internazionale, il nuovo Mayor rappresenterà il voto di otto milioni di cittadini, un’entità che avrà un peso notevole sull’atmosfera politica generale del Paese. Sei i candidati in lizza, di cui quattro i più plausibili, per una campagna elettorale giocata tra l’importanza delle singole personalità politiche, più che quella dei partiti, e il filo del populismo.
A dominare i sondaggi pre-elettorali, seppur di pochi punti, è Boris Johnson, il rappresentante dei Tories, il partito conservatore inglese, e primo cittadino in carica dal 2008. Nelle ultime elezioni ha ottenuto più di un milione di voti, la maggioranza elettorale più ampia nella storia britannica. Il partito laburista si presenta invece con Ken Livingstone, che ha già sfidato Johnson per la stessa poltrona nel 2008. Per i LibDem, il partito socialdemocratico inglese, si candiderà ancora una volta Brian Paddick, ex capo della polizia metropolitana londinese in pensione, che ha recentemente attirato l’occhio indiscreto dei media per il romantico matrimonio norvegese con il suo compagno storico.
Al gentil sesso, infine, la candidatura dei Verdi: si chiama Jenny Jones ed è una delle donne più influenti della Gran Bretagna, presente sulle scene della politica da ben 25 anni. Le probabilità di vincita di Miss Jones sono probabilmente basse, ma il suo contributo a queste elezioni non è da sottovalutare. Una proposta della candidata ecologista ha infatti “indotto moralmente“ i candidati sindaci a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. L’invito di Miss Jones è arrivato in seguito ad alcuni rumors circa una possibile evasione fiscale di Livingstone, lo sfidante laburista. Tutti e quattro i candidati hanno reso pubblici i loro piccoli segreti fiscali, e sia per Livingstone che per Johnson si sono riscontrate alcune “macchie”, che si sono in un certo senso equilibrate essendo presenti in entrambe le parti.
Una proposta della candidata ecologista ha infatti “indotto moralmente“ i candidati sindaci a rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. L’invito di Miss Jones è arrivato in seguito ad alcuni rumors circa una possibile evasione fiscale di Livingstone, lo sfidante laburista. Tutti e quattro i candidati hanno reso pubblici i loro piccoli segreti fiscali, e sia per Livingstone che per Johnson si sono riscontrate alcune “macchie”, che si sono in un certo senso equilibrate essendo presenti in entrambe le parti.
Una procedura, inutile dirlo, che ha spaventato tutta la classe politica inglese, preoccupata dal fatto che possa diventare un must. L’abitudine è già uno standard negli Stati Uniti e, poco ma sicuro, garantisce più trasparenza. The Guardian avverte tuttavia che in questo modo si rischia di annientare del tutto quel poco di ideologia che rimane alla politica, rimettendo tutto nella figura individuale dei singoli politici.
Per il resto, la campagna elettorale si è giocata interamente attorno alla sicurezza e alla lotta alla criminalità, una delle piaghe che maggiormente preoccupa il cittadino medio londinese. Johnson promette di dimettersi se non raggiunge, durante il suo mandato, una riduzione della criminalità del 20%. La promessa era già stata fatta nel 2008: i risultati non si sono comunque visti e il pegno non è stato pagato.
Livingstone, il candidato laburista, non perde occasione per ricordare agli elettori l’irresponsabilità di Johnson in occasione dei gravi disordini dell’estate 2011 quando, durante una protesta, la polizia uccise un giovane di 29 anni e i riots, per tutta risposta mise a ferro e fuoco (nel vero senso della parola) Tottenham Hale, un quartiere tutto fuorché residenziale della periferia nord- est della metropoli.
Johnson, che si trovava fuori Londra, riuscì a sollevare lo sdegno generale con una sola frase: ”Non ho intenzione di interrompere la mia vacanza per i disordini di Totthenam Hale”, aveva dichiarato spavaldo alla BBC, “perché sono certo che le forze dell’ordine sanno gestire la situazione in maniera ottimale”. Sottovalutando così l’importanza del quartiere messo in trincea dai manifestanti e l’entità degli scontri. E rivelando, oltre a un buon grado di arroganza, un’incapacità di giudizio critico impensabile per un politico. Anche Paddick, il socialdemocratico, scommette la propria poltrona contro un calo dei crimini, promettendo di togliere diversi privilegi agli ufficiali delle forze dell’ordine. Certo, un ex-capo di Scotland Yard ci si potrebbero aspettare grandi cose, eppure nel 2008 Paddick era arrivato solo terzo. Più contenuta Miss Jones, del partito ecologista, che “potrebbe dimettersi” nel caso in cui l’obiettivo sicurezza non venga raggiunto con un suo mandato. Tra i suoi targets, la riduzione della distanza fra ricchi e poveri, un’altra piaga che accompagna Londra da centinaia di anni, ma che è probabilmente il risultato più visibile di una politica nazionale, che un semplice sindaco non può cambiare.
Anche Paddick, il socialdemocratico, scommette la propria poltrona contro un calo dei crimini, promettendo di togliere diversi privilegi agli ufficiali delle forze dell’ordine. Certo, un ex-capo di Scotland Yard ci si potrebbero aspettare grandi cose, eppure nel 2008 Paddick era arrivato solo terzo. Più contenuta Miss Jones, del partito ecologista, che “potrebbe dimettersi” nel caso in cui l’obiettivo sicurezza non venga raggiunto con un suo mandato. Tra i suoi targets, la riduzione della distanza fra ricchi e poveri, un’altra piaga che accompagna Londra da centinaia di anni, ma che è probabilmente il risultato più visibile di una politica nazionale, che un semplice sindaco non può cambiare.
Per la questione sicurezza non potevano certo mancare le Olimpiadi: Livingstone ha accusato Johnson di aver tagliato il numero delle unità di polizia di Londra di 2000 unità, una decisione sconsiderata alla luce delle Olimpiadi, un evento che potrebbe rappresentare uno obiettivo terroristico molto goloso.
Eppure quella londinese sembra una campagna elettorale priva di sostanza. Un po’ come in una finale di Champions League tra due squadre di spicco, più il livello della sfida e il traguardo sono alti, più il gioco concreto manca di consistenza. Tanto importante è la sfida londinese, tanto vuoti sono i contenuti della sfida politica tra i candidati, che si mantengono nell’ambito dei problemi più quotidiani dei cittadini e fanno promesse che (lo sanno tutti) non potranno mai risolvere veramente la situazione.
Non si rende una città più sicura blindandola, bisognerebbe capire i motivi di tanta criminalità e magari andare a risolverli alla radice. E, soprattutto, non basta conoscere la dichiarazione dei redditi di un politico per capire se può gestire una metropoli come Londra, soprattutto quando i programmi elettorali sono bicchieri vuoti e senza spessore.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il primo turno delle presidenziali di domani in Francia si prospetta come un testa a testa tra il presidente uscente Nicolas Sarkozy e lo sfidante socialista François Hollande, seguiti dagli altri due candidati dell’estrema destra e di sinistra, accreditati complessivamente del voto di circa un terzo degli elettori d’oltralpe. Mentre i sondaggi continuano a indicare una chiara vittoria di Hollande al ballottaggio, un’eventuale affermazione di Sarkozy al primo turno potrebbe dare a quest’ultimo un certo impulso per tentare una rimonta che appare ancora piuttosto complicata.
I candidati in corsa domenica per l’Eliseo saranno in tutto dieci ma, oltre ai due favoriti, gli unici in grado di incidere in qualche modo sulla competizione sono Marine Le Pen del Front National (FN), Jean-Luc Mélenchon del Front de Gauche - composto principalmente dal Partito Comunista Francese (PCF), dal Parti de Gauche (PG) e dalla Gauche Unitarie (GU) - e il centrista François Bayrou del Mouvement Démocrate (MoDem). I due candidati che otterranno il maggior numero di voti al primo turno, essendo esclusa la conquista della maggioranza assoluta, si fronteggeranno al ballottaggio, in programma il 6 maggio prossimo.
Con i consensi in salita per Marine Le Pen e Mélenchon, le ultime settimane hanno registrato una certa radicalizzazione dei toni delle campagne elettorali anche di Sarkozy e Hollande, impegnati a fare appello, rispettivamente, agli elettori più spostati a destra e a sinistra. Se il presidente ha sfruttato i recenti omicidi di Tolosa, attribuiti sbrigativamente ad un giovane francese di origini algerine giustiziato in maniera sommaria dalle forze di sicurezza transalpine, per alimentare il sentimento xenofobo e per invocare nuove misure anti-immigrazione, Hollande da parte sua ha adattato i propri discorsi sempre più alla retorica di Mélenchon, facendo proprie alcune proposte del candidato della sinistra, come l’aumento del salario minimo. Per entrambi inoltre, al centro dei loro attacchi ci sono stati puntualmente i mercati finanziari fuori da ogni controllo.
Socialista moderato, Hollande ha promesso di combinare politiche di austerity con misure per promuovere la crescita economica e ridurre le crescenti disuguaglianze nel paese, ipotizzando un possibile modesto incremento della spesa pubblica da finanziare con l’aumento della pressione fiscale sui redditi più elevati e con una tassa sulle transazioni finanziarie.
 Una posizione, quella di Hollande, che se concretizzata provocherebbe però più di una tensione nei rapporti con Berlino e metterebbe in agitazione i mercati, preoccupati per l’eventuale deviazione dalle politiche di rigore che stanno caratterizzando la gestione della crisi del debito in tutta Europa. Per questo motivo, durante la campagna elettorale, Hollande è stato bene attento a dosare il populismo con ripetuti segnali rassicuranti lanciati agli ambienti finanziari.
Una posizione, quella di Hollande, che se concretizzata provocherebbe però più di una tensione nei rapporti con Berlino e metterebbe in agitazione i mercati, preoccupati per l’eventuale deviazione dalle politiche di rigore che stanno caratterizzando la gestione della crisi del debito in tutta Europa. Per questo motivo, durante la campagna elettorale, Hollande è stato bene attento a dosare il populismo con ripetuti segnali rassicuranti lanciati agli ambienti finanziari.
Invariabilmente, i principali media europei in questi giorni parlano di mercati nervosi di fronte all’ipotesi di una vittoria di Hollande e al venir meno dell’impegno preso dalla Francia per risanare il proprio bilancio, gravato da un debito pubblico che sfiora il 90% del PIL e con un livello di spesa pubblica tra i più elevati di tutta l’Unione.
Ciò indica come i mercati non intendano transigere dalle loro richieste nemmeno in minima parte, dal momento che il programma elettorale dello stesso Hollande prevede comunque di riportare il rapporto deficit/PIL al 3% entro il 2013 e di bilanciare il budget entro il 2017, vale a dire con un solo un anno di ritardo rispetto a quanto promesso da Sarkozy.
Entrambi i candidati favoriti, poi, hanno affermato più volte di voler affrontare il problema della competitività dell’industria francese, crollata costantemente rispetto a quella tedesca nell’ultimo decennio. Su questo tema sono mancate però le proposte concrete, come è rimasta assente dal dibattito l’adozione delle nuove misure di austerity che chiedono gli ambienti finanziari, poiché esse implicano provvedimenti estremamente impopolari, a cominciare dalle cosiddette "riforme strutturali" del mercato del lavoro, secondo la classe dirigente francese necessarie per raggiungere i livelli di flessibilità proprio della vicina Germania.
Secondo alcuni osservatori, una vittoria di Hollande, assieme alla probabile ottima prestazione delle sinistre nelle elezioni parlamentari in Grecia, previste anch’esse per il 6 maggio, potrebbe innescare una reazione a catena in Europa che porterebbe ad un certo ripensamento delle politiche di rigore fortemente volute, in primo luogo, dalla cancelliera Angela Merkel. L’ipotetico cambiamento di rotta potrebbe inoltre essere suggellato da un’eventuale successo socialista nelle elezioni per il rinnovo del parlamento francese che si terranno il prossimo mese di giugno.
 Quello che appare più probabile, tuttavia, è che le promesse lanciate da Hollande, e in parte anche dallo stesso Sarkozy, come la richiesta alla BCE di fare di più per la crescita, si scontreranno da subito con una realtà ben diversa, cioè dovranno fare i conti con le pressioni dei mercati ad adottare il prima possibile misure di rigore per mantenere i bilanci sotto controllo e per deregolamentare il mercato del lavoro, come puntualmente è avvenuto, ad esempio, all’indomani del voto dello scorso anno in Spagna.
Quello che appare più probabile, tuttavia, è che le promesse lanciate da Hollande, e in parte anche dallo stesso Sarkozy, come la richiesta alla BCE di fare di più per la crescita, si scontreranno da subito con una realtà ben diversa, cioè dovranno fare i conti con le pressioni dei mercati ad adottare il prima possibile misure di rigore per mantenere i bilanci sotto controllo e per deregolamentare il mercato del lavoro, come puntualmente è avvenuto, ad esempio, all’indomani del voto dello scorso anno in Spagna.
Dopo il voto di domenica trascorreranno due settimane prima del secondo turno, durante le quali Sarkozy cercherà di rimescolare le carte per evitare di diventare l’undicesimo leader europeo ad essere sconfitto dalle urne a partire dall’esplosione della crisi del debito. Per il presidente uscente, da lunedì prossimo si porrà la questione se svoltare a destra per intercettare i voti del Front National oppure al centro per assicurarsi quelli dei moderati che sceglieranno Bayrou.
Lo stesso dilemma dovrebbe presentarsi anche per François Hollande, il quale, secondo i sondaggi, si ritroverà a sinistra un Mélenchon che uscirà dal voto con un sostanzioso consenso. La strategia dei due favoriti, in ogni caso, dipenderà verosimilmente dal risultato dei candidati che si piazzeranno alle loro spalle, anche se è probabile che opteranno per una corsa al centro, visto che al ballottaggio la gran pare dei sostenitori di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon finirà per dirottare il proprio voto su Sarkozy e Hollande, così da evitare di vedere all’Eliseo il rispettivo rivale.
