- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
Il prossimo martedì si terranno a New York le elezioni primarie dei partiti Democratico e Repubblicano per scegliere i rispettivi candidati alla poltrona di sindaco dove siede da dodici anni il magnate ultra-miliardario delle telecomunicazioni Michael Bloomberg. A guidare da qui a pochi mesi la città più popolosa degli Stati Uniti, sempre più segnata da disuguaglianze sociali e di reddito a livelli stratosferici, sarà il vincitore del voto previsto per il 5 novembre, al quale saranno ammessi coloro che prevarranno nell’eventuale ballottaggio delle primarie in programma il 1° ottobre.
L’attenzione dei media americani si sta concentrando quasi esclusivamente sulle vicende all’interno del Partito Democratico, dove la candidata meglio finanziata e ritenuta nettamente favorita fino a pochi mesi fa, la presidente del Consiglio Comunale, Christine Quinn, starebbe per andare incontro ad una clamorosa sconfitta nelle imminenti primarie. In testa ai sondaggi è schizzato al suo posto Bill de Blasio, il quale potrebbe addirittura superare la soglia del 40% delle preferenze che gli consentirebbe di evitare il ballottaggio e accedere direttamente alla sfida di novembre.
De Blasio è l’attuale “public advocate” della città di New York, una carica elettiva che dovrebbe agire da tramite tra i cittadini e l’amministrazione comunale, a cui è inoltre assegnato il ruolo di controllo sulle agenzie municipali e di indagine sulle segnalazioni degli elettori in merito a disfunzioni dei servizi pubblici.
La stampa d’oltreoceano ha definito de Blasio come il candidato più a “sinistra” tra quelli in corsa, un’immagine che il 52enne ex consigliere comunale in rappresentanza di un distretto di Brooklyn ha attentamente coltivato per cavalcare il malcontento verso le politiche di Bloomberg ampiamente diffuso tra gli abitanti della città, ad esclusione di quelli facenti parte delle fasce di reddito più elevate.
Cavalli di battaglia della campagna elettorale di de Blasio sono alcune proposte populiste che avranno ben poche possibilità di essere implementate, come quella di aumentare il carico fiscale su coloro che guadagnano più di 500 mila dollari l’anno per finanziare asili-nido e programmi dopo-scuola. A spingere de Blasio verso la nomination democratica è anche un certo gradimento fatto segnare tra le donne e, grazie alla frequente presenza in campagna elettorale della moglie afro-americana, tra l’elettorato di colore. L’ascesa di de Blasio ha rappresentato una sorta di shock per i sostenitori di Christine Quinn, a cominciare dagli ambienti di potere che hanno maggiormente beneficiato dei tre mandati di Bloomberg. La Quinn è sostenuta ufficialmente sia dal “liberal” New York Times che dal conservatore New York Post e il suo crollo nel gradimento degli elettori è facilmente spiegabile, dal momento che negli ultimi anni è stata una fedele alleata del sindaco uscente.
L’ascesa di de Blasio ha rappresentato una sorta di shock per i sostenitori di Christine Quinn, a cominciare dagli ambienti di potere che hanno maggiormente beneficiato dei tre mandati di Bloomberg. La Quinn è sostenuta ufficialmente sia dal “liberal” New York Times che dal conservatore New York Post e il suo crollo nel gradimento degli elettori è facilmente spiegabile, dal momento che negli ultimi anni è stata una fedele alleata del sindaco uscente.
In particolare, la presidente del Consiglio Comunale ha giocato un ruolo chiave nell’approvazione nel 2009 dell’impopolare soppressione del tetto massimo di due mandati alla carica di sindaco voluta dallo stesso Bloomberg, così come ha manifestato il proprio favore per l’odiata pratica della polizia newyorchese definita “stop-and-frisk”, recentemente giudicata incostituzionale da un tribunale federale e secondo la quale gli agenti hanno la facoltà di fermare e perquisire chiunque anche senza chiari sospetti che abbia commesso un qualsiasi reato.
Oltre alla Quinn e a de Blasio, gli altri tre candidati democratici che si presenteranno alle primarie di martedì sono William Thompson - unico afro-americano in corsa ed ex “comptroller” della città, battuto di misura da Bloomberg nelle elezioni del 2009 - John Liu - l’attuale “comptroller” o addetto alla supervisione dell’andamento finanziario dei vari dipartimenti cittadini - e l’ex membro della Camera dei Rappresentanti di Washington, Anthony Weiner, caduto in disgrazia per la seconda volta qualche settimana fa dopo essere stato nuovamente coinvolto in uno scandalo sessuale.
Di fronte ai gravi problemi che affliggono New York, i candidati soprattutto democratici stanno cercando di condurre una campagna elettorale fatta di slogan nei quali si sprecano gli attacchi ai poteri forti cittadini e si promette di far pagare ai ricchi il costo di iniziative che dovrebbero ridurre le disparità sociali.
I bersagli preferiti dei candidati sembrano essere specialmente i grandi costruttori newyorchesi che, dopo i momenti bui della crisi economica esplosa nel 2008, stanno beneficiando di un vero e proprio boom edilizio a Manhattan, destinato com’è ovvio solo a milionari e miliardari che possono permettersi residenze da sogno. L’emergenza abitativa che riguarda invece il resto della popolazione di New York, comunque, difficilmente verrà affrontata dal nuovo sindaco. Secondo un’indagine apparsa questa settimana sul New York Times, infatti, gli attacchi contro l’industria edilizia lanciati dai candidati democratici in campagna elettorale nascondono una realtà ben diversa. Tutti i cinque pretendenti democratici alla carica di sindaco, così come quelli repubblicani, hanno cioè incassato donazioni più o meno sostanziose dai costruttori che ora criticano apertamente.
L’emergenza abitativa che riguarda invece il resto della popolazione di New York, comunque, difficilmente verrà affrontata dal nuovo sindaco. Secondo un’indagine apparsa questa settimana sul New York Times, infatti, gli attacchi contro l’industria edilizia lanciati dai candidati democratici in campagna elettorale nascondono una realtà ben diversa. Tutti i cinque pretendenti democratici alla carica di sindaco, così come quelli repubblicani, hanno cioè incassato donazioni più o meno sostanziose dai costruttori che ora criticano apertamente.
Solo in questa tornata elettorale, questi ultimi hanno contribuito con 2,2 milioni di dollari, di cui più di 700 mila sono andati a Christine Quinn, 643 mila a Weiner, 300 mila a Thompson e 215 mila a de Blasio. Il business del mattone tende a contribuire in maniera massiccia alle campagne elettorali per le cariche cittadine, poiché questa industria a New York viene regolata in gran parte proprio dalle autorità comunali, al contrario degli altri settori che fanno riferimento invece al governo statale o federale.
Accuse e controaccuse di essere al servizio dei costruttori hanno così occupato anche buona parte dell’ultimo dibattito televisivo tra i candidati democratici andato in scena martedì. I loro legami con i poteri forti della città, così come la non dichiarata volontà di difendere gli interessi delle classi più agiate, sono apparsi poi ancora più chiari nel momento più imbarazzante e rivelatore della serata, quando i candidati non hanno praticamente avuto alcun esempio da citare in risposta ad una domanda relativa all’ultima volta nella quale si sono ritrovati in ristrettezze economiche. Tutti gli aspiranti alla successione di un sindaco che nei dodici anni alla guida del governo cittadino ha visto passare il proprio patrimonio da 5 a 27 miliardi di dollari, hanno infatti ammesso di godere di redditi a sei zeri. Nonostante la retorica, perciò, la polarizzazione sociale di New York non verrà intaccata nemmeno nei prossimi quattro anni. A fronte di un’immagine cittadina di estrema ricchezza proiettata in tutto il mondo, nella Grande Mela non risiedono, ad esempio, soltanto i 46 mila contribuenti che denunciano redditi per almeno 1 milione di dollari.
Nonostante la retorica, perciò, la polarizzazione sociale di New York non verrà intaccata nemmeno nei prossimi quattro anni. A fronte di un’immagine cittadina di estrema ricchezza proiettata in tutto il mondo, nella Grande Mela non risiedono, ad esempio, soltanto i 46 mila contribuenti che denunciano redditi per almeno 1 milione di dollari.
Quasi la metà della popolazione di Manhattan e, soprattutto, degli altri quattro “boroughs” (Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island) è classificata al di sotto della soglia ufficiale di povertà o prossima ad essa, con una realtà effettiva con ogni probabilità anche peggiore visto l’elevatissimo costo della vita che si registra rispetto al resto degli Stati Uniti.
Dopo un digiuno che dura dal 1989, i democratici dovrebbero in ogni caso tornare ad occupare la carica di primo cittadino di New York, anche se la partecipazione degli elettori, come di consueto, sarà tutt’altro che entusiastica. Già nelle elezioni del 2009 l’affluenza non arrivò nemmeno al 30%, mentre nelle primarie di martedì dovrebbe a malapena toccare il 15%.
In campo repubblicano, infine, a contendersi la nomination saranno il favorito Joseph Lhota - banchiere ed ex presidente dell’Autorità Metropolitana dei Trasporti di New York - John Catsimatidis - proprietario di una catena di supermercati - e George McDonald, fondatore di un’organizzazione no-profit per il reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti e senzatetto.
In assenza di personalità politiche del calibro di Rudolph Giuliani o ben finanziate come Michael Bloomberg, i repubblicani sembrano avere ben poche possibilità di prevalere a novembre, soprattutto perché gli elettori registrati per il loro partito nella città risultano in numero nettamente inferiore rispetto a quelli democratici.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
In seguito all’improvvisa decisione di sottoporre al Congresso americano la questione dell’attacco militare contro la Siria, la Casa Bianca ha iniziato in questi giorni una intensa campagna propagandistica per convincere i deputati e i senatori di entrambi gli schieramenti ad esprimere un parere favorevole che spiani la strada ad un nuovo conflitto in Medio Oriente.
Alla Camera e al Senato di Washington rimangono tuttavia molte perplessità ad autorizzare un’aggressione contro il regime di Damasco e solo le trattative in corso renderanno chiara l’eventuale possibilità di trovare un punto di incontro utile per i piani del presidente tra le varie posizioni emerse finora sia in campo repubblicano che democratico.
A decidere l’esito del voto che dovrebbe tenersi non prima di martedì 9 settembre, quando il Congresso riprenderà ufficialmente i lavori dopo la pausa estiva, sarà perciò il grado di convergenza che si riuscirà a raggiungere sul contenuto della risoluzione che verrà alla fine presentata in aula. L’attuale testo della richiesta di autorizzazione dell’amministrazione Obama è stato infatti criticato da una parte dei “congressmen” perché troppo vago e quindi soggetto alle consuete manipolazioni dell’apparato militare con il rischio di un coinvolgimento totale degli Stati Uniti nella crisi siriana.
Questo genere di timori sono condivisi sia dai democratici “progressisti” che dai repubblicani di tendenze libertarie e tradizionalmente su posizioni isolazioniste in merito alle questioni di politica estera riguardanti il proprio paese.
Uomini simbolo di quest’ultima fazione sono attualmente i senatori Ted Cruz del Texas e, soprattutto, Rand Paul del Kentucky, figlio del più volte candidato alla presidenza, Ron Paul, e già osannato dalla destra repubblicana nel recente passato per avere condotto una serie di battaglie libertarie contro l’invadenza del governo federale nelle vite dei cittadini americani.
Più in generale, la leadership repubblicana di Camera e Senato, così come nelle principali commissioni dei due rami del Congresso, dovrà con ogni probabilità fare i conti con un numero consistente di agguerriti parlamentari che vedono con estremo sospetto ogni nuova avventura bellica degli Stati Uniti all’estero e che cercano in tutti i modi di bloccare le iniziative della Casa Bianca.
Il fatto che la destra libertaria repubblicana sia in grado di intercettare un più che giustificato malessere diffuso nella società americana, riuscendo a proporsi come unico baluardo contro una nuova guerra impopolare, è dovuto in ogni caso alla totale assenza di una qualsiasi forma di mobilitazione alla sinistra dello schieramento politico americano contro l’aggressione alla Siria.
Su questa frangia repubblicana, molto vicina ai Tea Party, finiranno così per essere esercitate le maggiori pressioni sia da parte della Casa Bianca che dei media e dell’altra fazione del partito, composta tradizionalmente da deputati e senatori che appoggiano una politica estera aggressiva, in parte per onorare i forti legami che molti di essi mantengono con la potente lobby israeliana negli Stati Uniti.
Anche questi ultimi, tuttavia, stanno mostrando per il momento una certa cautela nei confronti della richiesta dell’amministrazione Obama, in attesa di ottenere chiarimenti e conferme sulla presunta inevitabilità dell’attacco contro la Siria. Su queste esitazioni influisce soprattutto il precedente dell’invasione dell’Iraq di cui i “neo-con” furono gli artefici e che costò enormemente al proprio partito in termini di credibilità e di risultati elettorali.
Con la corsa alle presidenziali del 2016 alle primissime battute, inoltre, a parte i consueti guerrafondai come i senatori John McCain o Lindsey Graham, sono pochi i repubblicani di spicco a volersi compromettere del tutto con un delicatissimo conflitto che potrebbe facilmente sfociare in una guerra devastante con il coinvolgimento di varie potenze regionali e planetarie.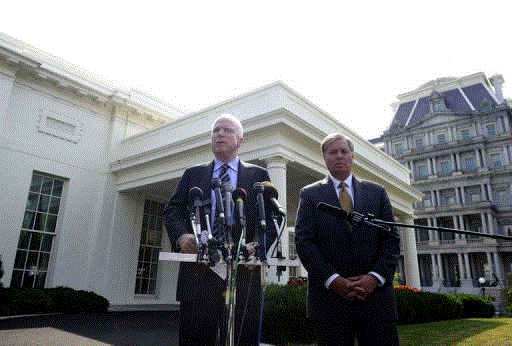 Proprio i due senatori di Arizona e South Carolina sono stati protagonisti questa settimana dell’endorsement più convinto al progetto bellico di Obama in Siria. Dopo un incontro alla Casa Bianca, i falchi McCain e Graham hanno annunciato il loro voto a favore dell’autorizzazione all’uso della forza per “punire” Assad, non prima però di avere ricevuto assicurazioni dal presidente democratico circa un imminente rafforzato impegno americano nell’assistere i “ribelli” siriani.
Proprio i due senatori di Arizona e South Carolina sono stati protagonisti questa settimana dell’endorsement più convinto al progetto bellico di Obama in Siria. Dopo un incontro alla Casa Bianca, i falchi McCain e Graham hanno annunciato il loro voto a favore dell’autorizzazione all’uso della forza per “punire” Assad, non prima però di avere ricevuto assicurazioni dal presidente democratico circa un imminente rafforzato impegno americano nell’assistere i “ribelli” siriani.
La coppia repubblicana avrebbe così rinunciato ad un’aggressione a tutto campo contro la Siria, accettando invece un attacco “limitato” che, però, a loro dire dovrebbe comunque danneggiare significativamente le strutture difensive e le capacità di offendere del regime di Damasco.
Il testo definitivo della risoluzione sulla quale si esprimerà settimana prossima il Congresso USA dovrà quindi tenere in considerazione sia i dubbi di coloro che sono disposti a dare il via libera soltanto ad un’operazione di basso profilo sia i più convinti interventisti alla McCain che hanno subordinato un voto favorevole alla prospettiva di assestare un colpo mortale alle forze di Assad. Se queste due interpretazioni sembrano a prima vista inconciliabili, è probabile che la richiesta di autorizzazione all’uso della forza avrà un linguaggio sufficientemente vago per dare mano libera alla Casa Bianca sulla gestione dell’attacco che si sta preparando.
Contraddizioni e divisioni sembrano però ancora marcate per il momento, come dimostra il lavoro della commissione Affari Esteri del Senato, guidata dal democratico Robert Menendez, che sta preparando una bozza con alcuni paletti da imporre all’azione USA, tra cui i divieti di inviare truppe in territorio siriano e di fissare come obiettivo dell’operazione il cambio di regime a Damasco. Questi limiti potrebbero però essere soltanto fumo negli occhi, dal momento che lo stesso pretesto delle armi chimiche è stato fabbricato ad arte per giustificare un intervento che abbia lo scopo preciso di ribaltare le sorti del conflitto in Siria e, quanto meno, facilitare la presa del potere delle formazioni “ribelli” finanziate e armate dall’Occidente e da svariati paesi mediorientali.
Non a caso, ciò che spicca dal dibattito avviato in questi giorni in vista del voto del Congresso è l’accettazione pressoché totale da parte dei politici di ogni orientamento delle conclusioni avanzate dall’amministrazione democratica circa le responsabilità dell’attacco con armi chimiche avvenuto a Ghouta, nei pressi di Damasco, il 21 agosto scorso.
In una serie di incontri avviati nel fine settimana tra membri del governo e del Congresso nell’ambito di un’offensiva propagandista denominata “flood the zone”, l’amministrazione Obama sembra avere convinto quasi tutti i propri interlocutori presentando “prove” della colpevolezza di Assad che consisterebbero in conversazioni intercettate tra esponenti del regime, post apparsi su svariati social media nelle ore successive all’attacco e filmati in gran parte apparsi su YouTube e girati dai “ribelli” stessi. Per stessa ammissione della Casa Bianca, tra le “prove” in proprio possesso non ci sono invece campioni raccolti sul terreno per verificare la presenza effettiva di agenti chimici nell’area colpita due settimane fa.
Nonostante quest’ultima ammissione tutt’altro che trascurabile, come ha spiegato al New York Times il deputato democratico della California, Adam Schiff, il dibattito al Congresso si è ormai spostato dalla questione della effettiva responsabilità di Assad, per nulla dimostrata, a quella delle misure da adottare per rispondere all’attacco di Ghouta. D’altra parte, anche i membri del Congresso più tiepidi nei confronti di Obama in gran parte non mettono in discussione la versione della Casa Bianca, né tantomeno la presunta autorità morale autoassegnatasi dagli USA per punire il ricorso ad armi chimiche di un qualsiasi paese. Essi, bensì, valutano troppo rischioso un intervento in Medio Oriente che avrebbe effetti destabilizzanti sull’intera regione con conseguenze negative per gli interessi americani o, tutt’al più, fanno riferimento alle tendenze isolazioniste di certi ambienti repubblicani che non vedono alcun vantaggio per il proprio paese nella partecipazione a qualsiasi guerra oltreoceano.
D’altra parte, anche i membri del Congresso più tiepidi nei confronti di Obama in gran parte non mettono in discussione la versione della Casa Bianca, né tantomeno la presunta autorità morale autoassegnatasi dagli USA per punire il ricorso ad armi chimiche di un qualsiasi paese. Essi, bensì, valutano troppo rischioso un intervento in Medio Oriente che avrebbe effetti destabilizzanti sull’intera regione con conseguenze negative per gli interessi americani o, tutt’al più, fanno riferimento alle tendenze isolazioniste di certi ambienti repubblicani che non vedono alcun vantaggio per il proprio paese nella partecipazione a qualsiasi guerra oltreoceano.
Il tentativo di Obama di ottenere l’approvazione del Congresso per l’aggressione contro la Siria, in definitiva, come dimostra il dibattito in corso non rappresenta altro che un modo per ottenere una qualche apparenza di legittimità per un’operazione illegale basata su fondamenta che sono crollate miseramente già nei giorni scorsi, spingendo il presidente a prendere atto dell’impossibilità di mettere assieme una coalizione sufficientemente ampia a livello internazionale ma anche dell’indisponibilità degli alleati di Assad ad astenersi da ritorsioni in caso di attacco su vasta scala contro Damasco.
Dal tunnel in cui egli stesso si è infilato, perciò, il presidente americano ha deciso di provare ad uscire con una manovra per la quale ha optato con ogni probabilità in fretta e furia, nella speranza di ottenere un qualche mandato per agire senza troppi vincoli pur di fronte ad una vasta opposizione popolare.
La decisione finale sull’eventuale attacco alla Siria e sulla sua portata verrà presa comunque dalla Casa Bianca in base alle circostanze che si verranno a creare nei prossimi giorni sia sul fronte interno che internazionale, come conferma il fatto che la stessa amministrazione Obama continua a non escludere la possibilità di procedere con un’operazione militare unilaterale e palesemente illegale anche in caso di voto contrario del Congresso americano.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Michele Paris
di Michele Paris
La frenata del presidente Obama sull’aggressione militare contro la Siria, in attesa dell’autorizzazione del Congresso americano, è la diretta conseguenza della totale illegalità della nuova guerra in Medio Oriente che si prospetta e del crollo repentino della credibilità delle accuse rivolte al regime di Assad circa l’attacco con armi chimiche avvenuto nei pressi di Damasco il 21 agosto scorso.
Se gli ostacoli incontrati dalla Casa Bianca nella programmazione dell’ennesima avventura bellica oltreoceano hanno ritardato l’inizio delle operazioni, la risolutezza di Washington nel colpire obiettivi in territorio siriano non sembra essere venuta meno, nonostante stia emergendo più di un indizio sulla possibile responsabilità degli stessi “ribelli” nei fatti di Ghouta che hanno causato centinaia di morti.
L’indagine giornalistica più circostanziata in questo senso è stata finora quella pubblicata dalla testata americana Mint Press News (MPN) con sede a Minneapolis, nel Minnesota, e condotta da Dale Gavlak - già corrispondente della Associated Press, ma anche di BBC e della National Public Radio americana - e Yahya Ababneh, un reporter giordano che ha raccolto interviste e testimonianze sul campo in Siria.
Secondo quanto riportato qualche giorno fa, alcuni gruppi “ribelli” avrebbero ricevuto le armi chimiche utilizzate il 21 agosto dai servizi segreti sauditi, guidati dal principe Bandar bin Sultan, per decenni ambasciatore di Riyadh negli Stati Uniti dove ha coltivato strettissimi rapporti con l’apparato militare e dell’intelligence americano. Bandar è uno più accesi sostenitori dell’opposizione anti-Assad in Siria e, recentemente, è stato protagonista di una visita a Mosca dove, tra l’altro, avrebbe prospettato alla Russia futuri attentati terroristici nel caso il Cremlino continuasse a rifiutare uno sganciamento dal regime di Damasco.
Tra le interviste pubblicate da MPN spicca quella con il padre di un “ribelle” siriano ucciso assieme ad altri 12 compagni all’interno di un “tunnel utilizzato per lo stoccaggio di armi fornite da un guerrigliero saudita a capo di un battaglione” anti-Assad. I decessi sarebbero avvenuti il giorno del presunto attacco a Ghouta in seguito all’impiego forse involontario di queste armi che i “ribelli” non sapevano fossero equipaggiate con sostanze chimiche. Secondo un anonimo “ribelle”, infatti, alcuni guerriglieri avrebbero “maneggiato impropriamente le armi, scatenando una serie di esplosioni”. Se tale versione dovesse corrispondere al vero, sarebbe confermata l’ipotesi di molti - tra cui il governo russo - secondo la quale i “ribelli” appoggiati dall’Occidente e dalle dittature sunnite del Golfo Persico avrebbero inscenato un attacco con armi chimiche o, quanto meno, erano sul punto di mettere in atto un’azione di questo genere quando ha avuto luogo un’esplosione inavvertita, incolpando poi dell’accaduto il regime di Damasco.
Se tale versione dovesse corrispondere al vero, sarebbe confermata l’ipotesi di molti - tra cui il governo russo - secondo la quale i “ribelli” appoggiati dall’Occidente e dalle dittature sunnite del Golfo Persico avrebbero inscenato un attacco con armi chimiche o, quanto meno, erano sul punto di mettere in atto un’azione di questo genere quando ha avuto luogo un’esplosione inavvertita, incolpando poi dell’accaduto il regime di Damasco.
Se il resoconto di MPN è stato messo in dubbio da qualche commentatore che ha sottolineato come il fondatore della testata di Minneapolis abbia “simpatie sciite”, questa ricostruzione proposta per i fatti di Ghouta appare del tutto plausibile visti i precedenti dei “ribelli” e la posta in gioco in Siria.
Non solo. Anche il giornale tedesco Die Tageszeitung ha collegato in qualche modo l’uso di armi chimiche ai “ribelli”, come dimostrerebbe una conversazione telefonica intercettata e postata su Facebook tra un membro del cosiddetto Fronte al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, ed un suo finanziatore residente in Qatar. In essa, il militante integralista in questione cerca di dare rassicurazioni circa la capacità del suo gruppo di sferrare un attacco per riprendere la città di Homs, informando ad un certo punto il proprio interlocutore come i suoi uomini abbiano “usato armi chimiche”. Dopo una pausa, quest’ultimo afferma di essere già a conoscenza dei fatti e chiede le informazioni necessarie per effettuare un trasferimento di denaro all’organizzazione estremista.
Come facilmente prevedibile, nessun organo di stampa ufficiale ha provato a fare chiarezza su queste notizie, preferendo invece allinearsi alla tesi sostenuta dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Occidente e nel mondo arabo, secondo la quale esisterebbe la certezza pressoché assoluta della responsabilità del regime di Assad o, per lo meno, di una fazione al suo interno. Secondo questa versione, inoltre, i “ribelli” non avrebbero le capacità o i mezzi per condurre un’operazione con armi chimiche, nonostante sia ben documentata l’assistenza fornita loro da esperti militari americani e gli armamenti sofisticati che provengono dai governi dei paesi mediorientali alleati di Washington.
La scorsa primavera, oltretutto, erano già stati segnalati alcuni episodi nei quali veniva ipotizzato l’uso di armi chimiche, soprattutto in un’occasione nei pressi di Aleppo in seguito alla quale lo stesso regime di Assad aveva chiesto alle Nazioni Unite di indagare. Una speciale commissione sulla Siria aveva successivamente lasciato intendere di avere individuato i responsabili proprio nei “ribelli” stessi e, in particolare, un suo autorevole membro - l’ex giudice del Tribunale Penale Internazionale Carla Del Ponte - aveva affermato in un’intervista che erano emerse prove “quasi certe” dell’uso di armi chimiche da parte dei gruppi armati dell’opposizione.
Queste dichiarazioni sarebbero state in grandissima parte occultate dalla stampa ufficiale, assieme ad un’altra notizia che contraddice coloro che sostengono come i “ribelli” non abbiano alcuna disponibilità di armi chimiche. Nel mese di maggio, infatti, la stampa turca aveva riportato dell’arresto di alcuni militanti del Fronte al-Nusra in una località di confine con la Siria nelle cui abitazioni era stata rinvenuta una certa quantità di gas sarin.
Ad alimentare i sospetti circa di fatti di Ghouta sono infine alcuni resoconti che in questi giorni descrivono come le forze dell’opposizione anti-Assad siano state informate nei giorni immediatamente precedenti al 21 agosto di una imminente escalation militare nei confronti del regime di Damasco in seguito a sviluppi che avrebbero determinato un cambiamento degli scenari del conflitto in corso da oltre due anni nel paese mediorientale. L’intelligence di paesi come Turchia e Qatar avrebbe quindi assicurato ai comandanti delle brigate attive in Siria l’imminente arrivo di ingenti forniture di armi per mettere in atto un’offensiva contro le forze regolari. L’attacco con armi chimiche a Ghouta, dunque, potrebbe essere stata un’azione programmata tra i “ribelli” e i loro sponsor occidentali e arabi, da utilizzare poi come pretesto per giustificare un intervento militare contro Assad. Questo modus operandi volto a fuorviare l’opinione pubblica, d’altra parte, in passato è stato utilizzato dall’imperialismo a stelle e strisce in svariate occasione, dal Vietnam all’Iraq.
L’intelligence di paesi come Turchia e Qatar avrebbe quindi assicurato ai comandanti delle brigate attive in Siria l’imminente arrivo di ingenti forniture di armi per mettere in atto un’offensiva contro le forze regolari. L’attacco con armi chimiche a Ghouta, dunque, potrebbe essere stata un’azione programmata tra i “ribelli” e i loro sponsor occidentali e arabi, da utilizzare poi come pretesto per giustificare un intervento militare contro Assad. Questo modus operandi volto a fuorviare l’opinione pubblica, d’altra parte, in passato è stato utilizzato dall’imperialismo a stelle e strisce in svariate occasione, dal Vietnam all’Iraq.
A fronte di tutti i dubbi sulle reali responsabilità dell’attacco con armi chimiche a Ghouta e dell’assenza di prove certe presentate da Washington a sostegno della propria tesi, il dibattito in corso sui media ufficiali continua ad essere incentrato su altre questioni, come l’efficacia di un’azione militare “limitata” in Siria oppure i rischi di natura politica a cui Obama andrebbe incontro con un intervento condotto senza la collaborazione dei tradizionali alleati o, addirittura, in assenza di un voto favorevole del Congresso di Washington.
Fuori dal dibattito rimangono invece regolarmente le vere motivazioni di natura strategica che stanno alla base dell’iniziativa americana, così come la totale mancanza di autorità morale degli Stati Uniti nel decidere di punire un paese che si sia reso eventualmente responsabile di un attacco con armi chimiche contro il proprio popolo.
Se anche ciò fosse accaduto in Siria - e i fatti emersi finora non sembrano confermarlo - gli USA si assumerebbero il compito di colpire i presunti responsabili pur essendo di fatto i principali trasgressori del diritto internazionale, essendo stati protagonisti solo nell’ultimo decennio dell’invasione illegale e della distruzione di un paese sovrano, dell’uso di fosforo bianco e uranio impoverito contro popolazioni civili, di torture e rendition su vastissima scala e, come è stato rivelato in questi mesi, della messa in atto di programmi di sorveglianza di massa per tenere sotto controllo ogni minaccia contro i propri interessi sia sul fronte domestico che su quello globale.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Fabrizio Casari
di Fabrizio Casari
Ha deciso di attaccare, però ascolterà prima il Congresso. Parola di Barak Obama. Che significa, né più né meno, che o la decisione è sottoponibile a mutamento, o il Congresso non ha il potere di mutarla. Insomma la confusione regna sovrana alla Casa Bianca. Tra un Segretario di Stato e un Presidente che parlano prima di riflettere, gli Stati Uniti sono in difficoltà.
Più che la determinazione della Siria, sulla quale fanfaroneggia Assad, sono lo stop del Parlamento britannico alle ansie guerriere di Cameron e la decisione dell’Italia di attenersi alle risoluzioni delle Nazioni Unite che lasciano Washington con il cerino in mano. Washington in Europa è sorretta solo dalla Francia, che però in Medio Oriente ha storicamente il riflesso incondizionato dei Mirage, in assenza di una politica.
Senza il consenso dell’Onu e della Lega Araba e non potendo utilizzare la Nato, l’appoggio della Turchia di Erdogan, di Israele e degli Emirati del Golfo ad un eventuale aggressione alla Siria non intacca, infatti, l’unilateralità della decisione statunitense. Obama si trova però in difficoltà: è andato troppo avanti per non lanciare i missili ma è in ritardo per quanto attiene alla capacità di reazione rapida ed alla capacità di costruire una coalizione che l’accompagni nell’avventura.
Coalizione che non sarà semplice da costituire. Le cosiddette prove che Kerry, emulando il Colin Powell che si prendeva gioco del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, spaccia senza pudore nelle ormai quotidiani incontri con la stampa, sono persino poco credibili sotto il profilo statistico e, con tutta evidenza, fanno parte della propaganda destinata ad ottenere il consenso dell’opinione pubblica statunitense. Che però al momento, al pari di quella europea, non ritiene affatto utile l’inizio di una nuova guerra mediorientale, possibile inizio di una tragedia di proporzioni più vaste ed effetti incontrollabili.
G ioca un ruolo decisivo, nella freddezza europea verso Washington, la consapevolezza di quanti e quali siano stati gli errori di Obama nell’appoggiare prima le cosiddette primavere arabe per poi accettare che fossero represse nel sangue, dal Barhein all’Egitto. Il risultato é che alla fine si è privato della stabilità l’insieme politico regionale ed aperto un quadro d’incertezza e di difficilissimi equilibri e tensioni che possono trasformare facilmente l’area in una polveriera.
ioca un ruolo decisivo, nella freddezza europea verso Washington, la consapevolezza di quanti e quali siano stati gli errori di Obama nell’appoggiare prima le cosiddette primavere arabe per poi accettare che fossero represse nel sangue, dal Barhein all’Egitto. Il risultato é che alla fine si è privato della stabilità l’insieme politico regionale ed aperto un quadro d’incertezza e di difficilissimi equilibri e tensioni che possono trasformare facilmente l’area in una polveriera.
Non sfugge del resto a nessuno che Mosca ritiene la caduta di Damasco una minaccia alla sua presenza nell’area e, di conseguenza, un diretto rinvigorimento della minaccia islamica fin nel Caucaso. La base russa di Taurus è ormai l’unico punto strategico per Mosca in una regione ormai ostile. Allo stesso tempo è perfettamente chiaro a Teheran come la caduta dell’alleato siriano - cui seguirebbe quella di Hezbollah in Libano - sarebbe destinata ad isolare e rendere più vulnerabile l’Iran, che si ritroverebbe così isolata e circondata.
Peraltro il regime iraniano non può permettersi di rimanere inerte mentre i suoi alleati ( e in qualche modo il suo cuscinetto difensivo esterno) vengono attaccati. Per lo Stato persiano significherebbe perdere ruolo regionale e credibilità interna ed internazionale e, con la messa a nudo dei suoi limiti politici e militari, comincerebbe il conto alla rovescia per la resa dei conti con Israele e Stati Uniti.
Quanto alle accuse statunitensi alla Siria, non s’intravvede un briciolo di coerenza. Non c’è nessuna questione relativa ai diritti umani che i carnefici di Guantanamo e delle renditions possono rivendicare, così come non può esserci credibilità in nessuna condanna all’uso di armi chimiche da parte di chi ha ordinato, nel corso della storia recente, l’uso indiscriminato di napalm e di fosforo bianco sulle popolazioni civili senza battere ciglio.
Altro che preoccupazioni umanitarie. L’attacco alla Siria si rende semmai inevitabile, per l’Occidente, a causa della situazione sul terreno, dove i ribelli sono in serie difficoltà militari e in preda ad una decisa divisione politica. La prima è determinata dalla controffensiva militare dell’esercito regolare di Assad che, aiutato dalle milizie degli Hezbollah libanesi, ha riconquistato città e punti strategici, interrompendo l’ampliamento delle zone conquistate e riducendo le roccaforti dei ribelli ad enclave. Il cammino verso Damasco da parte dei ribelli è al momento una pia illusione. La seconda è il risultato dello sconto interno tra i ribelli dell’esercito libero siriano - sostenuto da britannici, americani e francesi - e le bande terroristiche (zeppe di mercenari venuti da tutta la regione e non solo) dirette da Al Nusra, emanazione diretta di al-Queda, e foraggiate dall’Arabia Saudita e dal Qatar, pure in conflitto tra loro per via della vicenda egiziana, con Ryad a sostegno di Al Sisi e il Qatar al lato di Morsi. Parte delle incertezze americane ed europee risiedono proprio qui; la parte del leone nella guerriglia la svolgono i quesiti e avvantaggiarli con un attacco devastante su aviazione e basi lealiste potrebbe rivelarsi a breve-medio termine un boomerang.
La seconda è il risultato dello sconto interno tra i ribelli dell’esercito libero siriano - sostenuto da britannici, americani e francesi - e le bande terroristiche (zeppe di mercenari venuti da tutta la regione e non solo) dirette da Al Nusra, emanazione diretta di al-Queda, e foraggiate dall’Arabia Saudita e dal Qatar, pure in conflitto tra loro per via della vicenda egiziana, con Ryad a sostegno di Al Sisi e il Qatar al lato di Morsi. Parte delle incertezze americane ed europee risiedono proprio qui; la parte del leone nella guerriglia la svolgono i quesiti e avvantaggiarli con un attacco devastante su aviazione e basi lealiste potrebbe rivelarsi a breve-medio termine un boomerang.
In questo quadro è plausibile ritenere che la anche la carta sempre considerata di ripiego, come la soluzione politica proposta da Damasco e costantemente rifiutata dai ribelli e dai loro sponsor, aldilà della propaganda del regime non avrebbe a questo punto senso, visti i mutamenti della situazione militare sul terreno che spingerebbero ormai Assad a ritenere la vittoria militare definitiva quale unica soluzione politica possibile.
E un’eventuale vittoria di Assad non solo avrebbe ripercussioni politiche importanti in tutta l’area, ma ricaccerebbe definitivamente indietro il progetto occidentale di appropriarsi della Siria allo scopo di utilizzarla come terreno sul quale far passare un oleodotto per la fornitura del gas alternativo a quello di marca russa, privando così Mosca di una sua centralità nelle forniture energetiche all’intera Europa.
Alla Casa Bianca, però, non si riesce a trovare una soluzione che spinga Assad nell’angolo e, contemporaneamente, non costringa Obama a fare la figura di un presidente velleitario. Come uscirne? O la commissione di esperti ONU riferisce di una totale assenza di prove contro Damasco per l’uso di armi chimiche, oppure un attacco dovrà partire. Ma come evitare d’incendiare tutta la regione? Si dovrà probabilmente a cercare una soluzione militare che dimostri come anche Obama sa osservare il ruolo di prefetto mondiale e, allo stesso tempo, a non affondare il colpo oltre la soglia accettabile per Assad che farebbe scattare una risposta generalizzata sul piano regionale.
In assenza dunque di un soprassalto di ragione da parte della Casa Bianca o di un pronunciamento netto da parte del Congresso Usa (che potrebbe voler mettere Obama alle corde), nell’impossibilità di vedere il presidente umiliato la risposta militare yankee arriverà. A questo si riferisce Kerry quando ricorda che, Congresso o no, il "comandante in capo" ha deciso. Forse però un attacco mirato, breve e non durissimo, consentirebbe ad Obama di sostenere che risposta c’è stata e, contemporaneamente, a far dire ad Assad che lui è il primo presidente arabo a saper resistere ad un attacco USA. Due attori per una brutta commedia di fine estate. Ma è meglio vedere un brutto film che assistere ad una guerra.
- Dettagli
- Scritto da Administrator
- Categoria principale: Articoli
- Categoria: Esteri
 di Mario Lombardo
di Mario Lombardo
I compensi garantiti agli amministratori delegati più pagati delle grandi compagnie americane continuano a far segnare livelli da record nonostante la crisi economica di questi anni. Ad analizzare il divario sempre più marcato tra i redditi dei top manager d’oltreoceano e quelli dei loro sottoposti è stato uno studio pubblicato questa settimana da un “think tank” di Washington, nel quale viene messo in luce come la quantità di denaro incassata dai primi sia spesso svincolata dalle prestazioni delle aziende che dirigono.
Il rapporto dell’Institute for Policy Studies (IPS) è intitolato “Executive Excess: Bailed Out, Booted, and Busted” e prende in considerazione le performance di oltre duecento “chief executives” compresi almeno una volta negli ultimi due decenni nella lista dei più pagati degli Stati Uniti. Secondo l’IPS, quasi il 40% di essi avrebbe visto incrementare il proprio conto corrente con cifre a sei zeri dopo avere prodotto risultati estremamente modesti o addirittura disastrosi alla guida di una determinata compagnia.
L’esito dello studio conferma perciò come uno dei principi fondamentali del capitalismo - vale a dire l’ottenimento di gratifiche più o meno sostanziose in conseguenza di risultati positivi - venga in molti casi contraddetto proprio ai vertici del sistema stesso.
In particolare, il gruppo di studio americano ha distinto tre categorie di “CEO” non particolarmente brillanti ma ugualmente ricoperti di dollari: quelli la cui azienda è stata salvata dall’intervento del governo federale (“bailed out”), quelli sollevati dal loro incarico (“booted) e quelli alla guida di compagnie che hanno dovuto pagare sanzioni per avere violato la legge (“busted”).
Della seconda categoria, ad esempio, fanno parte amministratori delegati che in media hanno incassato buone uscite da 48 milioni di dollari, mentre le aziende implicate in procedimenti legali hanno sborsato qualcosa come 100 milioni ciascuna per liquidare i propri top manager.
Secondo il campione analizzato dall’IPS, l’amministratore delegato meglio retribuito nonostante il licenziamento sarebbe Eckhard Pfeiffer, allontanato nel 1999 dalla compagnia informatica Compaq (acquistata nel 2002 da HP) con “stock options” pari a 410 milioni di dollari ed una liquidazione di 6 milioni dopo sette anni di profitti in declino. La testata Business Insider avrebbe successivamente inserito Pfeiffer nella lista dei 15 peggiori CEO della storia.
Lo studio elenca poi 17 istituti finanziari - tra cui Morgan Stanley, AIG, JPMorgan, Wells Fargo e il defunto Lehman Brothers - che pur avendo ricevuto quasi 258 miliardi di dollari in fondi pubblici hanno complessivamente portato ben 112 dei loro dirigenti nella lista dei 25 CEO più pagati tra il 1993 e il 2012. Proprio l’ex CEO di Lehman Brothers, Richard Fuld, ha goduto per otto anni consecutivi di compensi tra i più generosi di Wall Street, toccando punte superiori ai 100 milioni di dollari nel 2001 e nel 2005, prima di contribuire nel 2008 a fare entrare la sua compagnia nella storia con il più clamoroso crack a cui il sistema finanziario americano abbia finora assistito.
Proprio l’ex CEO di Lehman Brothers, Richard Fuld, ha goduto per otto anni consecutivi di compensi tra i più generosi di Wall Street, toccando punte superiori ai 100 milioni di dollari nel 2001 e nel 2005, prima di contribuire nel 2008 a fare entrare la sua compagnia nella storia con il più clamoroso crack a cui il sistema finanziario americano abbia finora assistito.
Gli autori dell’indagine hanno così concluso che “un numero allarmante di amministratori delegati si dimostra incapace di aggiungere valore all’economia americana, mentre da essa al contrario ne ricava somme ingenti”. In altre parole, i massimi dirigenti delle grandi compagnie d’oltreoceano non sono altro che una ristretta élite parassitaria che presiede e beneficia di un colossale trasferimento di ricchezza a discapito delle classi inferiori, senza creare quasi mai alcun beneficio per l’economia del proprio paese.
Infatti, secondo i dati raccolti dal sindacato AFL-CIO, i compensi dei “CEO” americani sono aumentati del 5% solo tra il 2011 e il 2012, a fronte di una diminuzione del reddito medio complessivo dello 0,4% tra il 2009 e il 2011.
Ancora più drammatiche sono poi le disuguaglianze di reddito prodotte negli ultimi vent’anni. Se nel 1993 i salari dei massimi dirigenti negli USA erano circa 195 volte superiori a quelli dei lavoratori medi, tale rapporto è salito nel 2012 a 354 volte.
L’IPS indica infine alcuni provvedimenti bloccati al Congresso che dovrebbero servire a limitare i compensi eccessivi dei top manager americani. Alcuni di essi avrebbero dovuto essere già stati implementati in seguito all’approvazione della cosiddetta legge “Dodd-Frank” del 2010, definita dalla versione ufficiale come una “riforma” del sistema finanziario adottata per evitare altri tracolli simili a quello dell’autunno del 2008. Tra le misure che il think tank statunitense ritiene possano risultare utili a questo proposito vi sono l’obbligatorietà della pubblicazione del rapporto tra le retribuzioni dei CEO e degli altri lavoratori di un’azienda, la fissazione di limiti ai compensi garantiti ai manager dei grandi istituti finanziari e la drastica limitazione delle deduzioni fiscali sui costi dei compensi stessi che le grandi aziende possono ottenere dal governo.
Tra le misure che il think tank statunitense ritiene possano risultare utili a questo proposito vi sono l’obbligatorietà della pubblicazione del rapporto tra le retribuzioni dei CEO e degli altri lavoratori di un’azienda, la fissazione di limiti ai compensi garantiti ai manager dei grandi istituti finanziari e la drastica limitazione delle deduzioni fiscali sui costi dei compensi stessi che le grandi aziende possono ottenere dal governo.
Queste ed altre leggi proposte da varie parti avrebbero in ogni caso un effetto limitato e, comunque, la loro mancata approvazione nonostante il larghissimo sostegno ad esse della popolazione americana dimostra ancora una volta come la politica di Washington risponda esclusivamente agli interessi della classe di cui gli stessi amministratori delegati multi-milionari fanno parte.
L’allargamento della forbice dei redditi e il continuo aumentare dei compensi ai vertici delle grandi aziende di fronte al generale impoverimento di massa in atto non sono d’altra parte il risultato di forze impersonali o ineluttabili, bensì dell’azione deliberata di una classe politica che è espressione unica delle élite economico e finanziarie e alla quale l’Institute for Policy Studies, così come commentatori e intellettuali “liberal” negli Stati Uniti e non solo, continua a chiedere ingenuamente una riforma in senso progressista dell’intero sistema.
