- Dettagli
 La tregua mediata dall’Egitto tra Hamas e Israele potrebbe essere annunciata ufficialmente questa settimana. A riferirlo sono state fonti palestinesi vicine al movimento islamico palestinese, secondo le quali la delegazione egiziana avrebbe raggiunto una intesa in due fasi: la prima, iniziata domenica, rappresentata da alcuni “gesti di buona volontà” d’Israele; la seconda, che scatterà quando sarà formato il nuovo governo israeliano, relativa alle questioni più spinose che riguardano la Striscia.
La tregua mediata dall’Egitto tra Hamas e Israele potrebbe essere annunciata ufficialmente questa settimana. A riferirlo sono state fonti palestinesi vicine al movimento islamico palestinese, secondo le quali la delegazione egiziana avrebbe raggiunto una intesa in due fasi: la prima, iniziata domenica, rappresentata da alcuni “gesti di buona volontà” d’Israele; la seconda, che scatterà quando sarà formato il nuovo governo israeliano, relativa alle questioni più spinose che riguardano la Striscia.
- Dettagli
- Scritto da Margine Gutierrez
 MANAGUA. Di sinistra da giovane e ora vecchi di destra? Si dice sia un attitudine quasi inevitabile essere rivoluzionari da giovani e diventare di destra invecchiando. Non ci credo. Ciò annida solo negli opportunisti incalliti, che si comportano così secondo le circostanze. Non sono i principi né i valori che forgiano la coscienza di ognuno, la bussola che li orienta. Quasi sempre giustificano le proprie azioni con il trito e ritrito refrain che bisogna essere pragmatici.
MANAGUA. Di sinistra da giovane e ora vecchi di destra? Si dice sia un attitudine quasi inevitabile essere rivoluzionari da giovani e diventare di destra invecchiando. Non ci credo. Ciò annida solo negli opportunisti incalliti, che si comportano così secondo le circostanze. Non sono i principi né i valori che forgiano la coscienza di ognuno, la bussola che li orienta. Quasi sempre giustificano le proprie azioni con il trito e ritrito refrain che bisogna essere pragmatici.
Ce ne sono in abbondanza di quanti e quante si sono arricchiti in forma smisurata, non per il proprio onorato lavoro giacché questo non genera mai ricchezza, quanto piuttosto per le loro grandi capacità di appropriarsi di beni dello Stato; per sistemarsi nel bilancio pubblico in distinti incarichi negli anni 90 e per fondare associazioni senza fini di lucro la cui gestione fraudolenta gli ha procurato dei buoni utili. Quando non ci furono più possibilità di maggiore ricchezza, poco a poco si allinearono sulla parte opposta. Hanno continuato così ricevendo i loro bei dollari, facendo l'unica cosa che hanno sempre potuto fare.
Con una retorica da pseudo-sinistra e con abbondanti finanziamenti esterni hanno viaggiato dappertutto in vari forum mondiali; hanno menato vanto delle loro intime relazioni con alcuni leader latinoamericani considerati di sinistra e dal 2007 – o forse da prima – nei loro molteplici viaggi denunciano l'esistenza in Nicaragua di una dittatura secondo la loro incapacità per definire meglio la situazione.
Non era passato neanche un giorno che l'attuale governo si fosse insediato, che gli avevano già affibbiato il marchio di “dittatura”. Tutto questo – sicuramente in modo consapevole – gli è ampiamente servito per mettersi sul mercato e offrirsi come una buona pedina al servizio dei poteri imperiali. Opporsi visceralmente al canale è stata la consacrazione di una posizione che è passata dalla dissidenza alla più accanita e irascibile opposizione, in combutta con i contras, con somozisti e con la destra più reazionaria e pro-imperialista del Nicaragua.
Con lo slogan “no ai cinesi” - che hanno sempre gridato incompleto perché in realtà sarebbe “no ai cinesi, sì ai gringos” - hanno cercato il sostegno di settori sociali e territori della contra, tradizionalmente antisandinisti, e hanno iniziato una escalation di attacchi al governo maggiormente organizzata – posto che contavano con la base sociale che chiunque e per qualsiasi motivo può mobilitare contro il il governo sandinista – e con maggiori risorse fornite dagli Stati Uniti, che si oppongono ferocemente alla costruzione di un canale interoceanico alternativo a quello di Panama e si oppongono anche a qualsivoglia governo che non sia sottomesso ai suoi proposito egemonici.
Da allora abbiamo visto le stesse vecchie facce, che si precipitano ad accaparrarsi una telecamera in ogni problema - reale o artificiale - che si vive nel nostro paese. Così abbiamo visto gli stessi personaggi negli scontri della Miniera La India, nella Riserva dell'Indio Maiz e, ovviamente, in occasione della Legge di Riforma dellINSS. Sono i primi ad apparire dando dichiarazioni e impadronendosi della leadership in ogni conflitto.
Questa assurda e malata onnipresenza frustra qualsiasi tipo di partecipazione di persone in buona fede che possano avere interesse nella ricerca di soluzioni alle nostre difficoltà e frena la nascita di una leadership popolare autonoma e indipendente dal capitale pro-imperialista e nostalgico, includendo quello somozista, che essi stessi rappresentano.
Sono figure logore e squalificate non solo per la loro mancanza di carisma, di legame con i problemi reali e quotidiani del popolo e per una sconcertante assenza di credibilità, quanto anche per un discorso obsoleto – e che non calza con le loro attività pro-imperialiste – nel quale mescolano una retorica falsamente di sinistra, con slogan e canzoni create dal popolo nel fragore della lotta antisomozista, anticapitalista e antimperialista.
 Mentre vanno a braccetto con Ileana Ros-Lehtinen, con Marco Rubio, con Luis Flay, con Eduardo Montalegre e utilizzano La Prensa come loro portavoce, che interpreta lo stesso ruolo che ebbe El Mercurio contro Allende, intonano - senza nessun appoggio popolare - “el pueblo unido jamás será vencido” o gridano “que se rinda tu madre”, una frase che è un paradigma della purezza e coerenza rivoluzionaria e che Leonel Rugama gridò in faccia al tiranno Somoza, l'ultimo marine che lasciarono in Nicaragua gli yankees, dopo aver assassinato Sandino.
Mentre vanno a braccetto con Ileana Ros-Lehtinen, con Marco Rubio, con Luis Flay, con Eduardo Montalegre e utilizzano La Prensa come loro portavoce, che interpreta lo stesso ruolo che ebbe El Mercurio contro Allende, intonano - senza nessun appoggio popolare - “el pueblo unido jamás será vencido” o gridano “que se rinda tu madre”, una frase che è un paradigma della purezza e coerenza rivoluzionaria e che Leonel Rugama gridò in faccia al tiranno Somoza, l'ultimo marine che lasciarono in Nicaragua gli yankees, dopo aver assassinato Sandino.
Nessuno che sia al servizio dei gringos, che abbia richiesto sanzioni contro il Nicaragua o che lanci insulti contro il Venezuela, ha l'autorità morale per intonare le nostre canzoni, ancora meno per farsi chiamare sandinisti. L'antimperialismo è consustanziale al sandinismo. Quindi se una volta lo furono, ora chiaramente non lo sono.
Si definiscono anti-governo, in realtà però sono antisandinisti perché altrimenti come si spiega che ricorrano agli USA supplicando sanzioni contro la nostra patria sotto lo slogan “Nicaragua dice basta sandinisti”? O che vituperino la bandiera rojinegra, la calpestino e la odino quando è la bandiera di Sandino, la stessa che Carlos Fonseca recuperò per l'FSLN?
Tutta questa gente si è persa per strada ed è andata ad aumentare le lunghe liste di transfughi allineati all'imperialismo. Da Joaquin Villalobos fino a Michelle Bachelet. Hanno navigato con la bandierina di sinistra per coronare infine lo zenit della loro storia con la odiata bandiera a stelle e strisce. Una fine triste per una vita che avrebbe potuto concludersi in maniera gloriosa, e non - come dice Tomás Eloy Martinez - che potendo essere tutto, stanno finendo nel nulla.
Giornalista e militante dell'FSLN
- Dettagli
- Scritto da Redazione
 Christopher Black è uno dei giuristi penali internazionali più noti al mondo. Sul conflitto in Rwanda e su quello nella ex Jugoslavia negli anni '90, in particolare, Black ha dimostrato davanti ai tribunali istituiti ad hoc la loro illegittimità dal punto di vista della Carta delle Nazioni Unite e il loro essere meri strumenti di guerra degli Stati Uniti d'America.
Christopher Black è uno dei giuristi penali internazionali più noti al mondo. Sul conflitto in Rwanda e su quello nella ex Jugoslavia negli anni '90, in particolare, Black ha dimostrato davanti ai tribunali istituiti ad hoc la loro illegittimità dal punto di vista della Carta delle Nazioni Unite e il loro essere meri strumenti di guerra degli Stati Uniti d'America.
In particolare, in relazione alla guerra in Rwanda, Black ha portato in tribunale prove non confutabili di come il Fronte patriottico rwandese avesse condotto una guerra d'aggressione per conto degli Stati Uniti e del Regno Unito attraverso l'Uganda. Insieme a diversi altri giuristi, Black ha criticato pubblicamente l'arresto di Slobodan Miloševic da parte del Tribunale dell'Aja, sostenendo come fossero, al contrario, i leader della Nato che si sarebbero dovuti sedere davanti ad un tribunale per crimini di guerra. Con il Pofessor Michael Mandel e ad altri giuristi, Black ha presentato una serie di accuse formali di crimini di guerra contro tutti i leader dell'Alleanza Atlantica dopo i bombardamenti del 1999.
- C. Black è oggi una delle voci più autorevoli nel commentare la politica internazionale. Noi de l'AntiDiplomatico abbiamo avuto il privilegio di porgli alcune domande sulla nuova vittima dell'imperialismo nord-americano: il Venezuela.
Il suo paese, il Canada, fa parte del Gruppo di Lima, vale a dire quell'insieme di nazioni che, non potendo ottenere la maggioranza contro il Venezuela in sede OSA, ha deciso di distaccarsene. Da ultimo, questi paesi hanno chiesto alla Corte penale internazionale di aprire un'indagine contro il governo del Venezuela per crimini contro l'umanità. Ci sono le basi legali?
Il Venezuela è membro del Trattato di Roma e quindi rientra nella loro facoltà farlo, ma per iniziare un'indagine il Procuratore deve avere informazioni credibili e affidabili che meritino indagini sul fatto che siano stati commessi crimini. Crimini che il governo venezuelano starebbe sistematicamente ignorando o di cui è responsabile. Non hanno fornito tali informazioni nelle loro richieste. Tutto ciò che hanno inviato al Procuratore sono affermazioni infondate, dichiarazioni vuote che echeggiano la loro retorica politica. Quindi non ci sono motivi legali su cui il Procuratore possa agire.
Tuttavia, ci sono prove schiaccianti e la rea confessione di chi si vanta come gli Stati Uniti, il Canada e i paesi Ue di commettere crimini contro il popolo del Venezuela con la loro guerra economica. Le chiamano "sanzioni" che sono illegali a livello internazionale, per sostenere un tentativo di colpo di stato interno, per sostenere la cospirazione di chi commette aggressioni e ultimamente il sabotaggio di infrastrutture civili, come la rete elettrica.
Il Canada, seguendo quanto richiesto dagli Stati Uniti e con l'UE, impone sanzioni illegali che affliggono il popolo del Venezuela solo per rovesciare il governo attuale. Da un punto di vista legale cosa potrebbe fare il governo del Venezuela per proteggere i diritti violati della propria popolazione?
Sì, le sanzioni sono illegali perché violano la Carta delle Nazioni Unite, dato che solo il Consiglio di sicurezza ha l'autorità di imporre sanzioni ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Sono anche crimini contro l'umanità perché equivalgono a una guerra d'assedio che sta causando la deliberata sofferenza dei civili nel tentativo di rovesciare il governo. Il Venezuela sta facendo ciò che io stesso consiglierei alle autorità: costruire un sostegno tra le nazioni come la Russia, la Cina, l'India, la Turchia e molte altre che hanno appena formato un gruppo per ripristinare la Carta delle Nazioni Unite come cardine della legge internazionale. Caracas può anche chiedere all'ICC di muovere accuse contro i paesi che lo attaccano, come ho detto sopra. Il governo può infine presentare un reclamo contro gli Stati Uniti e gli altri paesi coinvolti per i danni ricevuti alla Corte di giustizia internazionale con la richiesta esplicita di fermare l’aggressione contro il Venezuela.
Bolton è arrivato a citare la Dottrina Monroe per spiegare l’approccio degli Stati Uniti contro il Venezuela. E’ un chiaro insulto a tutti i paesi dell’America Latina, Gruppo di Lima, compreso chiaramente. Ma ha qualche riferimento con il diritto internazionale?
La Dottrina Monroe non è accettata come parte del diritto internazionale e non lo è mai stata. È una dichiarazione molto semplice che Monroe emanò nel 1823, subito dopo che gran parte dell'America Latina si era liberata dal giogo spagnolo e portoghese: l'emisfero occidentale era da considerare una regione di interesse americana e qualsiasi intrusione europea nell'area sarebbe stata considerata un atto ostile. Riportarla alla luce oggi come Bolton cerca di fare è sì un insulto a tutti i paesi dell'America Latina e persino al Canada, poiché significa che gli americani considerano quelle nazioni come tante province del loro impero. Tuttavia c'è una contraddizione perché ora fanno affidamento sull'aiuto dell'Europa - ad esempio Spagna, Gran Bretagna, Francia e Germania - per procedere nella guerra contro il Venezuela. Ma così mostrano anche la loro debolezza, facendo affidamento proprio sull'aiuto delle stesse nazioni che la Dottrina Monroe afferma di voler escludere dalla regione.
Al ritorno in Venezuela il 4 marzo, il deputato Guaidò è stato scortato da alcuni ambasciatori europei, Spagna Francia e Germania in particolare. E’ una decisione in linea con la Convenzione di Vienna e il diritto internazionale generale?
No, è una violazione della Convenzione di Vienna e un atto ostile. L'articolo 5 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 stabilisce le normali attività consentite dei consoli in uno Stato ricevente. La sottosezione (m) afferma:
esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s’opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza. Ciò significa che il sostegno ai cospiratori in un tentativo di golpe contro lo Stato ricevente è chiaramente proibito ed è considerato dal diritto internazionale consuetudinario come un atto ostile e il paese ricevente ha il diritto di espellere immediatamente i funzionari consolari coinvolti o l'intero corpo diplomatico.
Da esperto di diritto internazionale cosa risponde a chi invoca la famigerata “responsabilità di proteggere” sul caso del Venezuela?
Non esiste una dottrina legale di "responsabilità di proteggere" nel diritto internazionale. È puramente un'invenzione degli Stati Uniti e dei loro alleati per giustificare le loro guerre di aggressione e violazioni della Carta delle Nazioni Unite. Dal momento che non possono ottenere il sostegno del Consiglio di sicurezza per le loro guerre, perché sono in violazione dell'obbligo di mantenere la pace e violano i diritti di ogni nazione alla sua sovranità e indipendenza, il diritto di non essere attaccato in alcun modo da altre nazioni, hanno inventato questa frase per giustificare l'ingiustificabile, non è altro che un pretesto per le guerre di aggressione e la gente dovrebbe metterlo fuori di testa come argomento per queste guerre. È una falsa dottrina, una vera dottrina, inventata dai fascisti.
Sempre da esperto di diritto internazionale come giudica il comportamento delle delegazioni dei paesi europei nel Consiglio di diritti umani di Ginevra?
Sono un giurista penalista esperto di diritto internazionale più che un esperto della tematica specifica dei diritti umani e, sebbene abbia una certa familiarità con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, non posso fornire un'opinione accademica. Tuttavia, dalla mia esperienza maturata negli ultimi 20 anni, posso dire che le potenze europee e gli americani ne hanno preso il controllo e lo usano per far avanzare i loro interessi. Il Consiglio ha inviato un relatore speciale in Venezuela per indagare sulle condizioni ivi presenti e il suo rapporto ha affermato che le difficoltà erano interamente imputabili alla guerra economica condotta dagli Stati Uniti contro il Venezuela. Ha anche affermato che il suo report è stato consegnato e da allora non è mai stato utilizzato. A dimostrazione proprio di questo.
Nei loro discorsi al Consiglio di Sicurezza sia il ministro degli esteri del governo venezuelano, Arreaza, che l’Ambasciatore presso la OEA, Moncada, hanno denunciato l’aggressione del 23 febbraio dalla Colombia. Hanno anche denunciato come Stati Uniti e alleati stiano armando bande irregolari di mercenari sul modello di quello che è avvenuto in Siria. Dopo il fallimento di Cucuta sarà questa la strategia contro il Venezuela?
Possiamo vedere la strategia di guerra ibrida che stanno utilizzando in questi giorni con l'attacco informatico che ha portato al sabotaggio della rete elettrica. La guerra ibrida è una guerra che usa tutti i campi della vita e della società per danneggiare la nazione presa di mira. Continueranno a usare la guerra economica, la guerra cibernetica, la guerra di propaganda, la sovversione, il sabotaggio, le minacce di attacchi di massa, il terrorismo, gli attacchi con false bandiere. Fanno lo stesso contro la Russia, la Siria, l’Iran e la Corea del Nord. Tutte queste tattiche sono ovviamente elementi di una guerra di aggressione, che è il crimine di guerra fondamentale e ora un crimine per cui, in teoria, dovrebbero essere perseguiti dalla Corte penale internazionale.
fonte: l'antidiplomatico.it
- Dettagli
- Scritto da Massimo Angelilli
 È un paese, l'Honduras, dove si uccide per occultare soprusi e violenze lunghe secoli. Dove si uccide per nascondere la verità. L'assassinio di Berta Cáceres, nella notte tra il due e il tre marzo del 2016, avviene dopo un crescendo di minacce e intimidazioni. Da parte di chi? Di uno Stato diretta filiazione del golpe del 2009. Estromesso, e costretto all'esilio, Manuel Zelaya, che aveva consentito l'ingresso dell'Honduras nell'ALBA, il paese rientra nell'orbita di controllo degli Stati Uniti.
È un paese, l'Honduras, dove si uccide per occultare soprusi e violenze lunghe secoli. Dove si uccide per nascondere la verità. L'assassinio di Berta Cáceres, nella notte tra il due e il tre marzo del 2016, avviene dopo un crescendo di minacce e intimidazioni. Da parte di chi? Di uno Stato diretta filiazione del golpe del 2009. Estromesso, e costretto all'esilio, Manuel Zelaya, che aveva consentito l'ingresso dell'Honduras nell'ALBA, il paese rientra nell'orbita di controllo degli Stati Uniti.
Al colpo di stato del 29 giugno del 2009 infatti, è ampiamente documentata la partecipazione attiva di Hilary Clinton, all'epoca Segretario di Stato.
L'allontanamento, sancito con un referendum, dagli interessi di Washington, scatena quindi la voracità del potente vicino e quella degli eterni esecutori interni. Banchieri, latifondisti, le solite aristocrazie, insomma tutto l'ordinamento socio-economico che da sempre tiene le redini di un paese eternamente condannato alla povertà, riprende violentemente il controllo.
L'ondata repressiva seguita al golpe lascia morti e atrocità, nelle città come nelle campagne. Non si sono ravvisate voci di indignazione e protesta nei tempi sacri della informazione, che invece si sollevano con sorprendente prontezza quando si tratta di alimentare e sostenere campagne di diffamazione nei confronti del Venezuela della Bolivia o del Nicaragua, solo per citarne alcune.
In ogni caso, il tentativo di arginare la svendita di risorse umane e naturali del paese ai grandi trattati commerciali, come avvenuto in tante altre realtà del sub-continente, viene frustrato con il sangue. Il Plan Puebla Panama, permette la privatizzazione dei fiumi per la costruzione di dighe.
Grandi opere che fanno la felicità delle imprese che le realizzano, che nessun beneficio però portano alla popolazione. Nello specifico, violano l'equilibrio naturale di intere zone nelle quali da secoli risiedono comunità che di quelle ricchezze naturali si nutrono. E che curano e conservano. Un attacco dunque, sferrato alla biodiversità per soddisfare la insaziabilità del capitalismo. Una storia vecchia come la umanità, che in questo angolo di pianeta si ripropone in forma di tragedia.
La comunità Lenca si oppone da subito alla ennesima espropriazione e all'ennesimo saccheggio da parte di multinazionali che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo, ma molto con il profitto.
Nasce il COPINH - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Berta ne diventa militante e ben presto leader riconosciuta. “Noi siamo discendenti dei popoli indigeni che hanno compiuto la più grande resistenza alla conquista. Questo non è mai stato riconosciuto, mai compreso, neppure dalla sinistra. L’imperialismo e la destra non si riposano. Li abbiamo sopravalutati e siamo rimasti come in letargo. Nella crisi generale del capitalismo, loro hanno bisogno delle nostre risorse, la biodiversità, il petrolio, la nostra cultura, i nostri saperi ancestrali. Perciò non rinunceranno. Ed è questo il tempo in cui il movimento sociale di sinistra, antimperialista, deve consolidare e rafforzare il suo processo di emancipazione. Deve essere una risposta non solo locale o regionale, ma internazionale, globale, contro il capitalismo”. Questo diceva Berta, questo gli valse nel 2015 il Golden Environmental Prize, considerato un Nobel dell'ambientalismo. Per questo, Berta fu assassinata.
La sua lotta contro il patriarcato, il colonialismo, il capitalismo, ha messo a dura prova la sua stessa esistenza, fino alle conseguenze più estreme. Il patto di ferro tra lo stato golpista e la DESA, l'impresa designata per la realizzazione delle dighe, ha perseguitato Berta e il COPINH per seminare morte e paura; per far desistere la popolazione da qualsiasi anelito di resistenza. E lo fa tuttora, a tre anni dall'omicidio, lasciando sostanzialmente impuniti i mandanti e gli autori materiali del delitto.
“Giustizia per Berta” non è dunque solo uno slogan, un lema per non dimenticare, per combattere l'oblio, questa malattia letale in America Latina come in tutto il pianeta. È un impegno costante per ristabilire in Honduras, ma dall'estrinseco valore universale, imprescindibili principi di democrazia. E lo è ora più che mai, in questi complicati tempi in cui tornano a tuonare i tamburi di guerra e a far mostra di muscoli per preparare un'aggressione, alle porte di paesi poco graditi alle oligarchie occidentali. Sembrano cronache del secolo passato, eppure raccontano questi nostri giorni. Berta ne è la drammatica testimonianza.
I suoi assassini l'hanno sorpresa nel sonno, violentando la sua indifesa intimità come solo la bestia fascista è capace di fare. Avrà avuto il tempo di stampare i suoi occhi negli occhi di chi nella maniera più vile avrebbe messo fine alla sua vita.
Per quanto sia stata una esecuzione, e condotta quindi con tutti i “crismi” che una operazione simile richiede, è la paura che ha fatto premere il grilletto.
La paura di trovarsi davanti una donna disarmata che con la sola forza delle parole, dei gesti esemplari, rendeva disarmante la bieca pratica della sopraffazione. L'avrà guardato fisso negli occhi per raccontargli in una frazione di secondo l'atroce inutilità di quel gesto. Come se uccidere e assassinare a sangue freddo fosse una prova di impareggiabile coraggio.
 Berta, è molto più di un'idea, di un esempio. È molto più di un cuore che smette di battere. È un fiume che scorre tra le montagne, è la montagna che lo accompagna tra le valli sacre che la bestialità del profitto vorrebbe stuprare per insediarcisi con tutto il suo carico di morte e devastazione. È la dignità che prende parola.
Berta, è molto più di un'idea, di un esempio. È molto più di un cuore che smette di battere. È un fiume che scorre tra le montagne, è la montagna che lo accompagna tra le valli sacre che la bestialità del profitto vorrebbe stuprare per insediarcisi con tutto il suo carico di morte e devastazione. È la dignità che prende parola.
Ed è un fiume in piena, proprio come quello che avrebbero voluto distruggere con una sproposito di dighe. E che lei ha tanto strenuamente difeso, fino all'ultimo respiro. L'avevano minacciata di morte più e più volte, per aver commesso l'atroce delitto di denunciare i padroni del vapore. Per aver commesso l'atroce delitto di aver preso la vita sul serio, come Leonel Rugama, crivellato di colpi dalla Guardia Nacional somozista nel Nicaragua della insurrezione sandinista.
Gli squadroni della morte non conoscono latitudini e congiunture storiche. Attraversano impunemente qualsiasi società e qualsiasi giusta causa. Svolgono diligentemente il loro lavoro grazie alla compiacenza di governi mascherati da democrazia e al disinteresse dei cosiddetti mezzi d'informazione. Il loro disinteresse però non impiega molto a tramutarsi in complicità. E più precisamente in quella comoda complicità che rende comodi le vite di chi trova conforto nel volgere lo sguardo sempre dall'altra parte. Dove regna il soporifero piacere di trovare nelle disperazioni altrui il proprio benessere.
- Dettagli
- Scritto da Manlio Dinucci
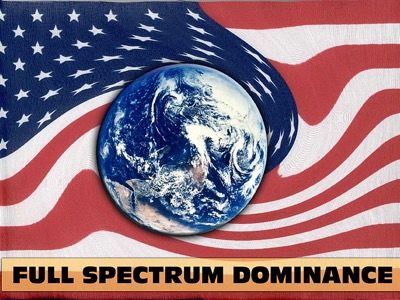 All’indomani degli attentati dell’11 Settembre, il segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, e il suo consigliere Arthur Cebrowski definirono la necessità per il Pentagono di dominare completamente il campo di battaglia mondiale (Full-spectrum dominance), in modo da assicurare l’unipolarità del mondo. È esattamente quanto gli Stati Uniti stanno cercando di fare oggi.
All’indomani degli attentati dell’11 Settembre, il segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, e il suo consigliere Arthur Cebrowski definirono la necessità per il Pentagono di dominare completamente il campo di battaglia mondiale (Full-spectrum dominance), in modo da assicurare l’unipolarità del mondo. È esattamente quanto gli Stati Uniti stanno cercando di fare oggi.
Due settimane fa Washington ha incoronato presidente del Venezuela Juan Guaidò, pur non avendo questi neppure partecipato alle elezioni presidenziali, e ha dichiarato illegittimo il presidente Maduro, regolarmente eletto, preannunciando la sua deportazione a Guantanamo.
La scorsa settimana ha annunciato la sospensione USA del Trattato INF, attribuendone la responsabilità alla Russia, e ha in tal modo aperto una ancora più pericolosa fase della corsa agli armamenti nucleari.
Questa settimana Washington compie un altro passo: domani 6 febbraio, la NATO sotto comando USA si allarga ulteriormente, con la firma del protocollo di adesione della Macedonia del Nord quale 30° membro.
Non sappiamo quale altro passo farà Washington la settimana prossima, ma sappiamo qual è la direzione: una sempre più rapida successione di atti di forza con cui gli USA e le altre potenze dell’Occidente cercano di mantenere il predominio unipolare in un mondo che sta divenendo multipolare. Tale strategia - espressione non di forza ma di debolezza, tuttavia non meno pericolosa - calpesta le più elementari norme di diritto internazionale.
Caso emblematico è il varo di nuove sanzioni USA contro il Venezuela, con il «congelamento» di beni per 7 miliardi di dollari appartenenti alla compagnia petrolifera di Stato, allo scopo dichiarato di impedire al Venezuela, il paese con le maggiori riserve petrolifere del mondo, di esportare petrolio. Il Venezuela, oltre ad essere uno dei sette paesi del mondo con riserve di coltan, è ricco anche di oro, con riserve stimate in oltre 15 mila tonnellate, usato dallo Stato per procurarsi valuta pregiata e acquistare farmaci, prodotti alimentari e altri generi di prima necessità. Per questo il Dipartimento del Tesoro USA, di concerto con i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche Centrali di Unione europea e Giappone, ha condotto una operazione segreta di «esproprio internazionale» (documentata da Il Sole 24 Ore).
Ha sequestrato: 31 tonnellate di lingotti d’oro appartenenti allo Stato venezuelano: 14 tonnellate depositate presso la Banca d’Inghilterra, più altre 17 tonnellate trasferite a questa banca dalla tedesca Deutsche Bank che li aveva avuti in pegno a garanzia di un prestito, totalmente rimborsato dal Venezuela in valuta pregiata.
Una vera e propria rapina, sullo stile di quella che nel 2011 ha portato al «congelamento» di 150 miliardi di dollari di fondi sovrani libici (ormai in gran parte spariti), con la differenza che quella contro l’oro venezuelano è stata condotta segretamente. Lo scopo è lo stesso: strangolare economicamente lo Stato-bersaglio per accelerarne il collasso, fomentando l’opposizione interna, e, se ciò non basta, attaccarlo militarmente dall’esterno.
Con lo stesso dispregio delle più elementari norme di condotta nei rapporti internazionali, gli Stati uniti e i loro alleati accusano la Russia di violare il Trattato INF, senza portare alcuna prova, mentre ignorano le foto satellitari diffuse da Mosca le quali provano che gli Stati Uniti avevano cominciato a preparare la produzione di missili nucleari proibiti dal Trattato, in un impianto della Raytheon, due anni prima che accusassero la Russia di violare il Trattato.
Riguardo infine all’ulteriore allargamento della NATO, che sarà sancito domani, va ricordato che nel 1990, alla vigilia dello scioglimento del Patto di Varsavia, il Segretario di Stato USA James Baker assicurava il Presidente dell’URSS Mikhail Gorbaciov che «la NATO non si estenderà di un solo pollice ad Est». In vent’anni, dopo aver demolito con la guerra la Federazione Jugoslava, la NATO si è estesa da 16 a 30 paesi, espandendosi sempre più ad Est verso la Russia.
fonte: voltairenet.org
