- Dettagli
- Scritto da Carlo Musilli
 La crisi economica che attraverseremo nei prossimi mesi (o anni) sarà probabilmente devastante. Al momento, nessuno è in grado di prevedere quanto durerà l’emergenza coronavirus, perciò ogni stima sull’andamento del Pil italiano o europeo è più che aleatoria. L’unica certezza è che andremo giù.
La crisi economica che attraverseremo nei prossimi mesi (o anni) sarà probabilmente devastante. Al momento, nessuno è in grado di prevedere quanto durerà l’emergenza coronavirus, perciò ogni stima sull’andamento del Pil italiano o europeo è più che aleatoria. L’unica certezza è che andremo giù.
Non solo. Il sistema italiano è quello che verosimilmente subirà i danni peggiori dall’epidemia. A differenza degli altri grandi Stati europei, infatti, il nostro Paese si regge su una spina dorsale fatta di piccole e medie imprese. E sono proprio queste le aziende destinate a cadere per prime: non potendo contare su grandi riserve di liquidità, migliaia di imprenditori e di commercianti rischieranno la bancarotta già dopo due-tre mesi di chiusura forzata o di fatturato vicino allo zero.
Inoltre, il crollo delle importazioni dalla Cina (dovuto allo stop delle fabbriche) spezzerà moltissime catene produttive nei prossimi mesi, quando le scorte di componenti made in China saranno esaurite. Anche sul versante dell’export i guai non mancheranno, con i flussi commerciali destinati a contrarsi su scala globale. Tutto questo causerà un’impennata della disoccupazione, che a sua volta produrrà una caduta dei consumi, innescando una spirale recessiva. La crisi in arrivo colpirà quindi sia la domanda che l’offerta.
In questo scenario, lo Stato vedrà crollare le entrate fiscali, ma allo stesso tempo sarà costretto a intervenire con ogni mezzo possibile – a cominciare da un oceano di cassa integrazione – per tamponare le emorragie. Il problema è che le risorse nazionali non basteranno per contrastare in modo efficace alla tempesta in cui stiamo entrando.
Il governo lo sa, per questo ha già chiesto e ottenuto dall’Europa maggiore flessibilità sui conti di quest’anno: 6,3 miliardi in più che saranno sterilizzati nei conteggi di deficit e debito. Questi soldi sono un buon inizio, ma bisognerà fare di più. È fondamele quindi capire come si muoverà l’Ue per sostenere i Paesi che rischiano un rovescio economico superiore perfino a quello iniziato nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers.
 Da questo punto di vista, il caso andato in scena la settimana scorsa non è un buon segnale. L’Italia aveva chiesto aiuto ai partner europei per coprire il fabbisogno di mascherine del nostro Paese, in piena emergenza, ma visto che il coronavirus si sta diffondendo in tutto il continente, nessuna capitale Ue ha offerto il proprio aiuto. A dimostrazione ancora una volta di come l’Unione, di fronte alle difficoltà di un Paese membro, sappia esprimere solo cinismo, rispondendo sempre alle ragioni degli egoismi nazionali e mai a quelle della solidarietà fra alleati.
Da questo punto di vista, il caso andato in scena la settimana scorsa non è un buon segnale. L’Italia aveva chiesto aiuto ai partner europei per coprire il fabbisogno di mascherine del nostro Paese, in piena emergenza, ma visto che il coronavirus si sta diffondendo in tutto il continente, nessuna capitale Ue ha offerto il proprio aiuto. A dimostrazione ancora una volta di come l’Unione, di fronte alle difficoltà di un Paese membro, sappia esprimere solo cinismo, rispondendo sempre alle ragioni degli egoismi nazionali e mai a quelle della solidarietà fra alleati.
Peraltro, bisogna considerare che l’epidemia si è abbattuta su un quadro già compromesso non solo in Italia, ma a livello globale. Ben prima che iniziassero i contagi, la nostra economia era già in stallo (tendente alla recessione), l’industria tedesca attraversava grandi difficoltà, la Cina rallentava e sui mercati incombevano due spettri: Brexit e la guerra dei dazi. Il tutto in un contesto monetario inedito, con un’inflazione bassa associata a un eccesso di liquidità mai visto prima, che riduce (e di parecchio) i margini di manovra delle banche centrali. Poi è arrivato il coronavirus.
- Dettagli
- Scritto da Antonio Rei
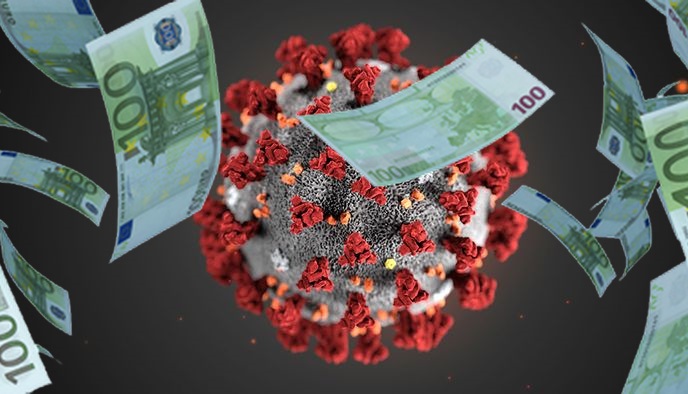 Nel medio periodo, è praticamente certo che il coronavirus farà molte meno vittime delle altre infezioni virali, che colpiscono platee decisamente più vaste. Tuttavia, le ricadute economiche del Covid-19 saranno senza dubbio più drammatiche. Al momento, com’è ovvio, non esistono ancora previsioni ufficiali o stime precise sull’impatto che l'epidemia potrebbe avere sul Pil italiano. Tuttavia, per avere un’idea della posta in gioco, vale la pena dare un’occhiata ad alcuni numeri.
Nel medio periodo, è praticamente certo che il coronavirus farà molte meno vittime delle altre infezioni virali, che colpiscono platee decisamente più vaste. Tuttavia, le ricadute economiche del Covid-19 saranno senza dubbio più drammatiche. Al momento, com’è ovvio, non esistono ancora previsioni ufficiali o stime precise sull’impatto che l'epidemia potrebbe avere sul Pil italiano. Tuttavia, per avere un’idea della posta in gioco, vale la pena dare un’occhiata ad alcuni numeri.
- Dettagli
- Scritto da Michele Paris
 Il tradizionale appuntamento dell’oligarchia mondiale a Davos è iniziato martedì con un intervento dai contorni surreali del presidente Trump, impegnato a celebrare le prestazioni di un’economia, come quella degli Stati Uniti, a suo dire in grado di creare ricchezza e benessere virtualmente per l’intera popolazione americana. Il clima prevalente al 50esimo World Economic Forum (WEF) appare però esattamente opposto, con i leader politici e gli esponenti delle élites economiche e finanziarie del pianeta intenti a salvaguardare i privilegi e le ricchezze riservati a pochissimi di fronte al dilagare di proteste e sentimenti di repulsione nei confronti del sistema capitalistico in crisi profonda.
Il tradizionale appuntamento dell’oligarchia mondiale a Davos è iniziato martedì con un intervento dai contorni surreali del presidente Trump, impegnato a celebrare le prestazioni di un’economia, come quella degli Stati Uniti, a suo dire in grado di creare ricchezza e benessere virtualmente per l’intera popolazione americana. Il clima prevalente al 50esimo World Economic Forum (WEF) appare però esattamente opposto, con i leader politici e gli esponenti delle élites economiche e finanziarie del pianeta intenti a salvaguardare i privilegi e le ricchezze riservati a pochissimi di fronte al dilagare di proteste e sentimenti di repulsione nei confronti del sistema capitalistico in crisi profonda.
Il tema di quest’anno dell’evento nel “resort” elvetico è quasi inevitabilmente legato alla questione climatica. Il riferimento alla necessità di costruire un “mondo coeso e sostenibile” e una serie di inutili accorgimenti “green”, predisposti dagli organizzatori del forum annuale, darà la possibilità agli ultra-miliardari presenti e ai loro riferimenti politici di atteggiarsi a leader turbati dagli effetti dei cambiamenti climatici e pronti ad agire per salvare il pianeta.
L’immancabile presenza della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, assieme a conferenze sull’argomento e iniziative varie, permette inoltre ancora una volta di perpetuare l’illusione della capacità del capitalismo e del libero mercato di autoregolarsi per attuare finalmente misure volte a fermare il riscaldamento globale.
L’unico interesse che banchieri e speculatori riuniti a Davos hanno nella battaglia per l’ambiente è in realtà quello di fare profitti, possibilmente enormi, anche sulle politiche ecologiche. L’invito e la presenza di Trump confermano pienamente questa realtà. Il presidente americano è uno dei negazionisti più convinti e nel suo intervento di martedì lo ha ribadito senza tante ambiguità, definendo gli ambientalisti “profeti di sventura” e respingendo le loro “previsioni apocalittiche” per difendere l’attuale modello economico statunitense.
Il consueto rapporto del WEF indica dunque come rischio principale sul medio periodo quello climatico, potenzialmente in grado di creare danni significativi anche in ambito economico e finanziario. Un'altra indagine mostra invece come i rischi che potrebbero aumentare più rapidamente nel corso del 2020 siano da ricondurre a questioni puramente economiche e alle disparità sociali e di reddito.
A livello ufficiale, praticamente come ogni anno a Davos si cerca di dibattere e di trovare soluzioni ai processi di polarizzazione economica e sociale che continuano a creare vere e proprie voragini tra una ristretta cerchia di super-ricchi e la stragrande maggioranza della popolazione. La sensazione diffusa tra i frequentatori del forum è appunto quella di una situazione di estrema pericolosità, con tensioni sociali pronte a esplodere mettendo in pericolo le posizioni di privilegio.
Ogni anno, tuttavia, le differenze aumentano e, una volta chiusi i summit internazionali, i processi di impoverimento che riguardano miliardi di persone nel pianeta e, per contro, quelli di accumulazione di ricchezze dalla parte opposta della piramide sociale continuano senza sosta. I numeri concreti che definiscono questa situazione li ha dati come al solito alla vigilia del WEF la ONG britannica Oxfam.
A oggi, appena 2.153 persone detengono ricchezze superiori a quelle possedute dai 4,6 miliardi di abitanti più poveri della terra. Forse ancora più incredibile è un altro dato, quello che spiega come l’1% della popolazione controlla il doppio della ricchezza di 6,9 miliardi di persone, in pratica tutto il resto degli abitanti del pianeta.
Oxfam propone un esempio curioso per cercare di dare l’idea di questo quadro quasi incomprensibile. Se, cioè, ognuno dovesse sedere sulle proprie ricchezze complessive trasformate in banconote da 100 dollari USA, “la maggior parte dell’umanità sarebbe seduta sul pavimento”. Un appartenente alla “classe media di un paese ricco siederebbe all’altezza di una normale sedia”, mentre i due uomini più ricchi della terra si ritroverebbero nello “spazio esterno”.
 Per l’ennesima volta, così, i potenti della terra cercheranno a Davos di proiettare un’immagine di filantropi e riformatori impegnati nel tentativo di creare un nuovo modello di sviluppo ecologicamente “sostenibile” e più equo, quanto meno per frenare le spinte anti-sistema, se non apertamente rivoluzionarie, sempre più evidenti in focolai di protesta che vanno dall’Europa all’Africa, dal Medio Oriente all’Asia, fino al continente americano.
Per l’ennesima volta, così, i potenti della terra cercheranno a Davos di proiettare un’immagine di filantropi e riformatori impegnati nel tentativo di creare un nuovo modello di sviluppo ecologicamente “sostenibile” e più equo, quanto meno per frenare le spinte anti-sistema, se non apertamente rivoluzionarie, sempre più evidenti in focolai di protesta che vanno dall’Europa all’Africa, dal Medio Oriente all’Asia, fino al continente americano.
Col passare degli anni, però, queste pretese trovano sempre meno appigli e un numero crescente di persone in tutto il mondo acquisisce la consapevolezza che quanti animano meeting esclusivi e vertici politici, rigorosamente vietati al resto della popolazione, sono essi stessi la causa di povertà e disuguaglianze sociali, da cui anzi traggono profitti e privilegi.
In questo scenario, diventa in qualche modo comprensibile anche l’impegno del presidente americano Trump nel cercare di dipingere un quadro ultra-ottimistico della situazione economica degli Stati Uniti. Da un lato, l’insistenza sulla potenza USA e sui livelli di crescita raggiunti negli ultimi anni serve a ostentare un’immagine di solidità sul piano internazionale proprio nel momento in cui la posizione e l’influenza di questo paese stanno toccando i punti più bassi della sua storia.
Dall’altro, emerge invece il tentativo di Trump di ingigantire i successi economici degli Stati Uniti o, meglio, di generalizzare una crescita che ha in realtà beneficiato in larghissima misura solo le grandi corporation, gli speculatori di Wall Street e, in generale, i grandi interessi americani, lasciando nella migliore delle ipotesi le briciole a lavoratori e classe media.
Una strategia, quella dell’inquilino della Casa Bianca, che a Davos deve essere stata accolta con favore, malgrado la retorica ufficiale dell’evento, perché serve, almeno nelle intenzioni, ad argine la rivolta contro il sistema e ad alimentare l’inganno di un capitalismo ancora capace di produrre occupazione stabile, ricchezza generalizzata e stabilità sociale.
- Dettagli
- Scritto da Michele Paris
 Per quanti confidano che la “prima fase” dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina firmato mercoledì a Washington possa mettere fine al conflitto tra le prime due potenze economiche del pianeta, i prossimi mesi riserveranno con ogni probabilità sgradite sorprese. Nessuna delle questioni fondamentali della rivalità esplosa negli ultimi anni è stata infatti affrontata, né tantomeno risolta, dal documento ratificato alla Casa Bianca con la stretta di mano tra il presidente americano Trump e il vice-premier cinese, Liu He.
Per quanti confidano che la “prima fase” dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina firmato mercoledì a Washington possa mettere fine al conflitto tra le prime due potenze economiche del pianeta, i prossimi mesi riserveranno con ogni probabilità sgradite sorprese. Nessuna delle questioni fondamentali della rivalità esplosa negli ultimi anni è stata infatti affrontata, né tantomeno risolta, dal documento ratificato alla Casa Bianca con la stretta di mano tra il presidente americano Trump e il vice-premier cinese, Liu He.
- Dettagli
- Scritto da Carlo Musilli
 Altro che Brexit. Altro che dazi. Altro che Alitalia e Ilva. A pesare più di ogni altra variabile sul futuro economico dell’Italia è la demografia. Secondo gli analisti della Banca d’Italia, che la settimana scorsa hanno pubblicato una rielaborazione di un loro recente studio, nei prossimi 22 anni i problemi legati alla composizione anagrafica degli italiani faranno crollare il Pil del 15% e il reddito pro-capite del 13%.
Altro che Brexit. Altro che dazi. Altro che Alitalia e Ilva. A pesare più di ogni altra variabile sul futuro economico dell’Italia è la demografia. Secondo gli analisti della Banca d’Italia, che la settimana scorsa hanno pubblicato una rielaborazione di un loro recente studio, nei prossimi 22 anni i problemi legati alla composizione anagrafica degli italiani faranno crollare il Pil del 15% e il reddito pro-capite del 13%.
Il problema è ormai di vecchia data, ma negli ultimi anni si è aggravato. Il Censis ha calcolato che dal 2015 la popolazione italiana è diminuita di 436mila unità: come se in quattro anni fossero sparite - tutte insieme - Ancona, Terni, Pescara e Piacenza.
