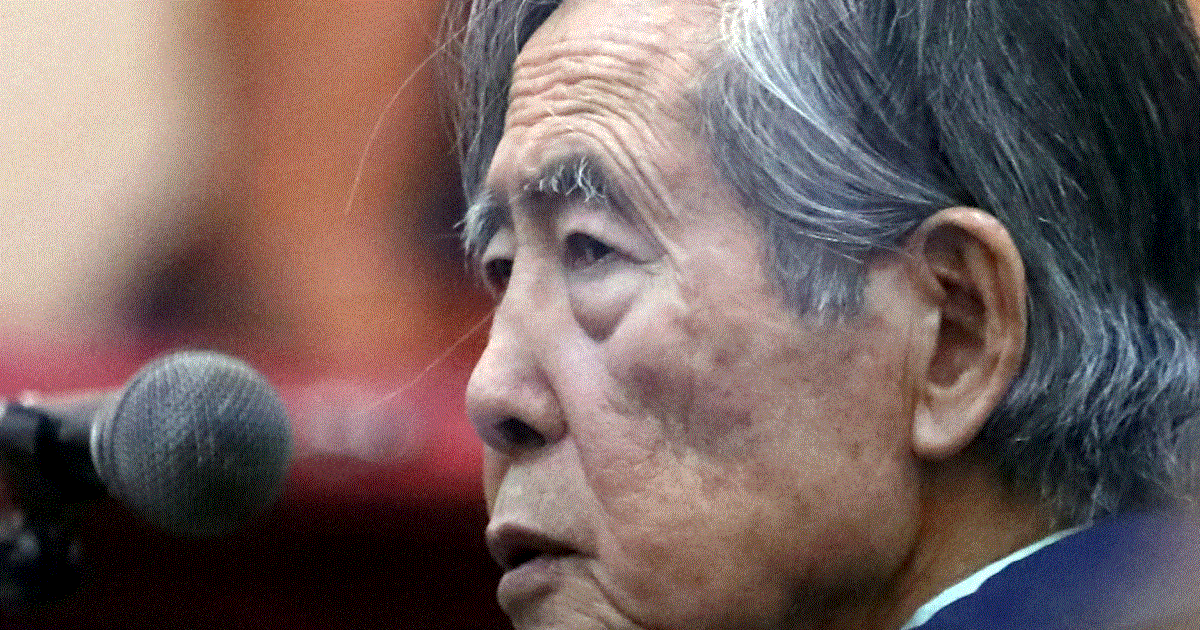USA-Israele, l’Iran resta nel mirino
 Il settimo incontro a Washington in meno di un anno tra Trump e Netanyahu si è chiuso apparentemente senza un accordo tra i due alleati su come procedere nei confronti dell’Iran. Secondo la versione ufficiale dei media americani e israeliani, il premier/criminale di guerra avrebbe chiesto di anticipare la visita alla Casa Bianca per spiegare le ragioni di Tel Aviv per includere nei negoziati in corso con Teheran una serie di condizioni in aggiunta al “file” nucleare. Come risulta chiaro ormai anche a livello pubblico, l’ossessione del regime israeliano è l’arsenale e il programma di missili balistici della Repubblica Islamica. Un’eventualità, quella dell’ampliamento dell’agenda dei colloqui, che Teheran non intende nemmeno prendere in considerazione, anche perché implicherebbe la rinuncia alle proprie capacità difensive e, in ultima analisi, al principale motivo – se non l’unico – per cui USA e Israele continuano a indugiare su un’aggressione militare di vasta portata.
Il settimo incontro a Washington in meno di un anno tra Trump e Netanyahu si è chiuso apparentemente senza un accordo tra i due alleati su come procedere nei confronti dell’Iran. Secondo la versione ufficiale dei media americani e israeliani, il premier/criminale di guerra avrebbe chiesto di anticipare la visita alla Casa Bianca per spiegare le ragioni di Tel Aviv per includere nei negoziati in corso con Teheran una serie di condizioni in aggiunta al “file” nucleare. Come risulta chiaro ormai anche a livello pubblico, l’ossessione del regime israeliano è l’arsenale e il programma di missili balistici della Repubblica Islamica. Un’eventualità, quella dell’ampliamento dell’agenda dei colloqui, che Teheran non intende nemmeno prendere in considerazione, anche perché implicherebbe la rinuncia alle proprie capacità difensive e, in ultima analisi, al principale motivo – se non l’unico – per cui USA e Israele continuano a indugiare su un’aggressione militare di vasta portata.
Dopo il vertice di mercoledì, Trump ha fatto sapere di avere deciso di continuare a discutere con l’Iran per esplorare la possibilità di un’intesa. Essendo il fattore sorpresa già usato nella breve guerra del giugno scorso, si può dedurre che nell’amministrazione repubblicana non ci sia ancora una posizione univoca e definitiva circa l’opzione militare. Ciò dipende appunto dai rischi che essa comporta, soprattutto dopo il recente fallimento dei piani di CIA e Mossad per fare implodere il sistema di potere iraniano attraverso le manifestazioni di protesta delle scorse settimane.
La retorica bellica americana resta in ogni caso ai massimi livelli, così come intense appaiono le operazioni che stanno portando nel teatro mediorientale armi e mezzi da impiegare in un attacco. Trump avrebbe a questo proposito ordinato la “preparazione” di una seconda portaerei, oltre alla USS Lincoln, da inviare nel Golfo Persico nel caso emergesse la necessità. La decisione di procedere con un attacco militare, si ribadisce con insistenza da Washington, verrebbe presa nel caso la diplomazia dovesse fallire. Questa tesi non ha evidentemente nessun fondamento, visto che l’esito dei negoziati dipende esclusivamente dagli Stati Uniti e dall’obiettivo delle discussioni che, se fossero condotte in buona fede e nel rispetto del loro interlocutore, potrebbero portare a un vero accordo in tempi rapidissimi.
L’interesse americano e di Israele non è però evidentemente quello di stipulare un accordo equo con la Repubblica Islamica. L’obiettivo è piuttosto di liquidare il regime e sostituirlo con uno più malleabile, in modo da consolidare il controllo strategico sul Medio Oriente e le sue risorse. La leadership iraniana è ben consapevole di questa realtà e cerca di limitare alla questione del nucleare gli argomenti delle trattative. Teheran non cerca, ad oggi, di costruire armi nucleari e le restrizioni, in termini ragionevoli, al proprio programma civile non sono un problema particolare, anche perché erano già state accettate con la firma dell’accordo del 2018 (JCPOA), in seguito fatto saltare unilateralmente dalla prima amministrazione Trump.
È difficile credere che il presidente americano si accontenti di una riedizione dell’accordo di Vienna che egli stesso ha cancellato. Per arrivare a questa conclusione non sarebbe stata necessaria infatti l’escalation militare in corso né le pressioni attraverso sanzioni e altre iniziative. C’è quindi da ipotizzare che il nuovo round di negoziati sia l’ennesimo teatrino per giustificare una guerra di aggressione contro un regime accusato di non avere interesse a trattare in maniera seria.
 Più che un processo diplomatico, quello che Washington ha promosso è un ricatto, con minacce via via crescenti nella speranza di fare cedere il governo iraniano. Le richieste di rinunciare ai missili e di mettere fine ai rapporti con i gruppi della Resistenza in Medio Oriente, oltre che azzerare il programma nucleare civile, sono totalmente inaccettabili per Teheran, perché corrisponderebbero appunto a una resa assoluta e alla consegna della propria sovranità a Stati Uniti e Israele.
Più che un processo diplomatico, quello che Washington ha promosso è un ricatto, con minacce via via crescenti nella speranza di fare cedere il governo iraniano. Le richieste di rinunciare ai missili e di mettere fine ai rapporti con i gruppi della Resistenza in Medio Oriente, oltre che azzerare il programma nucleare civile, sono totalmente inaccettabili per Teheran, perché corrisponderebbero appunto a una resa assoluta e alla consegna della propria sovranità a Stati Uniti e Israele.
La questione dei missili, ancora una volta, è cruciale in questa prospettiva. Israele, in particolare, ha toccato con mano la minaccia che essi rappresentano in caso di guerra. A giugno 2025 fu Netanyahu che decise di supplicare Trump per concordare una tregua con Teheran dopo che la ritorsione iraniana stava iniziando a fare danni devastanti in territorio israeliano. Washington e Tel Aviv erano ricorsi a una massiccia operazione di censura per dare l’impressione di avere la situazione sotto controllo e per minimizzare gli effetti dei missili della Repubblica Islamica. In seguito, però, indagini indipendenti avevano rivelato almeno una parte della distruzione provocata in Israele. Centinaia di edifici, in particolare a Tel Aviv e nei sobborghi, erano stati colpiti dopo che il sistema difensivo israeliano aveva mancato molti missili in arrivo dall’Iran. Anche obiettivi sensibili, come il famigerato Istituto di Scienza Weizmann, e militari erano stati colpiti, nonché installazioni e infrastrutture energetiche chiave per lo stato ebraico.
Il timore è inoltre che l’Iran abbia fatto ricorso solo a una parte del proprio arsenale e che i missili più efficaci e sofisticati siano ora pronti per quella che, hanno avvertito vari esponenti del governo di Teheran, sarebbe una risposta senza restrizioni in caso di aggressione. Molto difficile, secondo gli analisti militari, sarebbe anche un’operazione militare preventiva americana per colpire i depositi di questi missili. Con ogni probabilità, la gran parte dell’arsenale è stoccato in siti sotterranei diffusi in varie parti di un paese sterminato. È argomento di discussione infine la capacità difensiva dell’Iran, che ha subito senza dubbio perdite importanti durante la “guerra dei 12 giorni”, ma potrebbe avere ricevuto nei mesi successivi l’assistenza di Russia e Cina in questo ambito.
Al Pentagono c’è probabilmente chi pensa al flop dell’operazione che a inizio 2025 doveva decimare le capacità militari del governo di Ansarallah (Houthis) nello Yemen, dopo che quest’ultimo era intervenuto a sostegno dei palestinesi nella striscia di Gaza. La macchina militare americana non era riuscita a sconfiggere un nemico dotato di un arsenale relativamente modesto, costringendo la Casa Bianca ad annunciare una tregua fingendo di avere raggiunto i propri obiettivi. Si può di conseguenza immaginare quali siano i rischi di un attacco contro un paese come l’Iran. Nella migliore delle ipotesi per Washington, gli analisti ipotizzano una capacità offensiva, o di difesa contro la risposta iraniana, che rischia di essere seriamente compromessa dopo non più di un paio di settimane di operazioni militari.
Nonostante queste incognite, i piani di USA e Israele hanno una loro logica interna che spinge per un confronto militare con l’Iran ed esclude un accordo onesto che produca in teoria benefici per entrambe le parti in un contesto di stabilità regionale. Per questa ragione, la tesi offerta da alcuni media in questi giorni di un Netanyahu preoccupato per la possibilità che Trump raggiunga un’intesa con Teheran limitata alla questione del nucleare non sembra avere fondamento. Washington e Tel Aviv condividono la stessa visione egemonica che non prevede l’esistenza dell’Iran come elemento di disturbo o, peggio ancora, come snodo dell’influenza russo-cinese in Medio Oriente oppure di un’asse della Resistenza irriducibilmente ostile ai loro progetti.
 Trump, come Netanyahu, si ritrova piuttosto a valutare tutte le variabili e i pericoli di un’avventura militare che non assomiglierebbe a nessuna delle aggressioni lanciate dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Anche perché avrebbe effetti devastanti sull’economia globale, ma anche per molti alleati arabi nella regione che, non a caso, stanno facendo pressioni sulla Casa Bianca affinché si astenga dall’attaccare l’Iran. Che una decisione arrivi a breve o venga nuovamente rinviata, il risultato finale non può essere che una guerra totale.
Trump, come Netanyahu, si ritrova piuttosto a valutare tutte le variabili e i pericoli di un’avventura militare che non assomiglierebbe a nessuna delle aggressioni lanciate dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Anche perché avrebbe effetti devastanti sull’economia globale, ma anche per molti alleati arabi nella regione che, non a caso, stanno facendo pressioni sulla Casa Bianca affinché si astenga dall’attaccare l’Iran. Che una decisione arrivi a breve o venga nuovamente rinviata, il risultato finale non può essere che una guerra totale.
La scelta è tutta nelle mani di Washington. Per la Repubblica Islamica, d’altra parte, accettare le condizioni che le vengono imposte si tradurrebbe nella rinuncia alle possibilità di difesa e, in sostanza, nell’accettazione dello status di semi-colonia dei suoi nemici storici.