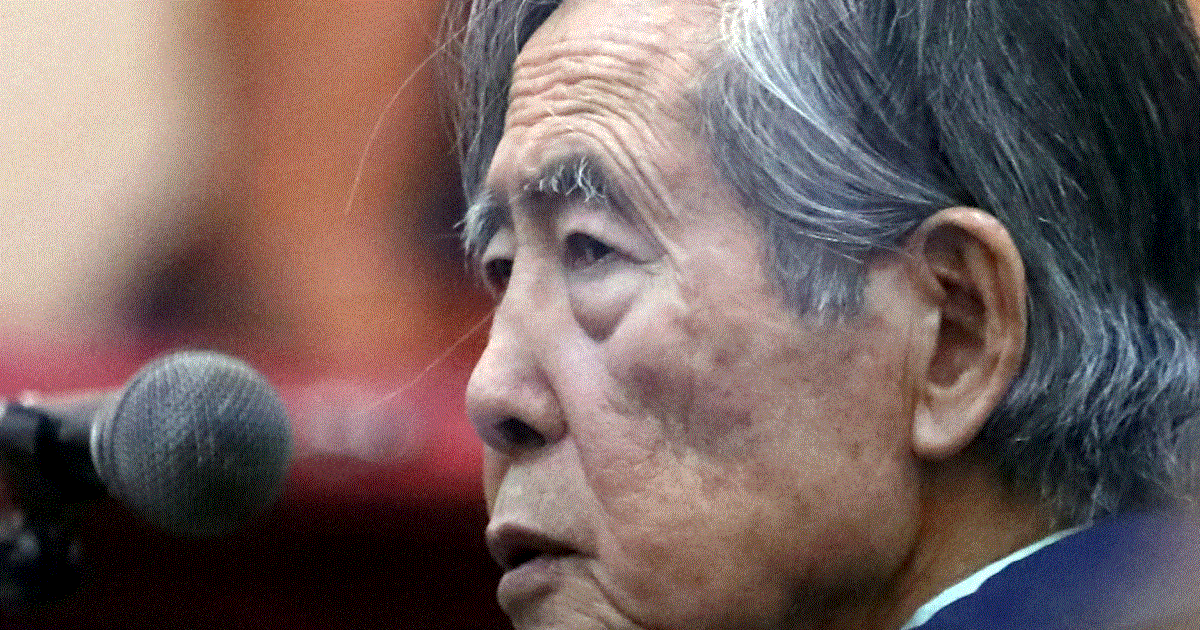Ritorno a Gaza
 Per quanto gli accordi firmati siano al centro di negoziati che dureranno ancora qualche giorno, il primo, fondamentale passo di quella che è soprattutto un accordo per il cessate il fuoco israeliano su Gaza, ha avuto inizio. E anche se il ritorno dei gazawi in quel che resta della loro città prosegue, gli accordi restano privi di prospettiva storica e di credibilità politica: rimangono il risultato di un negoziato che ha messo fine al bombardamento ed all’esilio forzato dei palestinesi dalla loro terra, ma scambiarli per un progetto di pacificazione sarebbe un errore madornale.
Per quanto gli accordi firmati siano al centro di negoziati che dureranno ancora qualche giorno, il primo, fondamentale passo di quella che è soprattutto un accordo per il cessate il fuoco israeliano su Gaza, ha avuto inizio. E anche se il ritorno dei gazawi in quel che resta della loro città prosegue, gli accordi restano privi di prospettiva storica e di credibilità politica: rimangono il risultato di un negoziato che ha messo fine al bombardamento ed all’esilio forzato dei palestinesi dalla loro terra, ma scambiarli per un progetto di pacificazione sarebbe un errore madornale.
Il principale problema è quello del rilascio di alcuni prigionieri palestinesi che Israele non vuole liberare. Tra questi, il più importante è Marwan Barghouti, detto “il Mandela palestinese”, la figura di maggiore spicco all’interno di Fatah e l’unico che potrebbe riunificare politicamente i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Israele lo tiene imprigionato da oltre 20 anni e gli ha comminato 5 ergastoli. Motivo? Avrebbe coordinato attacchi durante la seconda Intifada. Lui si è detto incolpevole ma non ha riconosciuto la legittimità del tribunale israeliano a giudicarlo.
Sulla sua vicenda, quella di un prigioniero politico a tutti gli effetti, emerge l’ipocrisia israeliana, che finge di preoccuparsi di Hamas ma poi ostacola la ripresa dell’ANP che avverrebbe anche a danno della stessa Hamas. C’è infatti chi sostiene che Hamas, da parte sua, essendo Barghouti un uomo della ANP, non farà di tutto per liberarlo. Ma sono speculazioni con poco senso se non quello di provocare maggiori frazioni nel mondo palestinese. La verità è che Barghouti resta in carcere proprio perché non sono riusciti a piegarlo, perchè Israele ne teme la personalità ed il ruolo di leadership che occuperebbe riconosciuto da tutti immediatamente.
Ci sono del resto ampi e diffusi dubbi circa il mantenimento israeliano degli accordi: Israele ha dovuto accettare una limitazione della sua operazione di colonizzazione di tutto il Medio Oriente e sa che difficilmente si ripresenterà un contesto interno ed internazionale così favorevole. Rispetterà quanto firmato? Nonostante gli accordi siano punitivi e senza senso per i palestinesi, la storia ha insegnato che la volontà israeliana di estirparli dal Medio Oriente è di gran lunga superiore alla credibilità delle sue firme e molti si chiedono cosa succederà una volta che anche l’ultimo ostaggio di Hamas sia tornato a casa, vivo o morto che sia. Al momento si spera che tutto vada come stabilito; la parte migliore dell’accordo è la fine dei bombardamenti massicci sulla popolazione (anche se Israele non perde occasione per uccidere) e il ritorno sulla sua terra.
La prima fase, quella della normalizzazione al cessare degli attacchi israeliani prevede un ritorno graduale alla normalità che avrà inizio con la smilitarizzazione in contemporanea alla ritirata delle truppe israeliane dalla striscia. Regole di ingaggio e dettagli sono al centro dei colloqui ma serviranno ricognizioni e molta abilità vista la propensione generale a mettere paletti.
 La Casa Bianca avrebbe ottenuto l’assenso di alcuni Stati-chiave, pronti a fornire i loro soldati. Ovviamente alcuni sono meglio di altri visti da parte dei palestinesi, che pure sanno, alla fine, di essere soli e di poter contare solo su se stessi. L’Egitto è comunque uno dei pochi paesi il cui operare non viene percepito come ostile: ha partecipato alla trattativa, confina con la Striscia, la sua intelligence ha entrature a Gaza e in Cisgiordania; ricopre un ruolo storico per antichi legami e per l’importanza strategica.
La Casa Bianca avrebbe ottenuto l’assenso di alcuni Stati-chiave, pronti a fornire i loro soldati. Ovviamente alcuni sono meglio di altri visti da parte dei palestinesi, che pure sanno, alla fine, di essere soli e di poter contare solo su se stessi. L’Egitto è comunque uno dei pochi paesi il cui operare non viene percepito come ostile: ha partecipato alla trattativa, confina con la Striscia, la sua intelligence ha entrature a Gaza e in Cisgiordania; ricopre un ruolo storico per antichi legami e per l’importanza strategica.
Anche il Qatar, dati i rapporti diretti con Hamas e il ruolo di mediazione svolto in questi anni è un Paese che i palestinesi non temono: ospita i capi di Hamas ed è pronto ad intervenire finanziariamente anche al di fuori di quanto stanziato per gli accordi.
Un discorso simile riguarda la Turchia: Erdogan è l’altra sponda per il movimento palestinese, ambisce ad estendere la sua influenza dalla Siria alla Libia, è stato importante nelle ultime fasi della trattativa, i suoi 007 operano con grande efficacia nell’area e l’inimicizia con Israele, caratterizzatasi anche da scontri verbali aperti in questi anni, in qualche modo rassicura Gaza circa le reali intenzioni del Califfo di Istambul.
Già il primo step del piano non sarà semplicissimo. Stando a quanto previsto dagli accordi, Hamas dovrà riconsegnare le armi. Certo non sarà semplice intendersi su quali armi, dato che Israele sogna di requisire persino le fionde ma nessuno può chiedere ad una entità governativa (tale è Hamas) o comunque a una organizzazione politica sotto occupazione militare straniera, di disarmarsi completamente mentre tutti sparano su di lei. Ragionevolmente una mediazione potrà avere luogo sul livello dell’armamento. Se ne occuperanno con tutta probabilità gli egiziani.
Il dispiegamento della struttura militare d’interposizione vedrà subito subito una task force, composta da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. Poi, nel giro di 6 settimane scenderà in campo una forza di stabilizzazione più corposa. Le prime unità arabe avranno un compito prioritario: collaborare al recupero dei corpi degli ostaggi israeliani, rimuovendo le macerie di palazzi e tunnel bombardati che impediscono di raggiungere le loro prigioni. Ma si dovranno occupare anche di proteggere la distribuzione degli aiuti, un elemento determinante per restituire la speranza ai palestinesi.
La seconda fase della missione – che potrebbe partire entro metà novembre – sarà la più dura: a Gaza è stato distrutto tutto e ovunque sono seminati ordigni. Vanno ricostruite rete idrica, elettrica, telefonica, stradale e, almeno inizialmente, toccherà ai reparti di genieri farsene carico. Servirà assistenza medica, con ospedali da campo. E anche riportare la sicurezza minacciata dalle irruzioni israeliane.
L’articolo 6 dell’intesa prevede che le nazioni del grande contingente dovranno essere accettate da Hamas e dallo Stato ebraico. Si cerca di coinvolgere paesi arabi o comunque musulmani come Marocco, Giordania, Azerbaijan, Indonesia, Bangladesh. Soltanto l’Egitto può però schierare forze qualificate ed esperte, con il vantaggio di essere confinante. Probabile dunque che sarà Il Cairo ad addossarsi il ruolo centrale.
Com’è consuetudine e in questo caso inevitabile, riportare la vita in quel cratere di morte e distruzione non potrà non vedere uno o più progetti di ricostruzione. Ciò, va detto, è garanzia sì di affari per le aziende che otterranno gli appalti ma in qualche modo rappresenta anche una conferma al ritorno dei gazawi. La ricostruzione di Gaza con i suoi miliardi di dollari di lavori e quasi 200 mila edifici da rifare, si annuncia esattamente così: il più grande cantiere del Medio Oriente.
Uno studio radar satellitare di giugno 2025 parla di 191mila edifici danneggiati o ridotti in briciole, tre quinti del patrimonio urbano della Striscia. Le macerie stimate superano i 40 milioni di tonnellate e la loro rimozione potrebbe richiedere più di dieci anni e secondo l’Oms serviranno oltre 7 miliardi per rimettere in piedi i servizi sanitari. Per la conta dettagliata dei danni materiali tra abitazioni rase al suolo, reti idriche ed elettriche inservibili, scuole e ospedali distrutti, strade e infrastrutture distrutte, vanno aggiunti almeno altri 30 miliardi di Dollari.
Le stime aggiornate della Banca Mondiale indicano in 80 miliardi di dollari la cifra approssimativa per la ricostruzione parziale di Gaza, cifra pari a quattro volte il PIL combinato di Cisgiordania e Striscia di Gaza nel 2022.
 Già a inizio marzo la Lega Araba aveva abbozzato il Gaza Reconstruction Plan, finanziato da Qatar, Emirati, Arabia Saudita ed Egitto, sotto il coordinamento della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite. I gruppi dell’area Mena, che comprende il Medio Oriente e il Nord Africa, si stanno posizionando per i futuri bandi multilaterali: egiziani, libanesi e qatarioti e turchi figurano già nei dossier preliminari della Lega Araba. Arrivano correndo partner per opere infrastrutturali finanziate dai fondi arabi e multilaterali.
Già a inizio marzo la Lega Araba aveva abbozzato il Gaza Reconstruction Plan, finanziato da Qatar, Emirati, Arabia Saudita ed Egitto, sotto il coordinamento della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite. I gruppi dell’area Mena, che comprende il Medio Oriente e il Nord Africa, si stanno posizionando per i futuri bandi multilaterali: egiziani, libanesi e qatarioti e turchi figurano già nei dossier preliminari della Lega Araba. Arrivano correndo partner per opere infrastrutturali finanziate dai fondi arabi e multilaterali.
Ovviamente dove si profilano affari e profitti Washington non perde l’occasione e la regia della Casa Bianca negli accordi di pace garantisce un ruolo alle aziende Usa per i progetti infrastrutturali, come reti idriche e sanitarie. Idem il Regno Unito, che figura tra gli advisor tecnici.
Alla fine la storia si ripete: dalle guerre i grandi gruppi finanziari angloamericani continuano a guadagnare quando scoppiano – con le armi – e quando finiscono – con la ricostruzione. Si conferma il mantra del capitalismo, che non ha amici o nemici, solo interessi. Visto dai loro portafogli, finché c’è guerra c’è speranza.