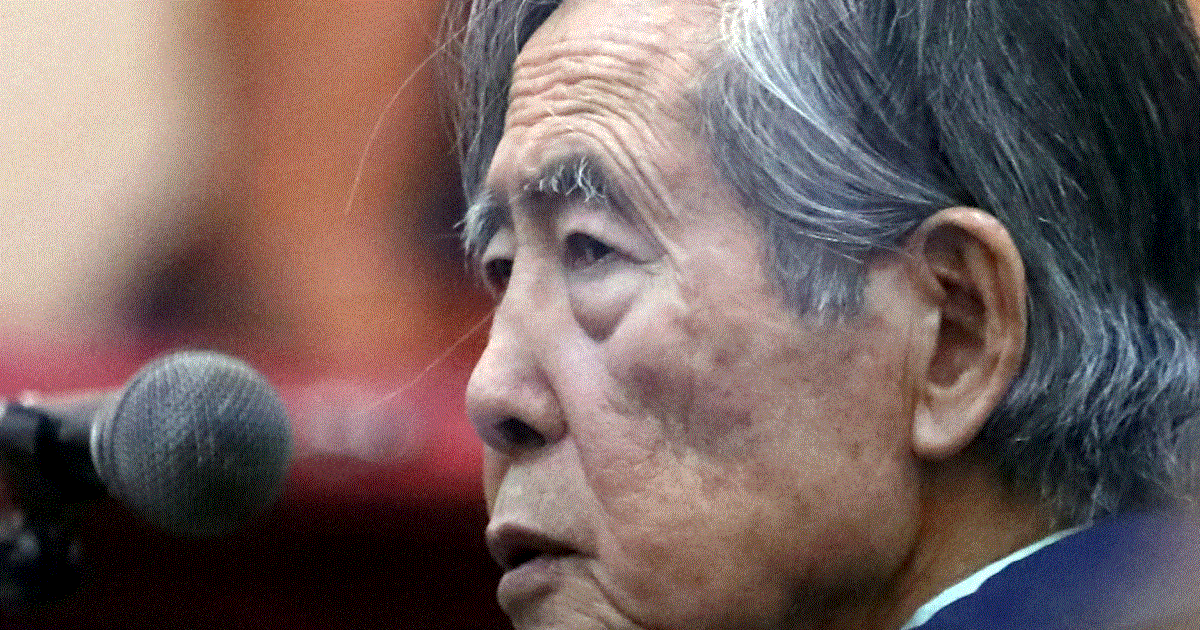Trump e la strategia del caos
 Il presidente americano Trump continua a parlare a ruota libera dei preparativi di un attacco militare contro l’Iran come se quella allo studio fosse un’operazione, oltre che legittima e rispettosa del diritto internazionale o della Costituzione degli Stati Uniti, facilmente gestibile e in grado di innescare i cambiamenti desiderati da Washington – e Tel Aviv – nel paese mediorientale. Quello che si prospetta, in caso di aggressione e nella peggiore delle ipotesi, è piuttosto uno scenario apocalittico che minaccia di ripercuotersi su tutta la regione e non solo, con conseguenze difficili da prevedere e quantificare. È improbabile che gli “strateghi”, per così dire, della Casa Bianca e del Pentagono abbiano trascurato questi fattori nella preparazione di piani operativi che, a ben vedere, non rispondono soltanto al delirio egomaniaco del presidente. Anzi, davanti al fallimento delle operazioni di cambio di regime a Teheran, è possibile che l’obiettivo sia precisamente il caos totale e l’implosione violenta dello stato iraniano.
Il presidente americano Trump continua a parlare a ruota libera dei preparativi di un attacco militare contro l’Iran come se quella allo studio fosse un’operazione, oltre che legittima e rispettosa del diritto internazionale o della Costituzione degli Stati Uniti, facilmente gestibile e in grado di innescare i cambiamenti desiderati da Washington – e Tel Aviv – nel paese mediorientale. Quello che si prospetta, in caso di aggressione e nella peggiore delle ipotesi, è piuttosto uno scenario apocalittico che minaccia di ripercuotersi su tutta la regione e non solo, con conseguenze difficili da prevedere e quantificare. È improbabile che gli “strateghi”, per così dire, della Casa Bianca e del Pentagono abbiano trascurato questi fattori nella preparazione di piani operativi che, a ben vedere, non rispondono soltanto al delirio egomaniaco del presidente. Anzi, davanti al fallimento delle operazioni di cambio di regime a Teheran, è possibile che l’obiettivo sia precisamente il caos totale e l’implosione violenta dello stato iraniano.
L’analista iraniano Mahdi Motlagh, in un articolo per il sito Antiwar, ha riassunto la questione con l’avvertimento che “l’Iran non è la Libia”, dove nel 2011 la NATO orchestrò la caduta di Gheddafi senza un piano percorribile per sostituirlo e, nonostante il paese nordafricano fosse poi precipitato in una crisi fuori controllo, non ci furono conseguenze troppo gravi al di fuori dei suoi confini o, per meglio dire, al di là della regione sub-sahariana. Che non ci sia una soluzione alternativa al sistema statale odierno in Iran è apparso chiaro ancora una volta dopo l’ennesimo insuccesso del movimento di protesta manovrato dalla CIA e dal Mossad, represso in maniera definitiva dalle forze di sicurezza solo pochi giorni fa. Anche il tentativo di promuovere come possibile nuovo leader politico una figura ultra-screditata come Reza Pahlavi, senza nessun seguito in Iran, dimostra l’assenza di opzioni in questo senso per USA e Israele.
Tornando al confronto con la vicenda libica, la destabilizzazione attraverso la forza militare di un paese di 90 milioni di abitanti, con un eccezionale retaggio storico-culturale, situato in una posizione geostrategica cruciale e al centro di una rete di alleanze che costituiscono il fulcro delle dinamiche multipolari, avrebbe effetti difficilmente contenibili. Su questa realtà hanno richiamato l’attenzione varie personalità di governo iraniane. Il presidente Pezeshkian, dopo un colloquio telefonico col principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ha spiegato che le minacce americane puntano a “minare la sicurezza della regione” e “non porteranno altro che instabilità”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, in una conferenza stampa tenuta martedì ha avvertito a sua volta che le conseguenze di un attacco militare contro l’Iran “avranno effetti sull’intera regione”. Il venir meno degli equilibri di sicurezza, ha aggiunto Baghaei, comporta dinamiche “contagiose”.
Per cominciare, il governo iraniano ha un ventaglio di strumenti sia per rispondere all’aggressione americana sia per allargare il conflitto come minimo a tutto il Medio Oriente. Il primo è quello prettamente militare. Teheran ha chiarito che intende superare l’attitudine improntata alla cosiddetta “pazienza strategica”, ovvero una ritorsione calibrata volta sostanzialmente ad evitare pericolose escalation. Già con questo atteggiamento relativamente prudente, nella “guerra dei 12 giorni” con USA e Israele del giugno scorso l’Iran aveva causato seri danni allo stato ebraico e colpito la gigantesca base americana di Al Udeid in Qatar, ancorché con un’azione in larga misura simbolica. In questo caso, il meccanismo di auto-limitazione verrebbe messo da parte, per passare alla guerra totale.
Ci sono evidentemente incertezze sulla natura dell’arsenale a disposizione della Repubblica Islamica e le sue capacità offensive, ma la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che le basi americane nella regione e il territorio di Israele possano essere seriamente esposti. In questa prospettiva, l’arrivo in Medio Oriente di svariati “asset” da guerra americani, come la portaerei Lincoln, aumenta la potenza di fuoco ma moltiplica anche gli obiettivi per i missili iraniani. Inoltre, e anche in questo caso gli avvertimenti di Teheran sono stati molto chiari, i paesi arabi che metteranno a disposizione il loro spazio aereo o le loro basi per gli attacchi USA saranno anch’essi oggetto di bombardamenti.
La Repubblica Islamica potrebbe anche avere sensibilmente rafforzato le sue dotazioni difensive con il contributo di Russia e Cina dopo l’aggressione subita lo scorso anno. La testata russa Vzglyad, vicina all’apparato di sicurezza del Cremlino, in una recente analisi ha espresso qualche perplessità sui mezzi di contrattacco a disposizione dell’Iran, ma ha al contempo evidenziato i rischi dell’operazione americana, per lo meno in assenza di un “asso nella manica” che permetta di “infliggere danni decisivi”.
 Trump ha celebrato martedì il dispiegamento di una “grande armata” americana nel Golfo Persico, ma la solita ostentazione di potenza si è accompagnata significativamente a una qualche apertura alla trattativa diplomatica. Il presidente americano ha sostenuto che l’Iran “vuole discutere” e “arrivare a un accordo”. Questa caratterizzazione dello stato dei rapporti con Teheran è con ogni probabilità falsa, anche perché la leadership iraniana sa benissimo che i negoziati con Washington sono totalmente inutili. Quello che le parole di Trump rivelano è piuttosto l’apprensione che circola nella sua amministrazione e ai vertici delle forze armate per un’avventura bellica potenzialmente rovinosa.
Trump ha celebrato martedì il dispiegamento di una “grande armata” americana nel Golfo Persico, ma la solita ostentazione di potenza si è accompagnata significativamente a una qualche apertura alla trattativa diplomatica. Il presidente americano ha sostenuto che l’Iran “vuole discutere” e “arrivare a un accordo”. Questa caratterizzazione dello stato dei rapporti con Teheran è con ogni probabilità falsa, anche perché la leadership iraniana sa benissimo che i negoziati con Washington sono totalmente inutili. Quello che le parole di Trump rivelano è piuttosto l’apprensione che circola nella sua amministrazione e ai vertici delle forze armate per un’avventura bellica potenzialmente rovinosa.
Da considerare c’è anche il fatto che le forze extra-statali dell’Asse della Resistenza allineate all’Iran nella regione sembrano essersi mobilitate in queste settimane per prendere parte alla guerra che si sta preparando. Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Iraq e il governo di Ansarallah (“Houthis”) nello Yemen hanno già fatto sapere che, a differenza della passività del giugno 2025, parteciperanno attivamente allo scontro, creando fronti multipli e imprevedibili del conflitto che USA e Israele intendono scatenare.
L’opzione più radicale a disposizione di Teheran e dalle implicazioni più gravi è in ogni caso la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui transita, secondo alcune stime, non meno del 20% del petrolio commerciato a livello globale. Un’iniziativa che penalizzerebbe la stessa Repubblica Islamica, ma che avrebbe soprattutto pesantissime ripercussioni sull’economia internazionale, facendo schizzare il prezzo del greggio anche negli Stati Uniti a meno di un anno dalle elezioni di metà mandato. A ciò si devono aggiungere i possibili bombardamenti che l’Iran effettuerebbe contro le infrastrutture petrolifere dei regimi del Golfo.
Proprio su questa prospettiva hanno riflettuto paesi come Arabia Saudita ed Emirati Arabi, i cui leader si sono espressi pubblicamente nei giorni scorsi sulla crisi, assicurando che entrambi non concederanno i propri spazi aerei ai caccia americani e israeliani durante un eventuale attacco contro l’Iran. Riyadh, in particolare, oltre a valutare con angoscia gli effetti di una ritorsione iraniana, vede correttamente nella destabilizzazione del vicino l’implementazione di un piano strategico che intende favorire la supremazia israeliana in Medio Oriente. Piano che metterebbe irrimediabilmente l’Arabia Saudita su un livello subalterno rispetto agli interessi di Tel Aviv.
In vista ci sono quindi conseguenze disastrose se dovesse esplodere una guerra che, come spiegato, non si evolverebbe nei limiti di quella dei “12 giorni” del giugno dello scorso anno. Gli Stati Uniti hanno senza dubbio considerato tutte le possibilità e ritengono molto probabilmente anch’essi, al di là della retorica trumpiana, che la nuova avventura militare rischia seriamente di produrre una situazione di caos tale da superare di gran lunga quella registrata dopo l’invasione dell’Iraq nel 2003.
L’analisi di Mahdi Motlagh citata all’inizio sostiene a un certo punto che, “da una prospettiva puramente Realista, il costo della difficile coesistenza con l’Iran è molto inferiore rispetto al costo derivante dalla gestione di una vasta area di instabilità non governabile nel cuore dell’Eurasia”. Questa considerazione è ineccepibile nel quadro di una valutazione razionale – e anche moralmente accettabile – dei rapporti tra stati in condizioni storiche “normali”. Il caso non si applica tuttavia agli Stati Uniti odierni in piena crisi, in quanto la gestione di una relazione conflittuale con un paese rivale non rientra nelle opzioni valutabili, perché in ultima analisi implica, per quest’ultimo, un livello di sovranità e libertà di azione semplicemente inaccettabile per una superpotenza la cui posizione di supremazia a livello internazionale si sta logorando in fretta.
Messa in un’altra prospettiva, la questione è che l’impossibilità di rovesciare l’attuale regime in Iran e di installare un governo-fantoccio che si allinei agli interessi americani e sionisti in Medio Oriente, così da rompere il legame con Russia e Cina “nel cuore dell’Eurasia”, lascia come unica alternativa la destabilizzazione e il caos puro e semplice. Forzare l’implosione del paese con la forza militare, favorendone la disgregazione se non la totale distruzione come entità unitaria e sovrana, è il modo, peraltro già sperimentato in Libia e in Siria, per impedire il consolidarsi di un centro di potere alternativo in un’area strategicamente cruciale del globo e a cui può guardare con fiducia il “Sud Globale” dopo la fine dell’era unipolare.
 Precisamente per questa ragione, Trump insiste nello spingere gli Stati Uniti verso una guerra che sa benissimo essere molto rischiosa e con conseguenze pesantissime in termini di vittime e distruzione. Che poi la scommessa della Casa Bianca possa portare a risultati imprevisti, sia per il grado di resistenza che l’Iran e gli alleati sapranno opporre sia per l’eventuale contributo che Mosca e Pechino daranno a Teheran, non è da escludere, ma, a giudicare dagli sviluppi di questi giorni, Trump e il suo partner nel crimine Netanyahu sembrano intenzionati a scoprirlo una volta per tutte.
Precisamente per questa ragione, Trump insiste nello spingere gli Stati Uniti verso una guerra che sa benissimo essere molto rischiosa e con conseguenze pesantissime in termini di vittime e distruzione. Che poi la scommessa della Casa Bianca possa portare a risultati imprevisti, sia per il grado di resistenza che l’Iran e gli alleati sapranno opporre sia per l’eventuale contributo che Mosca e Pechino daranno a Teheran, non è da escludere, ma, a giudicare dagli sviluppi di questi giorni, Trump e il suo partner nel crimine Netanyahu sembrano intenzionati a scoprirlo una volta per tutte.