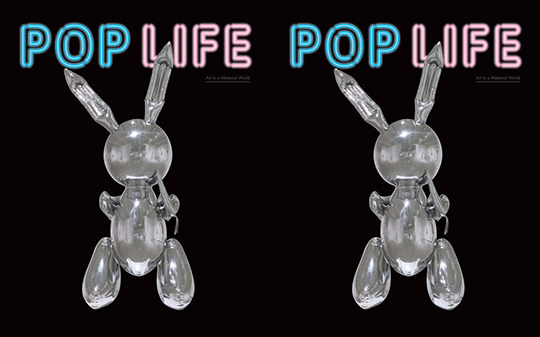 di Mario Braconi
di Mario Braconi
Il primo di ottobre si è aperta alla Tate Modern di Londra la mostra “Pop Life, Art in a Material World”, dove vengono esposti lavori di Keith Haring, Takashi Murakami, Richard Prince, Jeff Koons, oltre agli inevitabili Maurizio Cattelan e Damien Hirst. Tutti artisti il cui lavoro può essere ricondotto alla corrente artistica nota come Arte Pop, movimento culturale sviluppatosi in Gran Bretagna negli anni Sessanta. Non “arte popolare”, ma “arte di massa” - arte che cessa di essere appannaggio di un esiguo numero di eletti estenuati da intellettualistiche elucubrazioni e va per le strade, nei negozi e nei supermercati, entra dentro i cinema, guarda la televisione, legge i quotidiani e perfino i fumetti, per poi vomitare sui suoi fruitori, a loro volta massa, la sua esecrazione per la società dei consumi.
Già il titolo dell’esibizione di Londra è tutto un programma: cita il cantante Prince (Pop Life) ed echeggia un pezzo dei Police (Spirits in a Material World, 1981). Secondo i canoni della Pop Art, anche l’opera d’arte è merce, prodotto, ha un valore commerciale, può essere riprodotta in serie. E qui sta il paradosso di un movimento culturale che, nel tentativo di stigmatizzare una società malata, finisce per cadere nei suoi stessi perversi meccanismi. Da questo punto di vista, la carriera di Takashi Murakami è paradigmatica: nel suo paese, il Giappone, è titolare di una società multinazionale che produce in serie le sue “opere”, anzi si può ben dire che il suo studio contiene una vera e propria catena di montaggio. Tra le tante realizzazioni di Murakami, forse la più curiosa è l’opera di massa “Murakami SUPERFLATMUSEUM” (o Museo Ultrapiatto Murakami): 300.000 riproduzioni in miniatura di dieci lavori di Murakami, incluse come “sorpresa” nelle confezioni di gomme da masticare. Tanto per ribadire che Murakami è un buon manager, ricordiamo che ha collaborato con il marchio francese LVMH reinterpretando il celeberrimo logo LV. Andy Warhol ne sarebbe stato fiero.
Gli organizzatori della mostra sembrano aver chiara l’imbarazzante situazione dei Pop-artisti che potrebbe essere riassunta dal latino: “Grecia capta ferum victorem vicit” - ovvero la società dei consumi e del denaro facile che nasconde il vuoto pneumatico ha conquistato anche i paladini che dicevano di volerla sbeffeggiare. Uno degli artisti che espongono alla Tate Modern, tanto per dire, (si dice Damien Hirst), indispettito dal fatto che per anni la mostra fosse stata intitolata “Sold Out” (tutto venduto / tutti venduti), ha preteso che esso fosse cambiato in quello attuale. Del resto, e non caso, uno degli striscioni all’interno dello spazio espositivo recita: “Good Business is the best Art” (Un business fiorente è la miglior forma di arte) - frammento di una frase di Andy Wahrol (“Fare soldi è arte, lavorare è arte, e un business fiorente è la miglior forma d’arte”). Forse che le prime due frasi sono state censurate per decenza, visto quanto guadagnano gli artisti rappresentati e il modesto sforzo che devono fare per fabbricare le loro opere?
Tra le opere presenti a Pop Life c’è Hiropon (termine slang per “eroina”, la droga, non l’eroe di sesso femminile) del 1997 del citato Murakami: una bambola alta oltre due metri che rappresenta una ragazza sorridente con occhi enormi e capelli rosa raccolti di due codini, un seno immenso, grottesco, a malapena tenuto sotto controllo dal top di un bikini ridicolmente ridotto, che è poi il suo unico indumento. La ragazza è immortalata nell’atto di strizzarsi i grossi capezzoli a forma di pene, dai quali esce un liquido lattescente che disegna una figura circolare che l’abbraccia. Nel suo complesso l’impressione è quella figurina saltata fuori direttamente da un anime (o meglio da un hentai) per venire nel mondo reale a saltare la corda. Un lavoro che, attraverso un nutrito gruppo di clichet (la forma fisica estrema, la sessualizzazione paradossale, l’ambivalenza di genere) è quasi un compendio delle perversioni sessuali maschili. Verrebbe da dire: tutto qui?
E che dire di uno dei pezzi della serie “Made in Heaven” (1989) di Jeff Koons, cui è dedicata un’intera sala della mostra? Al centro, un tableau a tre dimensioni che riproduce, a dimensioni naturali, Koons e l’ex moglie Ilona Staller (in arte Cicciolina) impegnati in un rapporto sessuale. Alle pareti figurano serigrafie del pene di Koons opportunamente masterizzato digitalmente, e una originale stampa di stampo schiettamente pornografico che ritrae l’ano di Cicciolina. Anche qui, quando si chiede all’artista che cosa esattamente desiderava rappresentare, si ottengono salve di luoghi comuni: “Ho visto l’affresco di Masaccio che rappresenta la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso nella Cappella Brancacci a Firenze e sono rimasto molto colpito. Si vede la colpa e la vergogna che quei due provano. Anche io volevo creare un’opera sulla Caduta, me senza colpa né vergogna”. Forse di colpa e vergogna non ve ne sono, in “Made in Heaven”, ma di furbizia c’é abbondanza...
Il gusto per la provocazione facile si ritrova anche nell’opera “Spiritual America” di Richard Prince, che ha deciso di ristampare una vecchia foto di Brooke Shields ritratta in una sconvolgente posa pedopornografica all’età di 10 anni: certo; riconosciamo che la sua pubblicazione può avere un valore storico e suscitare anche il giusto raccapriccio per quello che è stato fatto all’infanzia della bellissima modella ed attrice americana. Benché la rimozione dell’opera, avvenuta per iniziativa di Scotland Yard il giorno prima dell’apertura della mostra, non sia condivisibile, resta il fatto che non è ancora chiaro se dobbiamo annoverare i Richard Prince tra i testimoni o tra i complici della oscena sessualizzazione di una bambina.
La provocazione a basso costo ricorre anche nel lavoro di Cattelan, consistente in un cavallo imbalsamato sdraiato al suolo con un palo conficcato in un fianco, dove si legge “INRI” (cioè, Gesù Nazareno, Re dei Giudei), la scritta che, secondo la tradizione cristiana, sarebbe stata apposta sulla croce del Redentore. Rimaniamo perplessi, non per la provocazione, che anzi in genere approviamo perché salutare, ma per la pochezza della stessa e per l’immensa arroganza che vi si nasconde dietro.
Questa veloce carrellata lascia un grande vuoto dentro, e anche un pizzico di rabbia (o forse di invidia - non sarebbe riuscito ognuno di noi, con un po’ più di facciatosta fare altrettanto, se non meglio di questi artisti tanto celebrati e soprattutto tanto pagati?). Del resto, come conclude il critico d’arte Adrian Searle, firma del Guardian: “Essere un furbacchione, un genio nelle pubbliche relazioni e aver naso per le opportunità del momento, sono tutte cose buone. Possono certamente aiutare a divenire un artista di successo; ma contribuiscono a fare arte di qualità? Questo è il tipo di domanda cui critici superciliosi rispondono con un’alzata di spalle: esiste solo il successo, dicono; il resto è soggettivo.”