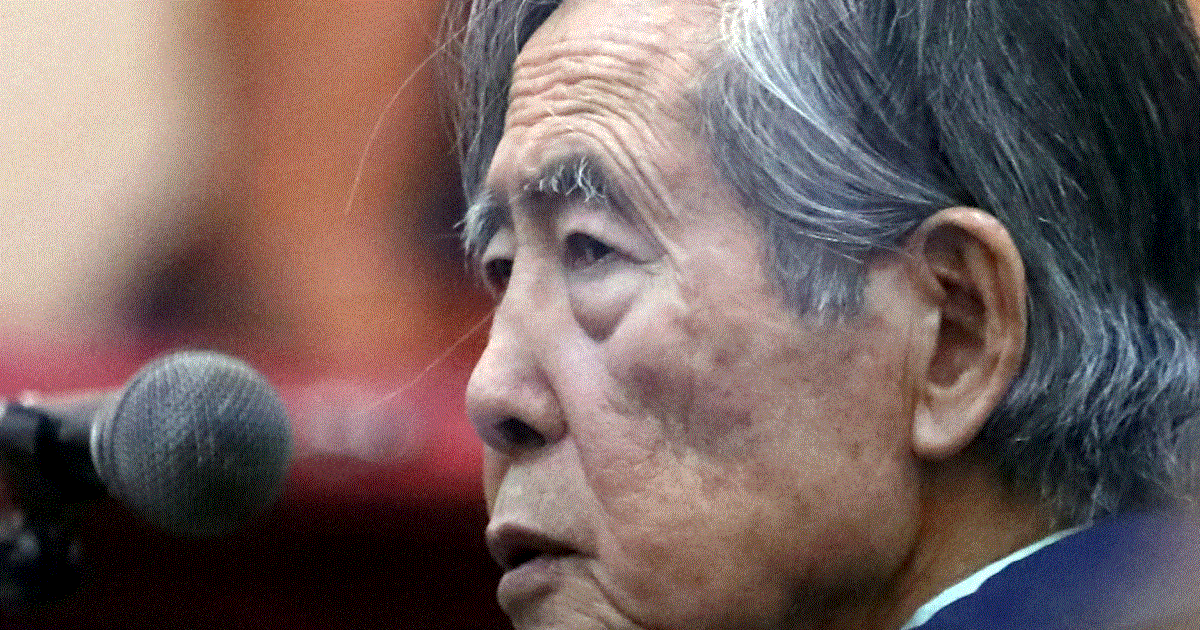USA, il rischio collasso
 Non arrivano buone notizie per l’economia statunitense. Le cronache da trumpilandia recitano negli ultimi cinque giorni minacce al Canada per gli accordi commerciali con la Cina, insulti agli europei (e in particolare agli italiani), minacce a tutti i paesi che commerciano con Cuba, in una mentecatta estensione estraterritoriale della legge Helms-Burton e minacce l’Iran di attacco militare. Lo scenario che si apre su Teheran è complesso anche per gli USA, sanno bene che ciò aprirebbe un conflitto armato le cui ripercussioni sarebbero devastanti anche per l’economia mondiale, visto che lo Stretto di Hormuz, dove transita il 22% del petrolio mondiale, sarebbe il primo obiettivo degli iraniani. Il che farebbe schizzare alle stelle il costo al barile proprio nel momento di massima ascesa dell’oro e di minimo peso del Dollaro.
Non arrivano buone notizie per l’economia statunitense. Le cronache da trumpilandia recitano negli ultimi cinque giorni minacce al Canada per gli accordi commerciali con la Cina, insulti agli europei (e in particolare agli italiani), minacce a tutti i paesi che commerciano con Cuba, in una mentecatta estensione estraterritoriale della legge Helms-Burton e minacce l’Iran di attacco militare. Lo scenario che si apre su Teheran è complesso anche per gli USA, sanno bene che ciò aprirebbe un conflitto armato le cui ripercussioni sarebbero devastanti anche per l’economia mondiale, visto che lo Stretto di Hormuz, dove transita il 22% del petrolio mondiale, sarebbe il primo obiettivo degli iraniani. Il che farebbe schizzare alle stelle il costo al barile proprio nel momento di massima ascesa dell’oro e di minimo peso del Dollaro.
Per quanto Trump affermi che tutto procede in modo meraviglioso, il cambio del Dollaro con l’Euro è sceso a 1,39 ed è difficile sostenere che la responsabilità sia della politica della FED, peraltro ora a guida Warsh. Da ben prima e per motivi strutturali viene la crisi del Dollaro, che alimenta ad amplifica quella dell’economia statunitense. Il problema principale resta quello di un indebitamento spaventoso: gli USA hanno un debito pubblico di 38.400 miliardi di Dollari. Gli interessi annui ammontano a 1600 miliardi di Dollari, 377 mila Dollari al giorno.
I titoli di Stato con i quali gli USA trovano la liquidità per sostenere i conti sono l’unica risorsa e allo stesso tempo un cappio che ogni anno rende più difficile la respirazione dell’economia USA. Lungi dalla riduzione della quota capitale, gli Stati Uniti vedono infatti gli interessi che aumentano regolarmente per effetto di una politica di finanziamento del debito che genera però ogni anno un maggior indebitamento. Perché si emette continuamente debito che dovrà essere pagato con altro debito, peggiorando così i conti e lasciando intravvedere una spirale negativa sulla stessa solvibilità degli USA.
La vendita dei Titoli di Stato, anche quando avviene a interessi minori in virtù di accordi politici, non risolve la caduta della domanda. Sebbene fino a pochi anni fa fossero considerati un porto sicuro per i rendimenti di ogni investimento e come colonna portante del capitalismo finanziario, alla luce dei conti odierni vengono visti con crescente perplessità, in quanto esposti con un debito ormai impagabile a breve e medio termine che li espone matematicamente a un rischio default. Il che non significa che ciò succederà ma nemmeno significa che manchino le condizioni strutturali perché ciò avvenga.
La supremazia produttiva è un ricordo. Gli USA non producono ormai sostanzialmente più nulla dal punto di vista dei manufatti e lo sbilanciamento dell’import-export è il risultato di una concezione folle della politica economica che ha pensato di allocare altrove la produzione industriale per concentrarsi sul primato dell’economia finanziaria. E oggi quel gigante che riempiva di merci l’intero mondo è come se fosse un grande centro commerciale privo di magazzini di deposito e che per vendere ha bisogno prima di importare.
 Va detto che anche importare è divenuto sempre più difficile: da un lato perché la ridotta influenza politica dei 52 paesi che formano l’Occidente Collettivo fa sì che i paesi esportatori a Sud e a Est non siano più disponibili alla svendita dei loro prodotti per favorire la bilancia commerciale statunitense; dall’altro perché lo scambio tra materie prime e tecnologia ha perso rilevanza strategica, stante la fine del dominio tecnologico esclusivo occidentale in generale e statunitense in particolare.
Va detto che anche importare è divenuto sempre più difficile: da un lato perché la ridotta influenza politica dei 52 paesi che formano l’Occidente Collettivo fa sì che i paesi esportatori a Sud e a Est non siano più disponibili alla svendita dei loro prodotti per favorire la bilancia commerciale statunitense; dall’altro perché lo scambio tra materie prime e tecnologia ha perso rilevanza strategica, stante la fine del dominio tecnologico esclusivo occidentale in generale e statunitense in particolare.
Ad aggravare pesantemente il quadro, c’è l’utilizzo delle sanzioni imposte dalle diverse amministrazioni USA negli ultimi 20 anni quale asse centrale delle relazioni commerciali. Oggi sono divenute il peggior boomerang, perchè colpiscono 23 paesi, pari al 73% della popolazione planetaria ed hanno quindi ridotto al solo il 27% della popolazione mondiale la possibilità di scambi. E questo, inevitabilmente, si ripercuote negativamente anche sulle condizioni degli scambi.
Certo Trump non aiuta l’economia favorendo i profitti delle multinazionali a lui vicine con operazioni di autentico insider trading e deprimendo il mercato interno con le sue politiche xenofobe, anche solo considerando che i latinos contribuiscono per il 38,5% imprenditoriale generata dal 2007 al 2025, superando del 7% la creazione di imprese statunitensi.
La supremazia del Dollaro si riduce quotidianamente, e solo nel 2025 il calo è stato dell’otto per cento. Le politiche imperiali e coercitive che utilizzano la divisa come bastone sulla testa di chi non consegna sovranità e risorse, inducono sia tutta l’area BRICS che altri investitori istituzionali ad abbandonare il Dollaro nelle transazioni commerciali. La minore richiesta impoverisce la valuta statunitense e determina un minor valore degli stessi titoli: a fronte di una minore influenza del Dollaro sui mercati si riduce la loro attrattiva e, con essa, si riduce la possibilità di attenuamento del debito anche attraverso un aumento dell’inflazione.
Di fronte a questo quadro la risposta di Trump è stata chiara: l’intero pianeta dovrà preoccuparsi di “collaborare” con gli Usa. E non potendo parlare direttamente di pirateria imperiale, gli USA preferiscono argomentare sostenendo che l’intero pianeta dovrà sostenere l’economia statunitense, con le buone o con le cattive. Perché essendo gli USA riconosciuti come il leader globale, la sostenibilità del sistema capitalistico internazionale non può prescindere dalla salute della loro economia. Tradotto: la crisi presenta profili di insolvibilità, il che è questione di sicurezza nazionale: dunque qualunque mezzo è lecito per convogliare risorse e allineamento politico sulle scelte strategiche statunitensi. La fallacia del discorso è evidente come anche l’impossibilità di trovarvi elementi a suffragio.
La crescita dirompente dell’economia della Cina, il consolidamento della Russia sul piano militare, la crescita del Sud globale e del nuovo Est; la continua affermazione dei modelli di governance regionali nelle diverse aree asiatiche e la rinascita dell’Africa, che prosegue il suo processo di definitiva decolonizzazione ponendo per di più le sue risorse minerarie su un tavolo globale dove esse sono diventate la più appetita delle pietanze; la nascita di organismi finanziari come la Nuova Banca dello Sviluppo dei BRICS e il peso crescente dell’impatto dei paesi associati che tocca il 44% del PIL globale, denotano con assoluta chiarezza la fine di un’epoca e la nascita, seppure ancora confusa in diversi aspetti, di un nuovo mondo desideroso di un Nuovo Ordine Internazionale e che non si poggia sul sistema gerarchico voluto dall’Occidente collettivo che vede 52 paesi dominare sui 142 rimanenti.
s’avanza con costanza l’idea di un mondo basato sui principi della Carta dell’ONU e su un modello di governance multilaterale e condiviso. Un parte significativa di mondo è stanca della destabilizzazione orchestrata dall’Occidente per favorire la destrutturazione delle entità statuali e afferma invece la buona strada della globalizzazione sul piano economico e commerciale. Come si vede ben altro sistema di regole da quello anglosassone imposto a convenienza occidentale.
La via d’uscita degli USA dal loro declino starebbe nella riconversione completa del modello economico, che però potrebbe arrivare solo dall’abbandono di quel teorema ideologico-messianico che gli assegna – a detta loro – la missione di guidare il mondo. Concetto che si ritrova nell’idea di “eccezionalismo” degli Stati Uniti scritto in Costituzione e rivendicato come base teorica del modello unipolare di governance globale.
 Non sarà con la destabilizzazione permanente ai quattro angoli del globo che il mondo s’inginocchierà di fronte a Wall Street, così come non sarà la sua forza militare a determinare il cammino del secolo. La forbice sempre più aperta tra i detentori della ricchezza globale e le aree di sottosviluppo causate dall’accentramento delle risorse, scava una breccia ormai insostenibile e le ambizioni sacrosante di chi supera l’insieme dei paesi del G8 e controlla la metà del PIL del pianeta con tendenza crescente, non sono eludibili con minacce militari. Non perché non siano abbastanza dure ma perché un mondo ridotto ad un cumulo di macerie non servirebbe comunque a nulla e a nessuno.
Non sarà con la destabilizzazione permanente ai quattro angoli del globo che il mondo s’inginocchierà di fronte a Wall Street, così come non sarà la sua forza militare a determinare il cammino del secolo. La forbice sempre più aperta tra i detentori della ricchezza globale e le aree di sottosviluppo causate dall’accentramento delle risorse, scava una breccia ormai insostenibile e le ambizioni sacrosante di chi supera l’insieme dei paesi del G8 e controlla la metà del PIL del pianeta con tendenza crescente, non sono eludibili con minacce militari. Non perché non siano abbastanza dure ma perché un mondo ridotto ad un cumulo di macerie non servirebbe comunque a nulla e a nessuno.
Lo status cinese di primo Paese per scambi commerciali con 138 dei 194 paesi del mondo, la sua economia ormai prossima al superamento di quella statunitense, il cambio di direzione dei capitali internazionali che lasciano il Nord per recarsi a Sud e ad Est, non consentono più una idea del mondo ad immagine e convenienza del capitalismo predatorio angloamericano. Men che mai il ruolo di “modello” etico è sopravvissuto di fonte agli atti di pirateria internazionale, alle aggressioni e al genocidio palestinese: il sistema valoriale del modello occidentale è ormai rigettato in tre quarti del mondo e, ancor prima della fine della superiorità economica, è giunta quella della presunta superiorità etica dell’impero unipolare.
La storia, sia essa lineare o ciclica, insegna sempre. Dopo la fine delle colonie arriva quella delle monarchie e anche quella degli imperi “democratici”, che altro non sono se non la dimensione tecnologica dei primi due. Per longevi che siano, avranno una fine e benché piena di stop and go, essa sarà molto più veloce di quel che s’immagina. La scommessa è ben quotata.